Gli usi del FUTURO in italiano
In questo video esploriamo tutti gli usi del futuro semplice e del futuro composto in italiano, andando oltre il semplice uso temporale.
Scarica il PDF gratuito con il riassunto della lezione
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
Hai paura del futuro? È normale, il futuro fa paura, il futuro è incerto. Ok, ora mi riferisco al futuro in senso esistenziale, ma anche il futuro nella lingua italiana ti può fare paura, perché nasconde alcuni usi che forse non conosci ma che sono davvero importanti per parlare come un italiano. (Ok forse è un po’ tirata come intro, questa). Tra l’altro, come vedremo, anche il futuro come tempo verbale ha a che vedere con l’incertezza.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Parleremo, in questo video, degli usi del futuro dell’italiano e lo faremo partendo da materiali autentici, materiali reali.
E non ci limiteremo a occuparci del futuro semplice, ma ci occuperemo anche del futuro composto (anche chiamato futuro anteriore).
Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara la lingua italiana. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno, e ricorda che la trascrizione integrale si trova sul mio sito, podcastitaliano.com. E poi, come sempre, ho anche preparato un PDF che accompagna il video e ti permetterà di ripassare quello che imparerai oggi e anche di esercitarti: ti consiglio di stamparlo, perché ti tornerà molto utile. Ti lascio il link in descrizione, oppure puoi scansionare questo codice QR a fianco alla mia testa.
Partiamo dal primo testo, un articolo che annuncia il rincaro degli alloggi a Cortina a causa delle Olimpiadi invernali del 2026. Il titolo recita infatti:
Ecco quanto costerà dormire a Cortina durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Il titolo contiene già un verbo al futuro, costerà. Lo stesso tempo verbale ritorna più volte in questo brano del testo:
E intanto la località di montagna è già un cantiere, con ben nove grandi alberghi in ristrutturazione o addirittura ricostruiti […]. L’antico Ampezzo, palazzo signorile ottocentesco, languiva abbandonato in pieno centro storico. Qui, l'80% della viabilità recupererà un disegno e la zona tornerà a vivere a pieno regime. Ma pare che la maggior parte degli hotel, […] non sarà pronta per l'evento sportivo. Per questo motivo, gli affitti a breve termine degli appartamenti privati schizzeranno alle stelle […]
Costerà, recupererà, sarà, schizzeranno sono tutti esempi di verbi al futuro. Ancora più nello specifico, di verbi al futuro nel suo uso temporale: per collocare, cioè, l’evento (o gli eventi), sulla linea del tempo, in un momento posteriore a quello in cui avviene la comunicazione; in questo caso, posteriore al momento in cui l’autore scrive l’articolo. Fin qui tutto semplice, vero? Nulla di sconvolgente.
Parentesi: ti invito a fare con me una considerazione. In italiano esiste almeno un altro tempo verbale che usiamo spesso per parlare di eventi che si collocano temporalmente dopo il momento della comunicazione. Ed è l’indicativo presente. Quando diciamo:
- Domani mi sveglio presto.
- Tra una settimana comincia la scuola.
- L’anno prossimo vado all’università.
Ecco, in tutti questi casi, sto parlando di eventi posteriori al momento in cui ne sto parlando, e ne sto parlando al presente. Dunque, il presente può essere usato sia per parlare di eventi contemporanei al momento in cui parlo (o scrivo), sia per parlare di eventi successivi. Nella lingua parlata questo avviene molto di frequente, ma oggi non te ne parlo perché ne ho già parlato in questo video.
Questo è un principio generale da ricordare: uno stesso tempo verbale può essere usato per esprimere eventi che si collocano in diversi tempi della realtà, e inoltre uno stesso tempo della realtà può essere espresso mediante diversi tempi verbali. Il tempo presente non si usa solo per parlare di eventi presenti, ma anche per parlare di eventi futuri; e, come scopriremo ora, il tempo futuro non si usa solo per parlare di eventi futuri, ma anche per parlare di eventi presenti.
Per fare insieme questa scoperta incredibile, spostiamoci da Cortina a Firenze, e andiamo a leggere un brano di un articolo che esemplifica un diverso uso del futuro indicativo. L’articolo definisce Firenze nel titolo come “una città difficile senza gli anticorpi di una metropoli”. L’articolo si riferisce al degrado della città, secondo l’autrice.
Nell’articolo, l’autore elabora delle ipotesi sulle cause dell’indifferenza dei passanti alla sofferenza che va in scena per strada, e lo fa usando il futuro:
Sarà che non ci sono più residenti e bottegai, sarà che la gente ha paura, sarà che si è persa la dimensione civica e si è piombati in una realtà metropolitana, sarà che in un mondo che costringe ad andare a mille all’ora, non c’è più nemmeno più il tempo per fermarsi ad assistere un anziano.
”Sarà che” si ripete quattro volte nel testo. Ecco, questo futuro non serve, come nel testo di prima, a collocare l’evento in un momento posteriore a quello della scrittura. Serve invece a esprimere una serie di ipotesi su una situazione presente, e non futura. Un po’ come dire “forse non ci sono più residenti, forse la gente ha paura”.
Questo uso del futuro è definito tecnicamente epistemico (ma non devi imparare questo termine): l’idea è che, appunto, serve a fare ipotesi, fare deduzioni. Non si parla di fatti certi, ma di congetture incerte.
Dal punto di vista temporale, questo tipo di futuro ha valore di presente, si riferisce al momento in cui parliamo o scriviamo.
Proviamo a capire meglio la differenza tra i due usi del futuro. Facciamo un piccolo esercizio e, per ogni esempio, dovrai dirmi se, secondo te, si tratta di un uso temporale o epistemico. Andiamo! Se hai bisogno di qualche secondo per pensarci, metti in pausa il video.
Dal prossimo anno le mie priorità saranno lo studio e lo sport. Questo che cos’è? Questo è un uso temporale: uso il futuro per descrivere un mio PROGETTO futuro.
Prometto che per quell’ora sarò a casa. Anche questo è un uso temporale, qui uso il futuro per esprimere una PROMESSA, per impegnarmi, dunque, a compiere un’azione in un momento futuro.
— Che ore sono?
— Saranno le tre.
Questo è un futuro epistemico: esprimo un’ipotesi che possiamo parafrasare come “ora forse sono le tre” o “secondo me sono le tre”, “credo siano le tre”.
A quest’ora Maria sarà già a casa. Qui abbiamo un futuro epistemico: uso il futuro per esprimere un’ipotesi, con il significato di “a quest’ora forse Maria è già a casa”, o “secondo me Maria è già a casa”.
Incontrerai un uomo affascinante che diventerà il tuo fidanzato. Ecco, qui il futuro parla effettivamente del futuro, e si usa per fare una previsione.
— Chi sarà quell’uomo?
— Mah, sarà il nuovo fidanzato della signora Baldini.
Qui uso il futuro, di nuovo, per esprimere un’ipotesi sull’identità dell’uomo in questione, con il significato di “forse è il nuovo fidanzato della signora Baldini”, o “secondo me”.
— Quanto guadagnerà per avere un macchinone così?
— Beh, guadagnerà almeno 4 mila euro al mese.
Anche questa è un’ipotesi, una deduzione che facciamo sulla base del fatto che l’uomo ha un macchinone mica da ridere.
Entro il prossimo anno guadagnerò il doppio di quello che sto guadagnando ora, me lo sono posto come obiettivo.
Questa invece è una previsione che riguarda il futuro.
Facciamo una riflessione interessante: che cos’hanno in comune questi due usi? Beh, l’ho anticipato all’inizio del video: l’incertezza. Sì, perché, se parliamo di previsioni future, beh, per definizione sono incerte. Non abbiamo la sfera di cristallo.🔮 Ma anche le ipotesi, le congetture non sono fattuali, sono, appunto, incerte. È proprio questo che accomuna questi due usi del futuro.
E sono proprio i casi in cui parliamo di situazioni o di azioni abbastanza certe, invece, in cui tendiamo a usare il presente, perché meno associati, appunto, all’incertezza. Per esempio, per parlare di piani: “domani vengo alle 3”; questo è un piano, è una mia intenzione, quindi, probabilmente, le cose andranno così.
Nota bene: oltre al futuro semplice, anche il futuro composto (o futuro anteriore) può avere un uso epistemico. In quel caso, servirà al parlante a esprimere un’ipotesi su un’azione o uno stato passato. Osserva la differenza tra queste coppie di frasi:
— Che ore sono?
— Saranno le tre
Significa “ora forse sono le tre”.
— Che ore saranno state quando c’è stata la scossa di terremoto?
— Mah, saranno state le tre.
Significa “in quel momento - passato - forse erano le tre”
A quest’ora Maria sarà già a casa. Significa “a quest’ora forse Maria è già a casa, penso che sia a casa”.
A quest’ora Maria sarà già rientrata a casa. Significa “a quest’ora forse Maria è già rientrata - in un momento passato - a casa”.
— Chi sarà quell’uomo?
— Mah, sarà il nuovo fidanzato della signora Baldini.
Significa “forse è il nuovo fidanzato della signora Baldini”.
— Dove avrà incontrato quell’uomo?
— Mah, lo avrà incontrato su Tinder, non lo so.
Significa “forse lo ha incontrato - sempre nel passato - su Tinder”.
— Quanto guadagnerà per avere un macchinone così?
— Beh, guadagnerà almeno 4 mila euro al mese.
Significa “forse guadagnerà 4 mila euro al mese, non meno”.
— Quanto avranno guadagnato i nostri concorrenti con quel contratto?
— Avranno guadagnato più di quello che abbiamo guadagnato noi in un anno.
Significa “forse hanno guadagnato - in un momento passato - più di quello che abbiamo guadagnato noi in un anno.
Troverai comunque tutti questi esempi riepilogati nel PDF, che ti consiglio davvero di scaricare: ti sarà molto utile e noi dedichiamo molto tempo e mettiamo molto amore nel creare questi PDF per ogni video. Dai un’occhiata.
Poniamoci ora una domanda: il futuro composto ha anche un uso temporale, oltre all’uso epistemico, che abbiamo visto?
Beh, la risposta è: sì! Certo! Il futuro composto si usa, oltre che per esprimere un’ipotesi su un evento passato, anche per indicare un’azione futura che è precedente, anteriore a un’altra azione futura, ecco perché si chiama anche futuro anteriore.
In altre parole, può essere usato per indicare un’azione futura che avviene prima di un’altra azione futura di cui si parla. Ciò avviene in combinazione con congiunzioni come quando, (non) appena, dopo che. Analizziamo alcuni esempi tratti anche questi da testi autentici.
Da una recensione letteraria abbiamo, ad esempio, estrapolato questa citazione:
Redenta è ingenua, ma il suo sguardo sbilenco vede ciò che gli altri ignorano. È vulnerabile, ma resiste alla ferocia del suo tempo. È un personaggio letterario magnifico. La sua voce continuerà a risuonare a lungo, dopo che avrete chiuso l'ultima pagina.
E quindi, prima chiuderete l’ultima pagina, e dopo la voce del personaggio di Redenta continuerà a risuonare. I due eventi si collocano entrambi nel futuro, rispetto al momento in cui l’autore scrive la recensione. Ma dei due eventi, uno si verifica prima (il chiudere la pagina), e per questo è espresso col futuro composto, e l’altro si verifica dopo (il persistente risuonare del personaggio), e per questo è espresso col futuro semplice.
Analizziamo un secondo esempio. Dalla guida di un sito online sul pagamento delle fatture, leggiamo:
Come sapere che il servizio è attivo: riceverai un’email con oggetto “conferma pagamento” non appena avremo completato la registrazione.
Cioè, prima completeremo la registrazione, e poi riceverai un’email di conferma. I due eventi si posizionano entrambi nel futuro, ma uno è anteriore all’altro.
Analizziamo un terzo e ultimo esempio tratto da una pagina di consigli su come gestire una squadra di lavoro:
In questa pagina non solo voglio spiegarti quali sono questi motivi e cosa fare per riuscire a delegare, ma anche cosa otterrai quando avrai imparato a farlo.
Prima imparerai a delegare, poi otterrai dei vantaggi. L’uno e l’altro evento si situano nel futuro. Ma il delegare precede l’ottenere vantaggi.
Attenzione! Il futuro composto, nell’uso temporale, può avere come ancoraggio, come riferimento, non solo un’altra azione al futuro, ma anche un’espressione di tempo, come mostrano i seguenti esempi:
- Domenica avrò finito tutti gli esami.
- Entro la fine della settimana avrò perso due chili.
- Se continuo a lavorare a questo ritmo, per venerdì avrò finito il progetto.
Quindi abbiamo un momento futuro, che è il nostro momento di riferimento, e poi diciamo che cosa succede prima di quel momento di riferimento.
Il futuro ammette la perifrasi progressiva, quella costruzione come “sto mangiando”, “stavo uscendo“ e così via. Ecco, al futuro, avremo, quindi, “starò mangiando“, “starò uscendo”.
Per fare un esempio:
Quando arriverai a casa, starò mangiando;
che è diverso da dire:
Quando arriverai a casa, mangerò.
Cioè, se dico “starò mangiando”, intendo dire che nel momento in cui tu arriverai a casa io sarò nel bel mezzo del mio pranzo o cena, mentre se dico “quando arriverai a casa, mangerò” intendo dire che dopo che arriverai (o dopo che sarai arrivato) io inizierò a mangiare. Questa è una costruzione alternativa a quella con il futuro composto, leggermente più informale. Col futuro composto la costruzione sarebbe “quando sarai arrivato a casa, mangerò”. Ed è sempre possibile il presente con significato futuro: “quando arrivi a casa, mangio”. Anzi, questa è decisamente la soluzione più comune nella lingua parlata.
Ecco, questo non funziona con verbi di stato come essere, stare, sapere: cioè non posso dire starò essendo, starò sapendo; come d’altronde non posso dire, neanche al presente, sto essendo, sto sapendo, sto stando. Non funziona in italiano.
Prima di concludere, dobbiamo ricordare altri due usi, meno frequenti ma comunque esistenti, del futuro indicativo:
Il primo è quello del cosiddetto futuro degli storici, (bel nome!) esemplificato da questo paragrafo su Giuseppe Garibaldi:
- Contemporaneamente il generale, sempre dalla sua Caprera, indirizza al Presidente della Camera una più formale lettera di dimissioni. L’Assemblea non le accoglie, e accorda invece all’”Eroe dei due mondi” un congedo di tre mesi. In delicate condizioni di salute, Garibaldi morirà a Caprera il 2 giugno 1882.
Qui abbiamo una serie di verbi al presente, dei presenti storici, che parlano del passato come se stesse avvenendo adesso; e poi c’è un futuro, che esprime fatti successivi a quelli appena descritti, quel morirà. Ecco, questo uso è appunto tipico dei libri di storia, delle narrazioni storiche, ma, nel parlato, non si usa, direi.
Il secondo uso del futuro con cui concludiamo questo video, è quello che ha come obiettivo esprimere un ordine, un comando o un’esortazione (dunque il futuro indicativo usato come variante dell’imperativo), come in questo esempio:
- Ora tu ti toglierai immediatamente quegli scarponi luridi, prenderai il mocio e pulirai tutte le impronte che hai lasciato sul pavimento!
Questo uso non è forse così comune: nel parlato preferiamo usare il presente, con la stessa funzione (quindi ora ti togli quegli scarponi, prendi il mocio) oppure, ovviamente, l’imperativo (togliti quegli scarponi, prendi il mocio).
Bene, questo è tutto per oggi. Ora, se vuoi metterti alla prova con degli esercizi, beh, ne troverai un po’ nel PDF che abbiamo preparato per te con tanto amore. Ti lascio di nuovo qui il codice QR, ma lo trovi anche sotto, nella descrizione del video. Alla prossima!
Hai paura del futuro? È normale, il futuro fa paura, il futuro è incerto. Ok, ora mi riferisco al futuro in senso esistenziale, ma anche il futuro nella lingua italiana ti può fare paura, perché nasconde alcuni usi che forse non conosci ma che sono davvero importanti per parlare come un italiano. (Ok forse è un po’ tirata come intro, questa). Tra l’altro, come vedremo, anche il futuro come tempo verbale ha a che vedere con l’incertezza.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Parleremo, in questo video, degli usi del futuro dell’italiano e lo faremo partendo da materiali autentici, materiali reali.
E non ci limiteremo a occuparci del futuro semplice, ma ci occuperemo anche del futuro composto (anche chiamato futuro anteriore).
Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara la lingua italiana. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno, e ricorda che la trascrizione integrale si trova sul mio sito, podcastitaliano.com. E poi, come sempre, ho anche preparato un PDF che accompagna il video e ti permetterà di ripassare quello che imparerai oggi e anche di esercitarti: ti consiglio di stamparlo, perché ti tornerà molto utile. Ti lascio il link in descrizione, oppure puoi scansionare questo codice QR a fianco alla mia testa.
Partiamo dal primo testo, un articolo che annuncia il rincaro degli alloggi a Cortina a causa delle Olimpiadi invernali del 2026. Il titolo recita infatti:
Ecco quanto costerà dormire a Cortina durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Il titolo contiene già un verbo al futuro, costerà. Lo stesso tempo verbale ritorna più volte in questo brano del testo:
E intanto la località di montagna è già un cantiere, con ben nove grandi alberghi in ristrutturazione o addirittura ricostruiti […]. L’antico Ampezzo, palazzo signorile ottocentesco, languiva abbandonato in pieno centro storico. Qui, l'80% della viabilità recupererà un disegno e la zona tornerà a vivere a pieno regime. Ma pare che la maggior parte degli hotel, […] non sarà pronta per l'evento sportivo. Per questo motivo, gli affitti a breve termine degli appartamenti privati schizzeranno alle stelle […]
Costerà, recupererà, sarà, schizzeranno sono tutti esempi di verbi al futuro. Ancora più nello specifico, di verbi al futuro nel suo uso temporale: per collocare, cioè, l’evento (o gli eventi), sulla linea del tempo, in un momento posteriore a quello in cui avviene la comunicazione; in questo caso, posteriore al momento in cui l’autore scrive l’articolo. Fin qui tutto semplice, vero? Nulla di sconvolgente.
Parentesi: ti invito a fare con me una considerazione. In italiano esiste almeno un altro tempo verbale che usiamo spesso per parlare di eventi che si collocano temporalmente dopo il momento della comunicazione. Ed è l’indicativo presente. Quando diciamo:
- Domani mi sveglio presto.
- Tra una settimana comincia la scuola.
- L’anno prossimo vado all’università.
Ecco, in tutti questi casi, sto parlando di eventi posteriori al momento in cui ne sto parlando, e ne sto parlando al presente. Dunque, il presente può essere usato sia per parlare di eventi contemporanei al momento in cui parlo (o scrivo), sia per parlare di eventi successivi. Nella lingua parlata questo avviene molto di frequente, ma oggi non te ne parlo perché ne ho già parlato in questo video.
Questo è un principio generale da ricordare: uno stesso tempo verbale può essere usato per esprimere eventi che si collocano in diversi tempi della realtà, e inoltre uno stesso tempo della realtà può essere espresso mediante diversi tempi verbali. Il tempo presente non si usa solo per parlare di eventi presenti, ma anche per parlare di eventi futuri; e, come scopriremo ora, il tempo futuro non si usa solo per parlare di eventi futuri, ma anche per parlare di eventi presenti.
Per fare insieme questa scoperta incredibile, spostiamoci da Cortina a Firenze, e andiamo a leggere un brano di un articolo che esemplifica un diverso uso del futuro indicativo. L’articolo definisce Firenze nel titolo come “una città difficile senza gli anticorpi di una metropoli”. L’articolo si riferisce al degrado della città, secondo l’autrice.
Nell’articolo, l’autore elabora delle ipotesi sulle cause dell’indifferenza dei passanti alla sofferenza che va in scena per strada, e lo fa usando il futuro:
Sarà che non ci sono più residenti e bottegai, sarà che la gente ha paura, sarà che si è persa la dimensione civica e si è piombati in una realtà metropolitana, sarà che in un mondo che costringe ad andare a mille all’ora, non c’è più nemmeno più il tempo per fermarsi ad assistere un anziano.
”Sarà che” si ripete quattro volte nel testo. Ecco, questo futuro non serve, come nel testo di prima, a collocare l’evento in un momento posteriore a quello della scrittura. Serve invece a esprimere una serie di ipotesi su una situazione presente, e non futura. Un po’ come dire “forse non ci sono più residenti, forse la gente ha paura”.
Questo uso del futuro è definito tecnicamente epistemico (ma non devi imparare questo termine): l’idea è che, appunto, serve a fare ipotesi, fare deduzioni. Non si parla di fatti certi, ma di congetture incerte.
Dal punto di vista temporale, questo tipo di futuro ha valore di presente, si riferisce al momento in cui parliamo o scriviamo.
Proviamo a capire meglio la differenza tra i due usi del futuro. Facciamo un piccolo esercizio e, per ogni esempio, dovrai dirmi se, secondo te, si tratta di un uso temporale o epistemico. Andiamo! Se hai bisogno di qualche secondo per pensarci, metti in pausa il video.
Dal prossimo anno le mie priorità saranno lo studio e lo sport. Questo che cos’è? Questo è un uso temporale: uso il futuro per descrivere un mio PROGETTO futuro.
Prometto che per quell’ora sarò a casa. Anche questo è un uso temporale, qui uso il futuro per esprimere una PROMESSA, per impegnarmi, dunque, a compiere un’azione in un momento futuro.
— Che ore sono?
— Saranno le tre.
Questo è un futuro epistemico: esprimo un’ipotesi che possiamo parafrasare come “ora forse sono le tre” o “secondo me sono le tre”, “credo siano le tre”.
A quest’ora Maria sarà già a casa. Qui abbiamo un futuro epistemico: uso il futuro per esprimere un’ipotesi, con il significato di “a quest’ora forse Maria è già a casa”, o “secondo me Maria è già a casa”.
Incontrerai un uomo affascinante che diventerà il tuo fidanzato. Ecco, qui il futuro parla effettivamente del futuro, e si usa per fare una previsione.
— Chi sarà quell’uomo?
— Mah, sarà il nuovo fidanzato della signora Baldini.
Qui uso il futuro, di nuovo, per esprimere un’ipotesi sull’identità dell’uomo in questione, con il significato di “forse è il nuovo fidanzato della signora Baldini”, o “secondo me”.
— Quanto guadagnerà per avere un macchinone così?
— Beh, guadagnerà almeno 4 mila euro al mese.
Anche questa è un’ipotesi, una deduzione che facciamo sulla base del fatto che l’uomo ha un macchinone mica da ridere.
Entro il prossimo anno guadagnerò il doppio di quello che sto guadagnando ora, me lo sono posto come obiettivo.
Questa invece è una previsione che riguarda il futuro.
Facciamo una riflessione interessante: che cos’hanno in comune questi due usi? Beh, l’ho anticipato all’inizio del video: l’incertezza. Sì, perché, se parliamo di previsioni future, beh, per definizione sono incerte. Non abbiamo la sfera di cristallo.🔮 Ma anche le ipotesi, le congetture non sono fattuali, sono, appunto, incerte. È proprio questo che accomuna questi due usi del futuro.
E sono proprio i casi in cui parliamo di situazioni o di azioni abbastanza certe, invece, in cui tendiamo a usare il presente, perché meno associati, appunto, all’incertezza. Per esempio, per parlare di piani: “domani vengo alle 3”; questo è un piano, è una mia intenzione, quindi, probabilmente, le cose andranno così.
Nota bene: oltre al futuro semplice, anche il futuro composto (o futuro anteriore) può avere un uso epistemico. In quel caso, servirà al parlante a esprimere un’ipotesi su un’azione o uno stato passato. Osserva la differenza tra queste coppie di frasi:
— Che ore sono?
— Saranno le tre
Significa “ora forse sono le tre”.
— Che ore saranno state quando c’è stata la scossa di terremoto?
— Mah, saranno state le tre.
Significa “in quel momento - passato - forse erano le tre”
A quest’ora Maria sarà già a casa. Significa “a quest’ora forse Maria è già a casa, penso che sia a casa”.
A quest’ora Maria sarà già rientrata a casa. Significa “a quest’ora forse Maria è già rientrata - in un momento passato - a casa”.
— Chi sarà quell’uomo?
— Mah, sarà il nuovo fidanzato della signora Baldini.
Significa “forse è il nuovo fidanzato della signora Baldini”.
— Dove avrà incontrato quell’uomo?
— Mah, lo avrà incontrato su Tinder, non lo so.
Significa “forse lo ha incontrato - sempre nel passato - su Tinder”.
— Quanto guadagnerà per avere un macchinone così?
— Beh, guadagnerà almeno 4 mila euro al mese.
Significa “forse guadagnerà 4 mila euro al mese, non meno”.
— Quanto avranno guadagnato i nostri concorrenti con quel contratto?
— Avranno guadagnato più di quello che abbiamo guadagnato noi in un anno.
Significa “forse hanno guadagnato - in un momento passato - più di quello che abbiamo guadagnato noi in un anno.
Troverai comunque tutti questi esempi riepilogati nel PDF, che ti consiglio davvero di scaricare: ti sarà molto utile e noi dedichiamo molto tempo e mettiamo molto amore nel creare questi PDF per ogni video. Dai un’occhiata.
Poniamoci ora una domanda: il futuro composto ha anche un uso temporale, oltre all’uso epistemico, che abbiamo visto?
Beh, la risposta è: sì! Certo! Il futuro composto si usa, oltre che per esprimere un’ipotesi su un evento passato, anche per indicare un’azione futura che è precedente, anteriore a un’altra azione futura, ecco perché si chiama anche futuro anteriore.
In altre parole, può essere usato per indicare un’azione futura che avviene prima di un’altra azione futura di cui si parla. Ciò avviene in combinazione con congiunzioni come quando, (non) appena, dopo che. Analizziamo alcuni esempi tratti anche questi da testi autentici.
Da una recensione letteraria abbiamo, ad esempio, estrapolato questa citazione:
Redenta è ingenua, ma il suo sguardo sbilenco vede ciò che gli altri ignorano. È vulnerabile, ma resiste alla ferocia del suo tempo. È un personaggio letterario magnifico. La sua voce continuerà a risuonare a lungo, dopo che avrete chiuso l'ultima pagina.
E quindi, prima chiuderete l’ultima pagina, e dopo la voce del personaggio di Redenta continuerà a risuonare. I due eventi si collocano entrambi nel futuro, rispetto al momento in cui l’autore scrive la recensione. Ma dei due eventi, uno si verifica prima (il chiudere la pagina), e per questo è espresso col futuro composto, e l’altro si verifica dopo (il persistente risuonare del personaggio), e per questo è espresso col futuro semplice.
Analizziamo un secondo esempio. Dalla guida di un sito online sul pagamento delle fatture, leggiamo:
Come sapere che il servizio è attivo: riceverai un’email con oggetto “conferma pagamento” non appena avremo completato la registrazione.
Cioè, prima completeremo la registrazione, e poi riceverai un’email di conferma. I due eventi si posizionano entrambi nel futuro, ma uno è anteriore all’altro.
Analizziamo un terzo e ultimo esempio tratto da una pagina di consigli su come gestire una squadra di lavoro:
In questa pagina non solo voglio spiegarti quali sono questi motivi e cosa fare per riuscire a delegare, ma anche cosa otterrai quando avrai imparato a farlo.
Prima imparerai a delegare, poi otterrai dei vantaggi. L’uno e l’altro evento si situano nel futuro. Ma il delegare precede l’ottenere vantaggi.
Attenzione! Il futuro composto, nell’uso temporale, può avere come ancoraggio, come riferimento, non solo un’altra azione al futuro, ma anche un’espressione di tempo, come mostrano i seguenti esempi:
- Domenica avrò finito tutti gli esami.
- Entro la fine della settimana avrò perso due chili.
- Se continuo a lavorare a questo ritmo, per venerdì avrò finito il progetto.
Quindi abbiamo un momento futuro, che è il nostro momento di riferimento, e poi diciamo che cosa succede prima di quel momento di riferimento.
Il futuro ammette la perifrasi progressiva, quella costruzione come “sto mangiando”, “stavo uscendo“ e così via. Ecco, al futuro, avremo, quindi, “starò mangiando“, “starò uscendo”.
Per fare un esempio:
Quando arriverai a casa, starò mangiando;
che è diverso da dire:
Quando arriverai a casa, mangerò.
Cioè, se dico “starò mangiando”, intendo dire che nel momento in cui tu arriverai a casa io sarò nel bel mezzo del mio pranzo o cena, mentre se dico “quando arriverai a casa, mangerò” intendo dire che dopo che arriverai (o dopo che sarai arrivato) io inizierò a mangiare. Questa è una costruzione alternativa a quella con il futuro composto, leggermente più informale. Col futuro composto la costruzione sarebbe “quando sarai arrivato a casa, mangerò”. Ed è sempre possibile il presente con significato futuro: “quando arrivi a casa, mangio”. Anzi, questa è decisamente la soluzione più comune nella lingua parlata.
Ecco, questo non funziona con verbi di stato come essere, stare, sapere: cioè non posso dire starò essendo, starò sapendo; come d’altronde non posso dire, neanche al presente, sto essendo, sto sapendo, sto stando. Non funziona in italiano.
Prima di concludere, dobbiamo ricordare altri due usi, meno frequenti ma comunque esistenti, del futuro indicativo:
Il primo è quello del cosiddetto futuro degli storici, (bel nome!) esemplificato da questo paragrafo su Giuseppe Garibaldi:
- Contemporaneamente il generale, sempre dalla sua Caprera, indirizza al Presidente della Camera una più formale lettera di dimissioni. L’Assemblea non le accoglie, e accorda invece all’”Eroe dei due mondi” un congedo di tre mesi. In delicate condizioni di salute, Garibaldi morirà a Caprera il 2 giugno 1882.
Qui abbiamo una serie di verbi al presente, dei presenti storici, che parlano del passato come se stesse avvenendo adesso; e poi c’è un futuro, che esprime fatti successivi a quelli appena descritti, quel morirà. Ecco, questo uso è appunto tipico dei libri di storia, delle narrazioni storiche, ma, nel parlato, non si usa, direi.
Il secondo uso del futuro con cui concludiamo questo video, è quello che ha come obiettivo esprimere un ordine, un comando o un’esortazione (dunque il futuro indicativo usato come variante dell’imperativo), come in questo esempio:
- Ora tu ti toglierai immediatamente quegli scarponi luridi, prenderai il mocio e pulirai tutte le impronte che hai lasciato sul pavimento!
Questo uso non è forse così comune: nel parlato preferiamo usare il presente, con la stessa funzione (quindi ora ti togli quegli scarponi, prendi il mocio) oppure, ovviamente, l’imperativo (togliti quegli scarponi, prendi il mocio).
Bene, questo è tutto per oggi. Ora, se vuoi metterti alla prova con degli esercizi, beh, ne troverai un po’ nel PDF che abbiamo preparato per te con tanto amore. Ti lascio di nuovo qui il codice QR, ma lo trovi anche sotto, nella descrizione del video. Alla prossima!

.png)
.png)



.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
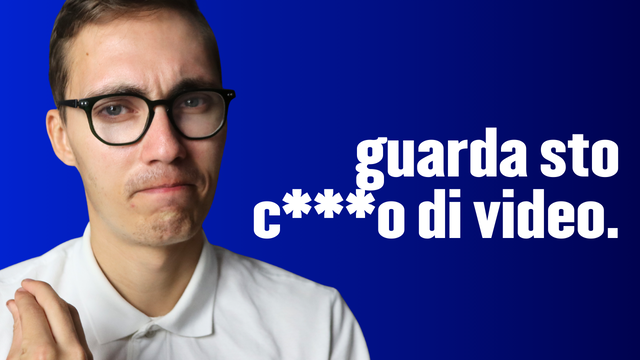
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)




























