5 TECNICHE per MEMORIZZARE le parole in italiano
In questo video scoprirai 5 strategie efficaci per memorizzare il lessico italiano, dalle flashcards con ripetizione spaziata agli associogrammi, dalla ripetizione ad alta voce alle tecniche di contestualizzazione. Imparerai anche come usare l'intelligenza artificiale per creare filastrocche personalizzate e come sfruttare l'etimologia delle parole per ricordarle meglio.
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
Quando si viaggia non si portano con sé le grammatiche; piuttosto, ci si porta un dizionario.
Questa frase del linguista Stephen Krashen racchiude una verità che nessuno studente di lingua dovrebbe dimenticare, ovvero che conoscere tante parole è fondamentale per capire e parlare bene una lingua.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Se mi conosci, sai già che per me le parole sono più importanti di tutto il resto, nell’apprendimento di una lingua: più importanti della grammatica, più importanti della pronuncia… le parole sono fondamentali per capire e per parlare bene una lingua. Più ne sappiamo, meglio è.
Ma la domanda fondamentale allora è: come memorizzare le parole? Quali strategie, quali tecniche e quali principi puoi adottare per imparare e memorizzare il lessico, e magari usarlo anche attivamente, oltre che comprenderlo passivamente?
Ne parliamo in questo video che sarà molto interessante, perché sono convinto che alcune di queste tecniche non le avrai mai sentite, e che quindi potrebbero rivelarsi molto interessanti ed estremamente utili.
Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l’italiano. Attiva i sottotitoli qui sotto, se ne hai bisogno; ricorda poi che la trascrizione integrale di quello che dico in questo video, si trova sul mio sito, podcastitaliano.com. Ho anche preparato un PDF che accompagna il video, e che potrai usare durante la visione. Questo pdf ti consiglio di stamparlo, a proposito, perché ti tornerà molto utile. Quindi stampalo, se puoi. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR.
Prima però voglio ricordarti brevemente un po’ come la penso io, sull’apprendimento delle lingue, la mia filosofia, se già non la conosci, che è questa: l’80% dell’apprendimento linguistico, quanto meno l’apprendimento passivo, e quindi anche l’80% dell’apprendimento delle parole, passa attraverso l’input, l’input comprensibile, ovvero ascoltare e leggere contenuti che siamo in grado di capire bene o abbastanza bene, e idealmente che siano interessanti o appassionanti. Stephen Krashen, che abbiamo menzionato prima, è uno dei più grandi sostenitori dell’input comprensibile: anzi, l’ipotesi dell’input comprensibile è proprio sua. Dunque darò per scontato che sai già come la penso sul tema e che ascolti e leggi già molto in italiano: ricorda che, se non lo fai, difficilmente farai grandi progressi, e queste tecniche che ti insegnerò diventano solo distrazioni inutili, o meglio, non aggiungono molto.
Detto questo, se già sei d’accordo con me su questo punto, io sono dell’idea che ci siano altre strategie meno centrali ma che possono aiutare l’apprendimento linguistico e che possono essere anche divertenti o stimolanti per alcuni di noi. Oggi, appunto, ci concentriamo su 5 strategie per interiorizzare le parole nuove, e per ogni strategia vedremo una serie di tecniche. Come vedremo, queste strategie sfumano le une nelle altre, sono cioè strettamente legate tra di loro e puoi anche combinarle insieme. Anzi, questo è proprio il modo migliore, secondo me, di applicarle. Iniziamo!
1. Lo sapevi che dopo soli 20 minuti dall’esposizione all’input nella lingua che impari si dimentica il 30-45 % del materiale linguistico memorizzato, e che dopo un giorno si è perso dal 50 al 65 % e dopo un mese addirittura l’80 %? Proprio per evitare questa perdita, si può ricorrere a tecniche di ripetizione. Una delle più efficaci è quella delle flashcards.
Le flashcards sono semplicemente delle schede, fisiche o digitali, con una domanda da un lato (il “prompt”) e la risposta dall’altro. Nel nostro caso, la domanda può essere una definizione, o una frase con uno spazio vuoto da completare; la risposta sarà la parola o l’espressione che stai cercando di ricordare, di ripescare dalla memoria. Esistono vari software per crearle: Anki, Quizlet, Memrise sono tra i più popolari.
Ora, dietro il funzionamento delle flashcards, c’è il principio della ripetizione spaziata (o Spaced Repetition). È una tecnica di memorizzazione basata su studi condotti già nell’Ottocento da Hermann Ebbinghaus, uno psicologo tedesco che per primo descrisse la cosiddetta curva dell’oblio (o forgetting curve, in inglese). In poche parole, dimentichiamo rapidamente tutto ciò che non ripassiamo, perché il nostro cervello decide che non è importante e dunque quell’informazione si può tranquillamente cancellare.
La ripetizione spaziata contrasta questo fenomeno proponendoti di ripassare le informazioni, in questo caso, le parole, proprio nel momento in cui stai per dimenticarle. Ogni volta che ricordi correttamente una parola, il software (e questo è il vantaggio del software) la ripresenterà sempre più di rado, sempre più raramente: avrai bisogno di ripassarla meno di frequente, magari una volta al mese o persino una volta ogni sei mesi.
Un altro principio chiave è quello del richiamo attivo (active recall): invece di rivedere passivamente le informazioni, sei costretto a recuperarle dalla tua memoria, e questo sforzo mentale rende il ricordo più solido.
Il mio consiglio è questo: crea flashcards includendo il contesto linguistico originale in cui hai trovato una parola o un’espressione.
Nella parte frontale non includere solo la definizione o un sinonimo della parola, ma aggiungi la frase in cui l’hai incontrata.per esempio, davanti possiamo scrivere:
Chi produce o ripara oggetti a mano, spesso utilizzando tecniche tradizionali.
Che è la definizione.
Poi, la frase è…
“Conosco un _____ che costruisce mobili in legno su misura”.
E sul retro metti “artigiano”, che è la parola che vogliamo indovinare, e la frase con la parola nel contesto, quindi “conosco un artigiano che costruisce mobili in legno su misura”.
Questo piccolo accorgimento del contesto fa una grande differenza, secondo me è molto utile perché il cervello ricorda meglio le informazioni contestualizzate, legate a un’esperienza linguistica reale.
Attenzione: la ripetizione non deve necessariamente riguardare parole singole, isolate, anzi; ancora meglio se riguarda unità più ampie, come, ad esempio, coppie di parole, parole inserite in espressioni, modi di dire, proverbi.
Molti studenti di lingue adorano le flashcards, io personalmente trovo che possano essere molto utili soprattutto per le parole o espressioni che facciamo più fatica a memorizzare, quelle a bassa frequenza che non incontriamo spesso nei testi o negli ascolti ma che, per qualche motivo, vogliamo memorizzare, ci piacciono e vogliamo farle nostre. E quindi una buona idea è creare una flashcard per queste.
A proposito: nei nostri corsi, Dentro l’Italia, Volti d’Italia e La storia di Italo, abbiamo già preparato per te mazzi di flashcards su Quizlet con le parole più difficili di ogni episodio.
2. La ripetizione può essere quella delle flashcards, ma ha lo svantaggio che è un po’ laboriosa, richiede un po’ di lavoro. Una cosa che puoi fare è ripetere ad alta voce registrando le parole nuove utilizzando l’app del microfono sul tuo telefono (voice memo, o come si chiama, insomma, sul tuo dispositivo) e, riascoltare così le parole registrate e ripeterle a voce alta.
Come abbiamo visto per le flashcards, la ripetizione può riguardare non solo parole singole, ma anche unità più ampie, perfino interi testi (come slogan, poesie, filastrocche, citazioni).
Facciamo un esempio. Immaginiamo che tu stia frequentando un corso di italiano e stia imparando il lessico legato al viaggio, e che il tuo obiettivo sia memorizzare le parole che si riferiscono ai mezzi di trasporto. Prova a registrarti mentre pronunci questa breve filastrocca inventata, poi riascoltati, e ripeti:
In treno vado a Roma,
in pullman vado a Sulmona,
in traghetto a Pantelleria
in aereo me ne volo via
La rima ti aiuterà a memorizzare il testo, e ripeterla sarà utile a fissare parole come “treno”, “pullman”, “traghetto”, “aereo”. Questo è un po’ lo stesso principio per cui ascoltare la musica è così efficace nell’apprendimento del lessico e delle strutture di una lingua, perché il ritmo e la musicalità rendono molto più facile la memorizzazione. Quindi sfrutta la musicalità della musica e anche delle filastrocche; e se sei una persona creativa, puoi scriverle anche tu, o chiedere all’intelligenza artificiale.
Ho dato ad esempio a un chatbot questo prompt: Scrivimi una filastrocca di 6 righe in rima baciata (AABBCC) che contenga il vocabolario relativo alle "vacanze in montagna". Il risultato, che ho leggermente adattato, è il seguente:
Zaino 🎒 sulle spalle e binocolo in mano,nel sentiero nel bosco cammino pian piano.Tra i sentieri respiro il profumo di pino,al rifugio mi scaldo vicino a un camino.Coi fedeli scarponi raggiungo la vetta,viva la montagna, silenziosa e perfetta!
Le parole che ho evidenziato in grassetto sono quelle che appartengono all’area lessicale che abbiamo scelto, quella delle “vacanze in montagna”. Insomma, visto che l’IA esiste, ed è qui per restare, pensiamo a modi creativi di usarla e integrarla nel nostro apprendimento!
3. Una terza strategia che può essere di grande utilità nella costruzione di un vocabolario più ampio consiste nell’associare la parola che vogliamo fissare nella memoria ad altre parole che hanno una relazione forte con la prima. Come? Ad esempio, annotando le parole associate nella stessa pagina di quaderno, nello stesso file digitale; insomma, nel supporto che preferisci. La relazione tra le parole associate può dipendere da fari fattori:
- Il primo, il più ovvio, è dal fatto che appartengono allo stesso dominio, allo stesso ambito (ad esempio, possiamo associare ”treno” a “pullman”, “traghetto”, “aereo”, “taxi”, “moto”, “bicicletta”, sono tutte parole che si riferiscono a mezzi di trasporto). Anche in questo caso possiamo chiedere aiuto all’IA. Chiedendo Dammi 10 parole che appartengono allo stesso dominio lessicale della parola "spiaggia" ho ottenuto per esempio questa lista: Ombrellone - Sabbia - Mare - Asciugamano - Crema solare - Costume - Secchiello - Bagnino - Conchiglia - Telo mare. Se il significato di qualcuna di queste parole non dovesse esserci chiaro, possiamo chiaramente chiedere alla stessa IA, o ovviamente anche cercare su un dizionario, se preferiamo.
- In alternativa, l’associazione di una parola ad altre parole può dipendere anche dal fatto che queste parole entrano tutte nella stessa azione, oppure nella stessa catena di azioni (possiamo in questo modo associare “treno” a ”biglietto”, “timbrare”, “binario”, “salire”, “partenza”, “controllore”, “arrivo”, “scendere”, in quanto tutte queste parole possono essere usate per descrivere un evento come questo: ho comprato il biglietto per il treno interregionale, l’ho timbrato, sono andato al binario, sono salito sul treno qualche minuto prima della partenza da Roma, ho mostrato il biglietto al controllore e, all’arrivo a Napoli, sono sceso per correre all’Università).
Le associazioni tra parole possono essere rappresentate anche graficamente, attraverso i cosiddetti associogrammi. Gli associogrammi sono diagrammi che partono da una parola-base, a partire dalla quale si sviluppa una rete di associazioni. Si ottiene così una mappa concettuale che può aiutarci a organizzare il lessico.
Nel Thesaurus dell’Enciclopedia Treccani, il cui link ti lascio nel PDF, insieme ad altri esempi di associogrammi interessanti, ti lascio un po’ di roba interessante, troverai anche una grande quantità di mappe lessicali già pronte all’uso, mappe in cui una parola-base è associata ad altre parole che hanno con la prima parola una qualche relazione, un rapporto di significato.
Osserviamo ad esempio la mappa associativa (o, appunto, associogramma) della parola “treno”:
In questa mappa, le relazioni di significato con la parola di base sono organizzate in varie categorie, tra cui:
- “persone” (passeggero, pendolare, viaggiatore.)
- “cose” (scompartimento, sedile, finestrino.)
- “parti” (locomotiva, vagone, carrozza.)
- “azioni” (come cambiare, partire, salire, scendere etc.)
E così via. Nel PDF associato a questo video ti lascio alcuni consigli ulteriori su come usare gli assiociogrammi.
A proposito di associazioni tra parole, ti ricordo che nulla funziona meglio che creare associazioni di tipo “affettivo” o “emotivo”. Associare le parole alle esperienze affettive di cui siamo stati protagonisti, e di cui queste parole sono state protagoniste, è di grande, grandissimo aiuto alla loro memorizzazione. Le parole che ci restano in mente perché sono legate a esperienze personali, positive o negative che siano, sono quelle che non dimenticheremo mai più. A me capita spesso di passare del tempo magari con dei madrelingua, parliamo molto nella lingua del madrelingua, e viene fuori una parola che io non conosco, e quella parola me la ricordo perché magari la giornata che abbiamo passato insieme è particolarmente memorabile, abbiamo fatto cose interessanti o divertenti… insomma, non è una giornata comune. E quindi fare esperienze nella lingua che stiamo imparando ci aiuta molto anche a questo scopo.
E quindi, perché non provare a creare degli associogrammi tutti tuoi, personali, legati alle tue esperienze di vita. Lo puoi fare, ad esempio, usando come espressioni-stimolo, diciamo:
- “gita a (gita a… come una città italiana che hai visitato, magari)“
- “conversazione con (un italiano che hai conosciuto)”
- “lettura di (un libro in italiano che ti è piaciuto)”
E creare un diagramma con tutte le parole, magari parole nuove che hai appena imparato nella tua lezione di conversazione o nella tua conversazione con un partner linguistico, e che, in questa maniera, vuoi memorizzare.
4. Un’altra strategia per memorizzare le parole nuove che incontri nell’input a cui ti esponi, e quindi quando leggi e quando ascolti in italiano, consiste nell’inserirle in un contesto linguistico; non necessariamente, o non solo, lo stesso contesto in cui hai incontrato quella parola in origine (che comunque, ti ricordo, è molto importante, l’abbiamo visto per le flashcards), ma anche un in nuovo contesto linguistico. La parola è contestualizzata, ad esempio, quando è inserita in una coppia di parole legate tra loro da un rapporto di significato, o quando è inserita in una frase, oppure, a un livello ancora superiore, quando è collocata in un testo. Studi di linguistica confermano che, in generale, i gruppi di parole di lunghezza di 10-15 sillabe sono più facili da memorizzare.
Vediamo alcune tecniche.
- Forma coppie di parole, ad esempio: treno regionale, treno interregionale, treno passeggeri, treno merci. Per formare queste coppie, puoi sia ricorrere agli associogrammi di cui abbiamo precedentemente parlato, sia usare strumenti di intelligenza artificiale. Per esempio, chiedendo: In quali coppie di parole entra con maggiore frequenza la parola “treno"? Io, per esempio, ho ottenuto come risposta: treno veloce - treno regionale - treno ad alta velocità - treno merci. E puoi anche usare i cosiddetti dizionari di collocazioni, come il dizionario Zanichelli di collocazioni, che ti mostrano quali sono le collocazioni (cioè le combinazioni) più comuni di parole: di verbi e nomi, di aggettivi e nomi, di verbi e avverbi, e così via. E quindi, con nomi e verbi, potresti avere “Il treno è partito”, “Il treno viaggia a 200 chilometri all’ora”, “Il treno rallenta quando arriva alla stazione”, ecc.
- La seconda tecnica è quella di inserire la parola in un’azione o in una catena di azioni. Facciamo un altro esempio. Chiediamo all’IA: Scrivi un testo di 20-25 parole che includa la parola “spiaggia” in una catena di azioni. Ecco cosa otteniamo: Arrivo in spiaggia, stendo l’asciugamano, metto la crema solare, nuoto nel mare, faccio castelli con la sabbia, poi mangio un gelato. Nuovamente, le parole che ti evidenzio sono quelle associate dal fatto che rientrano nella stessa catena di azioni, e tra l’altro, appartengono allo stesso ambito, cioè quello della spiaggia e del mare.
- La terza tecnica è quella di apprendere frasi idiomatiche e proverbi in cui si trova la parola che vuoi imparare, come perdere l’ultimo treno, che significa “lasciarsi sfuggire l’ultima occasione” o questo è un treno che passa una sola volta, che vuol dire “questa è un’occasione rara che passa una sola volta nella vita”. Ma se ti interessano le frasi idiomatiche, ti segnalo un altro strumento disponibile: il “Dizionario dei modi di dire” edito da Hoepli. Ti basterà digitare la parola che vuoi contestualizzare, ad esempio “viaggio”, e otterrai in risposta un elenco di espressioni idiomatiche e proverbi che la contengono. Ti lascio il link nell’indirizzo che trovi nel PDF. A proposito, sapevi che ho un intero ebook dedicato ai 50 modi di dire più comuni usati in italiano? Te lo lascio nel PDF.
- La quarta tecnica, che abbiamo già menzionato prima parlando della registrazione e ripetizione ad alta voce, è quella di ricorrere a filastrocche, cioè poesie per bambini in rima. Ne abbiamo vista una prima, vediamone un altra, sul treno:
Il treno va veloce,
laggiù, nel grande piano,
e annuncia la sua voce che va lontan lontano.
- La quinta tecnica consiste nell’elaborare uno o più esempi che illustrino il significato della parola; ad esempio: lo sciopero dei trasporti ha causato ritardi dei treni e disagi ai pendolari; in questo può aiutarti, tra gli altri strumenti, Google Notizie, Google News, in italiano, ovviamente, dove troverai esempi tratti da contesti reali di queste parole, oppure ti consiglio anche il sito YouGlish, che ti permette di fare ricerche all’interno dei video YouTube, dei sottotitoli dei video YouTube. Nel PDF, comunque, ti dico di più su come usare questi strumenti.
5. L’ultima strategia di cui ti voglio parlare è quella del confronto, della comparazione, che può avere luogo:
- in italiani, cioè all’interno della lingua che stai studiando (e sarà in questo caso un confronto tra una parola nuova che hai incontrato e altre parole che conosci già bene);
- oppure può avvenire tra l’italiano e la tua lingua materna, la tua lingua madre. Quest’ultimo tipo di confronto, tra lingue, anche se è demonizzato da alcuni insegnanti (cioè non piace a tutti gli insegnanti, ma io non sono tra loro), può aiutarti a prendere coscienza delle somiglianze e differenze di significato che esistono tra parole italiane e parole della tua lingua, parole che a volte possono sembrare equivalenti ma non esserlo del tutto, che possono NON riferirsi esattamente alla stessa cosa, alla stessa entità del mondo allo stesso modo, con le stesse connotazioni culturali, ad esempio.
Ecco alcune tecniche che ti consiglio:
- cercare sinonimi, parole con significato uguale o molto simile (ad esempio, veloce e rapido), oppure antonimi, o contrari (ad esempio, veloce e lento); in questo caso può aiutarti un dizionario dei sinonimi e dei contrari, come quello a cura di Hoepli che è disponibile all’indirizzo che trovi nel PDF.
- cercare equivalenze di una parola nella lingua madre (ad esempio tra treno e train, tren, trem)
- distinguere tra equivalenze totali, oppure parziali, o perfino ingannevoli (i famosi “falsi amici”, come parent-parente, dove la parola inglese significa “genitore” mentre quella italiana significa “un familiare”);
- individuare le parole per cui non esiste nessuna equivalenza diretta e parafrasarle, come si potrebbe fare, ad esempio, con la parola “menefreghista”, cioè persona che se ne frega (dall’espressione “me ne frego”) e che, almeno in inglese, non mi pare abbia una traduzione di una sola parola (ma, se ce l’ha, scrivimi un commento, così imparo qualcosa anch’io).
- Un’altra cosa che può essere molto utile per ricordare il significato di una parola è conoscere la sua etimologia, la sua origine. L’etimologia può aiutare a capire e memorizzare meglio una parola nuova, perché la collega ad altre parole che già conosci. Prendiamo per esempio la parola falegname. Vai sul dizionario, vedi il significato, ma poi, dando un’occhiata all’etimologia, scopri che viene da fa + legname, e tutto diventa più chiaro: il falegname è la persona che “fa legname”, cioè che raccoglie il legno, e lavora il legno. E a quel punto è molto più probabile che tu la ricordi, perché il significato è diventato logico, è diventato quasi visivo. Un altro esempio semplice e interessante è capodanno. La parola viene da capo + d’anno, letteralmente “la testa dell’anno”, cioè il suo inizio. Sapere che capo (dal latino “caput”) significa “testa” (ed è per questo che “capo”, come “boss”, ha questo significato; il capo è la testa di un’organizzazione), dicevo, sapere questa etimologia ti aiuta anche a riconoscere questa stessa radice in tante altre parole italiane: capitale, cioè la “testa”, la città principale di uno Stato; capitano: il “capo” di un gruppo; capolavoro: il “lavoro principale e più importante, più bello di un artista”. Trovi l’etimologia in alcuni dizionari, come per esempio lo Zingarelli (che è a pagamento). Non sempre l’etimologia ti sarà utile o comprensibile (soprattutto se l’origine è latina o greca e, insomma… tira in ballo parole che non conosci), ma io consiglio, comunque, di buttare un occhio all’etimologia, perché a volte ti riserva scoperte illuminanti che ti possono, proprio, a livello pratico, di memorizzazione, ti possono aiutare.
Per concludere questo video molto lungo, voglio fare un’ultima osservazione. Cosa significa, davvero, sapere una parola? Capirla non è certo saperla usare, anche perché possiamo capire, dal contesto, parole che non abbiamo mai sentito prima. Secondo me puoi dire che hai imparato davvero una parola, che è entrata nel tuo vocabolario pienamente, solo se la sai usare attivamente. Ricordati dunque di provare a usare le parole nuove che impari e di prestare attenzione al feedback che ti danno i madrelingua, soprattutto gli insegnanti, perché saranno loro in grado di dirti se l’hai usata bene o male. Fai delle prove, fai dei test, e vedi le reazioni degli italiani. E ovviamente occorre ascoltare e leggere il più possibile, per esporci a una parola da tanti angoli diversi e capire tutte le sue sfumature e i suoi contesti d’uso, capirla a 360 gradi.
Ricorda che queste sono tecniche, strategie, e principi che puoi sperimentare, ma soprattutto le tecniche specifiche che ti ho dato, non ti consiglio di usarle se ti risultano noiose: perché, se ti obblighi a usarle e non ti piace, l’unico effetto che otterresti è quello di stufarti, di perdere interesse, e questa è una cosa pericolosa che dovresti cercare di evitare. Perché, al di là delle strategie e tecniche specifiche, divertirsi è ciò che più importa. Per esempio, io trovo che le flashcards possano essere molto utili ed efficaci, ma personalmente le trovo un po’ noiose e non sono mai riuscito a usarle con costanza. E dunque, non le uso. Ma so che sono utili.
Bene. Ora, se vuoi, puoi ripassare tutto quello che abbiamo visto con il PDF, dove troverai tutte queste tecniche riassunte e troverai anche alcuni approfondimenti interessanti. Puoi scaricare il PDF al link in descrizione oppure scansionare questo codice QR. Nel PDF, tra l’altro, ti propongo anche delle attività per lavorare sul lessico a partire da un input, attraverso alcune delle strategie di misurazione che abbiamo usato.
Ti ricordo, poi, che ho già parlato di memorizzazione di parole con Alessandro De Concini, che è un esperto di apprendimento e di memoria: con lui abbiamo parlato di altre tecniche che qui non abbiamo menzionato, ma che possono essere molto interessanti. Se t’interessa ti lascio la card alla fine del video. E ora raccontami: quale tra le strategie che ho menzionato usi già? Quali sono le strategie che hai trovato più efficaci per imparare una parola? Quali, invece, vorresti provare?
Fammi sapere. Questo è tutto, alla prossima!
Quando si viaggia non si portano con sé le grammatiche; piuttosto, ci si porta un dizionario.
Questa frase del linguista Stephen Krashen racchiude una verità che nessuno studente di lingua dovrebbe dimenticare, ovvero che conoscere tante parole è fondamentale per capire e parlare bene una lingua.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Se mi conosci, sai già che per me le parole sono più importanti di tutto il resto, nell’apprendimento di una lingua: più importanti della grammatica, più importanti della pronuncia… le parole sono fondamentali per capire e per parlare bene una lingua. Più ne sappiamo, meglio è.
Ma la domanda fondamentale allora è: come memorizzare le parole? Quali strategie, quali tecniche e quali principi puoi adottare per imparare e memorizzare il lessico, e magari usarlo anche attivamente, oltre che comprenderlo passivamente?
Ne parliamo in questo video che sarà molto interessante, perché sono convinto che alcune di queste tecniche non le avrai mai sentite, e che quindi potrebbero rivelarsi molto interessanti ed estremamente utili.
Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l’italiano. Attiva i sottotitoli qui sotto, se ne hai bisogno; ricorda poi che la trascrizione integrale di quello che dico in questo video, si trova sul mio sito, podcastitaliano.com. Ho anche preparato un PDF che accompagna il video, e che potrai usare durante la visione. Questo pdf ti consiglio di stamparlo, a proposito, perché ti tornerà molto utile. Quindi stampalo, se puoi. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR.
Prima però voglio ricordarti brevemente un po’ come la penso io, sull’apprendimento delle lingue, la mia filosofia, se già non la conosci, che è questa: l’80% dell’apprendimento linguistico, quanto meno l’apprendimento passivo, e quindi anche l’80% dell’apprendimento delle parole, passa attraverso l’input, l’input comprensibile, ovvero ascoltare e leggere contenuti che siamo in grado di capire bene o abbastanza bene, e idealmente che siano interessanti o appassionanti. Stephen Krashen, che abbiamo menzionato prima, è uno dei più grandi sostenitori dell’input comprensibile: anzi, l’ipotesi dell’input comprensibile è proprio sua. Dunque darò per scontato che sai già come la penso sul tema e che ascolti e leggi già molto in italiano: ricorda che, se non lo fai, difficilmente farai grandi progressi, e queste tecniche che ti insegnerò diventano solo distrazioni inutili, o meglio, non aggiungono molto.
Detto questo, se già sei d’accordo con me su questo punto, io sono dell’idea che ci siano altre strategie meno centrali ma che possono aiutare l’apprendimento linguistico e che possono essere anche divertenti o stimolanti per alcuni di noi. Oggi, appunto, ci concentriamo su 5 strategie per interiorizzare le parole nuove, e per ogni strategia vedremo una serie di tecniche. Come vedremo, queste strategie sfumano le une nelle altre, sono cioè strettamente legate tra di loro e puoi anche combinarle insieme. Anzi, questo è proprio il modo migliore, secondo me, di applicarle. Iniziamo!
1. Lo sapevi che dopo soli 20 minuti dall’esposizione all’input nella lingua che impari si dimentica il 30-45 % del materiale linguistico memorizzato, e che dopo un giorno si è perso dal 50 al 65 % e dopo un mese addirittura l’80 %? Proprio per evitare questa perdita, si può ricorrere a tecniche di ripetizione. Una delle più efficaci è quella delle flashcards.
Le flashcards sono semplicemente delle schede, fisiche o digitali, con una domanda da un lato (il “prompt”) e la risposta dall’altro. Nel nostro caso, la domanda può essere una definizione, o una frase con uno spazio vuoto da completare; la risposta sarà la parola o l’espressione che stai cercando di ricordare, di ripescare dalla memoria. Esistono vari software per crearle: Anki, Quizlet, Memrise sono tra i più popolari.
Ora, dietro il funzionamento delle flashcards, c’è il principio della ripetizione spaziata (o Spaced Repetition). È una tecnica di memorizzazione basata su studi condotti già nell’Ottocento da Hermann Ebbinghaus, uno psicologo tedesco che per primo descrisse la cosiddetta curva dell’oblio (o forgetting curve, in inglese). In poche parole, dimentichiamo rapidamente tutto ciò che non ripassiamo, perché il nostro cervello decide che non è importante e dunque quell’informazione si può tranquillamente cancellare.
La ripetizione spaziata contrasta questo fenomeno proponendoti di ripassare le informazioni, in questo caso, le parole, proprio nel momento in cui stai per dimenticarle. Ogni volta che ricordi correttamente una parola, il software (e questo è il vantaggio del software) la ripresenterà sempre più di rado, sempre più raramente: avrai bisogno di ripassarla meno di frequente, magari una volta al mese o persino una volta ogni sei mesi.
Un altro principio chiave è quello del richiamo attivo (active recall): invece di rivedere passivamente le informazioni, sei costretto a recuperarle dalla tua memoria, e questo sforzo mentale rende il ricordo più solido.
Il mio consiglio è questo: crea flashcards includendo il contesto linguistico originale in cui hai trovato una parola o un’espressione.
Nella parte frontale non includere solo la definizione o un sinonimo della parola, ma aggiungi la frase in cui l’hai incontrata.per esempio, davanti possiamo scrivere:
Chi produce o ripara oggetti a mano, spesso utilizzando tecniche tradizionali.
Che è la definizione.
Poi, la frase è…
“Conosco un _____ che costruisce mobili in legno su misura”.
E sul retro metti “artigiano”, che è la parola che vogliamo indovinare, e la frase con la parola nel contesto, quindi “conosco un artigiano che costruisce mobili in legno su misura”.
Questo piccolo accorgimento del contesto fa una grande differenza, secondo me è molto utile perché il cervello ricorda meglio le informazioni contestualizzate, legate a un’esperienza linguistica reale.
Attenzione: la ripetizione non deve necessariamente riguardare parole singole, isolate, anzi; ancora meglio se riguarda unità più ampie, come, ad esempio, coppie di parole, parole inserite in espressioni, modi di dire, proverbi.
Molti studenti di lingue adorano le flashcards, io personalmente trovo che possano essere molto utili soprattutto per le parole o espressioni che facciamo più fatica a memorizzare, quelle a bassa frequenza che non incontriamo spesso nei testi o negli ascolti ma che, per qualche motivo, vogliamo memorizzare, ci piacciono e vogliamo farle nostre. E quindi una buona idea è creare una flashcard per queste.
A proposito: nei nostri corsi, Dentro l’Italia, Volti d’Italia e La storia di Italo, abbiamo già preparato per te mazzi di flashcards su Quizlet con le parole più difficili di ogni episodio.
2. La ripetizione può essere quella delle flashcards, ma ha lo svantaggio che è un po’ laboriosa, richiede un po’ di lavoro. Una cosa che puoi fare è ripetere ad alta voce registrando le parole nuove utilizzando l’app del microfono sul tuo telefono (voice memo, o come si chiama, insomma, sul tuo dispositivo) e, riascoltare così le parole registrate e ripeterle a voce alta.
Come abbiamo visto per le flashcards, la ripetizione può riguardare non solo parole singole, ma anche unità più ampie, perfino interi testi (come slogan, poesie, filastrocche, citazioni).
Facciamo un esempio. Immaginiamo che tu stia frequentando un corso di italiano e stia imparando il lessico legato al viaggio, e che il tuo obiettivo sia memorizzare le parole che si riferiscono ai mezzi di trasporto. Prova a registrarti mentre pronunci questa breve filastrocca inventata, poi riascoltati, e ripeti:
In treno vado a Roma,
in pullman vado a Sulmona,
in traghetto a Pantelleria
in aereo me ne volo via
La rima ti aiuterà a memorizzare il testo, e ripeterla sarà utile a fissare parole come “treno”, “pullman”, “traghetto”, “aereo”. Questo è un po’ lo stesso principio per cui ascoltare la musica è così efficace nell’apprendimento del lessico e delle strutture di una lingua, perché il ritmo e la musicalità rendono molto più facile la memorizzazione. Quindi sfrutta la musicalità della musica e anche delle filastrocche; e se sei una persona creativa, puoi scriverle anche tu, o chiedere all’intelligenza artificiale.
Ho dato ad esempio a un chatbot questo prompt: Scrivimi una filastrocca di 6 righe in rima baciata (AABBCC) che contenga il vocabolario relativo alle "vacanze in montagna". Il risultato, che ho leggermente adattato, è il seguente:
Zaino 🎒 sulle spalle e binocolo in mano,nel sentiero nel bosco cammino pian piano.Tra i sentieri respiro il profumo di pino,al rifugio mi scaldo vicino a un camino.Coi fedeli scarponi raggiungo la vetta,viva la montagna, silenziosa e perfetta!
Le parole che ho evidenziato in grassetto sono quelle che appartengono all’area lessicale che abbiamo scelto, quella delle “vacanze in montagna”. Insomma, visto che l’IA esiste, ed è qui per restare, pensiamo a modi creativi di usarla e integrarla nel nostro apprendimento!
3. Una terza strategia che può essere di grande utilità nella costruzione di un vocabolario più ampio consiste nell’associare la parola che vogliamo fissare nella memoria ad altre parole che hanno una relazione forte con la prima. Come? Ad esempio, annotando le parole associate nella stessa pagina di quaderno, nello stesso file digitale; insomma, nel supporto che preferisci. La relazione tra le parole associate può dipendere da fari fattori:
- Il primo, il più ovvio, è dal fatto che appartengono allo stesso dominio, allo stesso ambito (ad esempio, possiamo associare ”treno” a “pullman”, “traghetto”, “aereo”, “taxi”, “moto”, “bicicletta”, sono tutte parole che si riferiscono a mezzi di trasporto). Anche in questo caso possiamo chiedere aiuto all’IA. Chiedendo Dammi 10 parole che appartengono allo stesso dominio lessicale della parola "spiaggia" ho ottenuto per esempio questa lista: Ombrellone - Sabbia - Mare - Asciugamano - Crema solare - Costume - Secchiello - Bagnino - Conchiglia - Telo mare. Se il significato di qualcuna di queste parole non dovesse esserci chiaro, possiamo chiaramente chiedere alla stessa IA, o ovviamente anche cercare su un dizionario, se preferiamo.
- In alternativa, l’associazione di una parola ad altre parole può dipendere anche dal fatto che queste parole entrano tutte nella stessa azione, oppure nella stessa catena di azioni (possiamo in questo modo associare “treno” a ”biglietto”, “timbrare”, “binario”, “salire”, “partenza”, “controllore”, “arrivo”, “scendere”, in quanto tutte queste parole possono essere usate per descrivere un evento come questo: ho comprato il biglietto per il treno interregionale, l’ho timbrato, sono andato al binario, sono salito sul treno qualche minuto prima della partenza da Roma, ho mostrato il biglietto al controllore e, all’arrivo a Napoli, sono sceso per correre all’Università).
Le associazioni tra parole possono essere rappresentate anche graficamente, attraverso i cosiddetti associogrammi. Gli associogrammi sono diagrammi che partono da una parola-base, a partire dalla quale si sviluppa una rete di associazioni. Si ottiene così una mappa concettuale che può aiutarci a organizzare il lessico.
Nel Thesaurus dell’Enciclopedia Treccani, il cui link ti lascio nel PDF, insieme ad altri esempi di associogrammi interessanti, ti lascio un po’ di roba interessante, troverai anche una grande quantità di mappe lessicali già pronte all’uso, mappe in cui una parola-base è associata ad altre parole che hanno con la prima parola una qualche relazione, un rapporto di significato.
Osserviamo ad esempio la mappa associativa (o, appunto, associogramma) della parola “treno”:
In questa mappa, le relazioni di significato con la parola di base sono organizzate in varie categorie, tra cui:
- “persone” (passeggero, pendolare, viaggiatore.)
- “cose” (scompartimento, sedile, finestrino.)
- “parti” (locomotiva, vagone, carrozza.)
- “azioni” (come cambiare, partire, salire, scendere etc.)
E così via. Nel PDF associato a questo video ti lascio alcuni consigli ulteriori su come usare gli assiociogrammi.
A proposito di associazioni tra parole, ti ricordo che nulla funziona meglio che creare associazioni di tipo “affettivo” o “emotivo”. Associare le parole alle esperienze affettive di cui siamo stati protagonisti, e di cui queste parole sono state protagoniste, è di grande, grandissimo aiuto alla loro memorizzazione. Le parole che ci restano in mente perché sono legate a esperienze personali, positive o negative che siano, sono quelle che non dimenticheremo mai più. A me capita spesso di passare del tempo magari con dei madrelingua, parliamo molto nella lingua del madrelingua, e viene fuori una parola che io non conosco, e quella parola me la ricordo perché magari la giornata che abbiamo passato insieme è particolarmente memorabile, abbiamo fatto cose interessanti o divertenti… insomma, non è una giornata comune. E quindi fare esperienze nella lingua che stiamo imparando ci aiuta molto anche a questo scopo.
E quindi, perché non provare a creare degli associogrammi tutti tuoi, personali, legati alle tue esperienze di vita. Lo puoi fare, ad esempio, usando come espressioni-stimolo, diciamo:
- “gita a (gita a… come una città italiana che hai visitato, magari)“
- “conversazione con (un italiano che hai conosciuto)”
- “lettura di (un libro in italiano che ti è piaciuto)”
E creare un diagramma con tutte le parole, magari parole nuove che hai appena imparato nella tua lezione di conversazione o nella tua conversazione con un partner linguistico, e che, in questa maniera, vuoi memorizzare.
4. Un’altra strategia per memorizzare le parole nuove che incontri nell’input a cui ti esponi, e quindi quando leggi e quando ascolti in italiano, consiste nell’inserirle in un contesto linguistico; non necessariamente, o non solo, lo stesso contesto in cui hai incontrato quella parola in origine (che comunque, ti ricordo, è molto importante, l’abbiamo visto per le flashcards), ma anche un in nuovo contesto linguistico. La parola è contestualizzata, ad esempio, quando è inserita in una coppia di parole legate tra loro da un rapporto di significato, o quando è inserita in una frase, oppure, a un livello ancora superiore, quando è collocata in un testo. Studi di linguistica confermano che, in generale, i gruppi di parole di lunghezza di 10-15 sillabe sono più facili da memorizzare.
Vediamo alcune tecniche.
- Forma coppie di parole, ad esempio: treno regionale, treno interregionale, treno passeggeri, treno merci. Per formare queste coppie, puoi sia ricorrere agli associogrammi di cui abbiamo precedentemente parlato, sia usare strumenti di intelligenza artificiale. Per esempio, chiedendo: In quali coppie di parole entra con maggiore frequenza la parola “treno"? Io, per esempio, ho ottenuto come risposta: treno veloce - treno regionale - treno ad alta velocità - treno merci. E puoi anche usare i cosiddetti dizionari di collocazioni, come il dizionario Zanichelli di collocazioni, che ti mostrano quali sono le collocazioni (cioè le combinazioni) più comuni di parole: di verbi e nomi, di aggettivi e nomi, di verbi e avverbi, e così via. E quindi, con nomi e verbi, potresti avere “Il treno è partito”, “Il treno viaggia a 200 chilometri all’ora”, “Il treno rallenta quando arriva alla stazione”, ecc.
- La seconda tecnica è quella di inserire la parola in un’azione o in una catena di azioni. Facciamo un altro esempio. Chiediamo all’IA: Scrivi un testo di 20-25 parole che includa la parola “spiaggia” in una catena di azioni. Ecco cosa otteniamo: Arrivo in spiaggia, stendo l’asciugamano, metto la crema solare, nuoto nel mare, faccio castelli con la sabbia, poi mangio un gelato. Nuovamente, le parole che ti evidenzio sono quelle associate dal fatto che rientrano nella stessa catena di azioni, e tra l’altro, appartengono allo stesso ambito, cioè quello della spiaggia e del mare.
- La terza tecnica è quella di apprendere frasi idiomatiche e proverbi in cui si trova la parola che vuoi imparare, come perdere l’ultimo treno, che significa “lasciarsi sfuggire l’ultima occasione” o questo è un treno che passa una sola volta, che vuol dire “questa è un’occasione rara che passa una sola volta nella vita”. Ma se ti interessano le frasi idiomatiche, ti segnalo un altro strumento disponibile: il “Dizionario dei modi di dire” edito da Hoepli. Ti basterà digitare la parola che vuoi contestualizzare, ad esempio “viaggio”, e otterrai in risposta un elenco di espressioni idiomatiche e proverbi che la contengono. Ti lascio il link nell’indirizzo che trovi nel PDF. A proposito, sapevi che ho un intero ebook dedicato ai 50 modi di dire più comuni usati in italiano? Te lo lascio nel PDF.
- La quarta tecnica, che abbiamo già menzionato prima parlando della registrazione e ripetizione ad alta voce, è quella di ricorrere a filastrocche, cioè poesie per bambini in rima. Ne abbiamo vista una prima, vediamone un altra, sul treno:
Il treno va veloce,
laggiù, nel grande piano,
e annuncia la sua voce che va lontan lontano.
- La quinta tecnica consiste nell’elaborare uno o più esempi che illustrino il significato della parola; ad esempio: lo sciopero dei trasporti ha causato ritardi dei treni e disagi ai pendolari; in questo può aiutarti, tra gli altri strumenti, Google Notizie, Google News, in italiano, ovviamente, dove troverai esempi tratti da contesti reali di queste parole, oppure ti consiglio anche il sito YouGlish, che ti permette di fare ricerche all’interno dei video YouTube, dei sottotitoli dei video YouTube. Nel PDF, comunque, ti dico di più su come usare questi strumenti.
5. L’ultima strategia di cui ti voglio parlare è quella del confronto, della comparazione, che può avere luogo:
- in italiani, cioè all’interno della lingua che stai studiando (e sarà in questo caso un confronto tra una parola nuova che hai incontrato e altre parole che conosci già bene);
- oppure può avvenire tra l’italiano e la tua lingua materna, la tua lingua madre. Quest’ultimo tipo di confronto, tra lingue, anche se è demonizzato da alcuni insegnanti (cioè non piace a tutti gli insegnanti, ma io non sono tra loro), può aiutarti a prendere coscienza delle somiglianze e differenze di significato che esistono tra parole italiane e parole della tua lingua, parole che a volte possono sembrare equivalenti ma non esserlo del tutto, che possono NON riferirsi esattamente alla stessa cosa, alla stessa entità del mondo allo stesso modo, con le stesse connotazioni culturali, ad esempio.
Ecco alcune tecniche che ti consiglio:
- cercare sinonimi, parole con significato uguale o molto simile (ad esempio, veloce e rapido), oppure antonimi, o contrari (ad esempio, veloce e lento); in questo caso può aiutarti un dizionario dei sinonimi e dei contrari, come quello a cura di Hoepli che è disponibile all’indirizzo che trovi nel PDF.
- cercare equivalenze di una parola nella lingua madre (ad esempio tra treno e train, tren, trem)
- distinguere tra equivalenze totali, oppure parziali, o perfino ingannevoli (i famosi “falsi amici”, come parent-parente, dove la parola inglese significa “genitore” mentre quella italiana significa “un familiare”);
- individuare le parole per cui non esiste nessuna equivalenza diretta e parafrasarle, come si potrebbe fare, ad esempio, con la parola “menefreghista”, cioè persona che se ne frega (dall’espressione “me ne frego”) e che, almeno in inglese, non mi pare abbia una traduzione di una sola parola (ma, se ce l’ha, scrivimi un commento, così imparo qualcosa anch’io).
- Un’altra cosa che può essere molto utile per ricordare il significato di una parola è conoscere la sua etimologia, la sua origine. L’etimologia può aiutare a capire e memorizzare meglio una parola nuova, perché la collega ad altre parole che già conosci. Prendiamo per esempio la parola falegname. Vai sul dizionario, vedi il significato, ma poi, dando un’occhiata all’etimologia, scopri che viene da fa + legname, e tutto diventa più chiaro: il falegname è la persona che “fa legname”, cioè che raccoglie il legno, e lavora il legno. E a quel punto è molto più probabile che tu la ricordi, perché il significato è diventato logico, è diventato quasi visivo. Un altro esempio semplice e interessante è capodanno. La parola viene da capo + d’anno, letteralmente “la testa dell’anno”, cioè il suo inizio. Sapere che capo (dal latino “caput”) significa “testa” (ed è per questo che “capo”, come “boss”, ha questo significato; il capo è la testa di un’organizzazione), dicevo, sapere questa etimologia ti aiuta anche a riconoscere questa stessa radice in tante altre parole italiane: capitale, cioè la “testa”, la città principale di uno Stato; capitano: il “capo” di un gruppo; capolavoro: il “lavoro principale e più importante, più bello di un artista”. Trovi l’etimologia in alcuni dizionari, come per esempio lo Zingarelli (che è a pagamento). Non sempre l’etimologia ti sarà utile o comprensibile (soprattutto se l’origine è latina o greca e, insomma… tira in ballo parole che non conosci), ma io consiglio, comunque, di buttare un occhio all’etimologia, perché a volte ti riserva scoperte illuminanti che ti possono, proprio, a livello pratico, di memorizzazione, ti possono aiutare.
Per concludere questo video molto lungo, voglio fare un’ultima osservazione. Cosa significa, davvero, sapere una parola? Capirla non è certo saperla usare, anche perché possiamo capire, dal contesto, parole che non abbiamo mai sentito prima. Secondo me puoi dire che hai imparato davvero una parola, che è entrata nel tuo vocabolario pienamente, solo se la sai usare attivamente. Ricordati dunque di provare a usare le parole nuove che impari e di prestare attenzione al feedback che ti danno i madrelingua, soprattutto gli insegnanti, perché saranno loro in grado di dirti se l’hai usata bene o male. Fai delle prove, fai dei test, e vedi le reazioni degli italiani. E ovviamente occorre ascoltare e leggere il più possibile, per esporci a una parola da tanti angoli diversi e capire tutte le sue sfumature e i suoi contesti d’uso, capirla a 360 gradi.
Ricorda che queste sono tecniche, strategie, e principi che puoi sperimentare, ma soprattutto le tecniche specifiche che ti ho dato, non ti consiglio di usarle se ti risultano noiose: perché, se ti obblighi a usarle e non ti piace, l’unico effetto che otterresti è quello di stufarti, di perdere interesse, e questa è una cosa pericolosa che dovresti cercare di evitare. Perché, al di là delle strategie e tecniche specifiche, divertirsi è ciò che più importa. Per esempio, io trovo che le flashcards possano essere molto utili ed efficaci, ma personalmente le trovo un po’ noiose e non sono mai riuscito a usarle con costanza. E dunque, non le uso. Ma so che sono utili.
Bene. Ora, se vuoi, puoi ripassare tutto quello che abbiamo visto con il PDF, dove troverai tutte queste tecniche riassunte e troverai anche alcuni approfondimenti interessanti. Puoi scaricare il PDF al link in descrizione oppure scansionare questo codice QR. Nel PDF, tra l’altro, ti propongo anche delle attività per lavorare sul lessico a partire da un input, attraverso alcune delle strategie di misurazione che abbiamo usato.
Ti ricordo, poi, che ho già parlato di memorizzazione di parole con Alessandro De Concini, che è un esperto di apprendimento e di memoria: con lui abbiamo parlato di altre tecniche che qui non abbiamo menzionato, ma che possono essere molto interessanti. Se t’interessa ti lascio la card alla fine del video. E ora raccontami: quale tra le strategie che ho menzionato usi già? Quali sono le strategie che hai trovato più efficaci per imparare una parola? Quali, invece, vorresti provare?
Fammi sapere. Questo è tutto, alla prossima!

.png)
.png)



.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
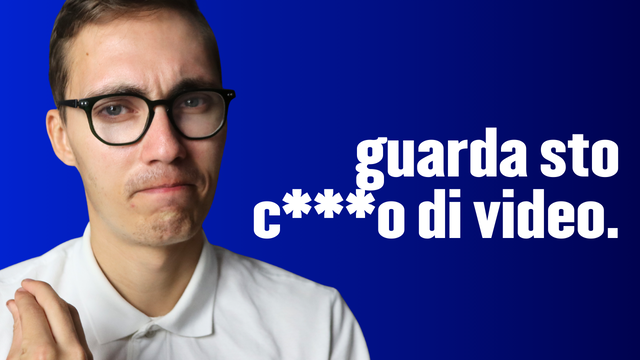
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)




























