Che cosa significa EGLI?
In questo video esploriamo l'evoluzione dei pronomi soggetto italiani partendo dai testi di Leopardi per arrivare all'uso moderno di "lui", "lei" e "loro".
Scarica il PDF gratuito con il riassunto della lezione
Iscriviti alla lista d'attesa della mia nuova "Sfida dei pronomi"
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
C’è una parola un po’ strana che, se impari l’italiano, potresti aver trovato in qualche grammatica, o magari in qualche lettura. Parlo di “egli”. “Egli” è un pronome soggetto, come si dice nella grammatica, ed è una parola che, in italiano moderno, praticamente non si usa più, ma che in passato si usava molto. La sua assenza ha, diciamo così, causato qualche problema, qualche imbarazzo, a volte, nell’ esprimere il pronome soggetto. Quindi guarda questo video perché… beh, è un aspetto fondamentale della grammatica.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
E lo faremo partendo dalla letteratura, dalla Grande Letteratura: partiamo dalla lingua di un grande poeta romantico dell’Ottocento per arrivare alla lingua parlata oggi. Partiamo, infatti, da Giacomo Leopardi, autore di poesie tra le più belle e studiate che siano mai state scritte nella nostra lingua, per parlare di pronomi soggetto, in particolare di quei pronomi che sono diventati nel tempo sempre più rari, fino, in alcuni casi, a scomparire del tutto, sia dalla lingua parlata che, a volte, dalla lingua scritta.
Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l’italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno, e ricorda che la trascrizione integrale di questo video, come di tutti i video, si trova sul mio sito. Ho anche preparato un PDF che riassume il contenuto di questa lezione. Puoi scaricarlo al link in descrizione, oppure scansionando questo codice QR. Dai un’occhiata perché il PDF è davvero un accompagnamento molto utile di tutte le lezioni che facciamo su YouTube.
Ah, e oggi ho anche un annuncio speciale che farò, però, dopo, alla fine del video, dunque guardalo tutto: non perderti l’annuncio!
Apriamo, dunque, un’opera in particolare di Giacomo Leopardi, lo Zibaldone di Pensieri, un’impresa di ben 4500 pagine, più di 60 quaderni scritti tra il 1817 e il 1832, e prepariamoci a quest’immersione nella sua lingua, una lingua comprensibile per un parlante dell’italiano contemporaneo, ma con alcuni tratti che la distanziano dalla lingua di oggi.
L’11 settembre 1821 Leopardi scriveva:
“L’uomo inesperto del mondo, come il giovane (…) sopravvenuto da qualche disgrazia o corporale o qualunque, dov’egli non abbia alcuna colpa, non pensa neppure che ciò debba essere agli altri oggetto di riso sul suo conto.”
In questo pensiero, sull’ingenuità e la purezza di chi ha ancora poca esperienza della vita, ci interessa, in questo video, quell’egli: un pronome che si riferisce al “giovane sopravvenuto da qualche disgrazia”. Ecco, in italiano contemporaneo, per riferirci al giovane in questione, avremmo usato il pronome soggetto “lui” oppure non avremmo usato un bel niente, omettendo, quindi, il pronome soggetto.
Passiamo ora al pensiero leopardiano del 15 dicembre 1826:
“L’invenzione del linguaggio, cosí com’ella è maravigliosissima, è pur comune a tutti i popoli, anche a’ piú separati e piú barbari.”
In questa seconda frase (un pensiero da linguista, in un certo senso) a interessarci è il pronome ella, che si riferisce in questo caso all’invenzione del linguaggio. “Ella” oggi non si userebbe più. Quale pronome allora useremmo nell’italiano contemporaneo al posto di “ella”? Non “lei”, in questo caso, perché “lei”, così come anche “lui”, si usano solo per riferirsi a entità animate, cioè vive, come persone o anche animali; dunque non funziona con “l’invenzione del linguaggio”, che non è né una persona né un animale, ma piuttosto un concetto.
Sai, allora, quale sarebbe la nostra soluzione più probabile? Non esprimere affatto il pronome, lasciarlo implicito, inespresso, ometterlo; usare quello che i linguisti chiamano “soggetto nullo” o “soggetto zero”. Diremmo, cioè, qualcosa di simile a:
“L’invenzione del linguaggio, se da un lato (Ø) è meravigliosa, dall’altro lato è comune a tutti i popoli.
Dove quel simboletto, no? Quello zero sbarrato “Ø” indica proprio il soggetto nullo. Questo è quello che si fa più spesso in italiano: non si scrive o non si dice proprio il pronome soggetto, ma si omette. Ne parliamo meglio dopo.
Passiamo ora al pensiero che Leopardi annota il 19 dicembre 1826:
“Il drammatico è ultimo dei tre generi, di tempo e di nobiltà. Esso non è un'ispirazione, ma un'invenzione; figlio della civiltà, non della natura.”
In questa frase ci interessa il pronome esso, che riprende “il (genere, sarebbe) drammatico”. Per quanto esso resista ancora oggi in alcune scritture molto formali e in alcuni linguaggi specialistici, è sempre più raro nell’italiano contemporaneo, in cui si tende a evitarlo, a sostituirlo con “questo” o “quello” o, più spesso, anche in questo caso, con niente, con un soggetto nullo.
Se Leopardi fosse nato oggi, probabilmente scriverebbe così:
“Il genere drammatico è l’ultimo tra i tre generi, per tempo e per nobiltà. Ø Non è un'ispirazione, ma un'invenzione.”
La stessa cosa vale anche per “essa”, “essi”, “esse”, che sono rispettivamente la forma femminile singolare, maschile plurale e femminile plurale di “esso”.
Ad esempio, il 23 luglio 1827 Leopardi scrive:
“I giovani non hanno patito nulla, non hanno idea sufficiente delle infelicità umane, le considerano quasi come illusioni, o certo come accidenti d’un altro mondo, perché essi non hanno negli occhi che felicità.”
In questo caso essi si riferisce a “i giovani che non hanno patito nulla”, cioè i giovani che non hanno sofferto. Rimanda, cioè, a delle persone. A “essi” e “esse”. Infatti, le forme plurali “essi” e “esse”, a differenza del singolare, quindi “esso” e “essa”, possono rimandare anche a referenti animati, a entità animate, quindi persone e animali.
Tentiamo, a questo punto, una sintesi di ciò che abbiamo scoperto immergendoci nel bellissimo italiano dello Zibaldone di Leopardi:
1. Uno: che i pronomi egli, ella, esso, essa al singolare e essi, esse al plurale si usavano in passato con la funzione di pronomi soggetto di terza persona, per riferirsi cioè a entità del mondo diverse sia dal parlante (io) o dai parlanti (quindi da noi) sia dall’ascoltatore o dagli ascoltatori (quindi tu o voi). Egli ed ella erano usati principalmente per entità animate; esso ed essa si usavano generalmente per entità inanimate, come idee, concetti, solo in casi particolari anche per persone in contesti formali o filosofici. Essi ed esse funzionavano come plurali di tutte le forme precedenti.
Nel successo di queste forme c’è lo zampino di un linguista del Cinquencento, famoso per aver prescritto le regole di buon uso della lingua italiana: sto parlando di Pietro Bembo, il quale, nella sua opera Prose della Volgar Lingua, sentenzia che i pronomi soggetto devono essere egli ed ella, e aggiunge che, se in qualche passo di Dante o Boccaccio compaiono esempi di “lui” (perché, insomma, è un fenomeno che già iniziava a svilupparsi anche all'epoca), beh, ciò accade per distrazione o, nelle sue parole, per “inavvertenza”. Certo che bisogna avere le palle per criticare l’italiano di Dante o di Boccaccio…
Comunque, a Bembo ho dedicato anche questo video se, per caso, ti interessa. Le prescrizioni di “egli”, “ella”, “essi” sono arrivati fino ai giorni nostri, nonostante, in realtà, questi pronomi non si usino nella lingua di tutti i giorni da molto tempo. Ecco, nonostante questo, ancora quando ho fatto le scuole elementari io, quindi poco meno di 20 anni fa, si imparavano ancora i verbi così (per esempio, il verbo essere: io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono). Chissà se oggi si insegnano ancora così o se si usa lui, lei e loro. Ecco, se qualche italiano all’ascolto insegna alle elementari, può lasciarmi un commento, perché io non lo so…non ne ho idea. Però, agli stranieri, normalmente, come sai, si insegnano lui lei e loro. Ma adesso ci arriviamo.
2. Punto due: ti può capitare di imbatterti in questi pronomi che oggi suonano decisamente “antichi” leggendo le opere di autori o autrici precedenti al Novecento, come ad esempio, oltre a Leopardi, Alessandro Manzoni, che nel suo capolavoro, I Promessi Sposi, scrive:
Egli entrò nella stanza con passo misurato.
Ella rimase muta, col capo chino.
O Ugo Foscolo, che nel suo celebre Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis scrive:
Ella non mi ama, e io l’adoro.
Egli è troppo grande per questa terra.
O, andando ancora più indietro, Ludovico Ariosto, che nell’Orlando furioso scrive:
Egli partì, pieno d’onore e gloria.
Ma anche:
Essa piangea la sorte sua, infelice.
Ah, a proposito di Manzoni (il primo degli autori che abbiamo citato, e di cui dovremmo parlare, prima o poi, su questo canale): c’è da riconoscergli il merito di essersi reso conto per primo che egli, ma anche ella, cominciava a suonare antico e artificiale; proprio per questo ha scritto e riscritto molte volte il suo capolavoro, I Promessi Sposi, nel tentativo di “svecchiare”, di rendere un po’ più moderna la lingua, anche dal punto di vista dei pronomi soggetto: così, nell’edizione del 1827 del suo romanzo egli ricorreva 862 volte; pensa, nel 1840, 13 anni dopo, le volte erano solo 64, di egli, con riferimento, spesso, a Dio; lui, che nel ‘27 non compariva mai come soggetto, nel ‘40 ricorreva 200 volte. Ma cosa sarà accaduto agli altri 500 egli? Beh, l’autore non ha fatto altro che quello che facciamo noi ancora oggi: ha semplicemente lasciato il soggetto implicito, inespresso, omesso. Cioè… lo ha tolto. L’esempio di Manzoni è poi stato seguito da molti scrittori dell’Ottocento e del Novecento.
3. Tre: nell’italiano contemporaneo i pronomi di cui abbiamo parlato non si usano più, ad eccezione, forse, di “egli”, che resiste nei registri molto formali (ad esempio negli scritti scientifici o giuridici). “Ella” è invece praticamente scomparso. Al posto di egli, ella, esso, essa, essi, i pronomi soggetto di terza persona che usiamo nell’italiano contemporaneo, soprattutto nel parlato, per riferirci ad entità animate sono:
lui per un’entità animata maschile singolare;
lei per un’entità animata femminile singolare;
loro al plurale, indifferentemente al maschile o femminile.
Questi, in origine, erano le forme usate per l’oggetto diretto, oppure anche indiretto, nello specifico le forme toniche, quindi “ho visto lui”, “ho visto lei”. Le forme come queste di sarebbero usate in casi come “è lui che ha mangiato la torta”: non si sarebbe mai detto “è egli”. Ecco perché ci sono, c’erano, casi in cui egli o ella o essi non si potevano usare, non funzionavano. È proprio per questo che, secondo i linguisti, questi pronomi hanno perso forza, e sono stati sostituiti invece da lui, lei, loro, che invece si possono usare in più casi.
Qual è il problema, però? Che lui, lei, loro, ad alcuni, possono sembrare leggermente informali, soprattutto in contesti un po’ più… appunto, più formali, come, ad esempio, la lingua scritta. Il che porta a un imbarazzo: da un lato egli, ella, esso, essa, essi che sanno davvero di vecchio, di antico; dall’altro abbiamo lui, lei, loro che si usano molto ma non sembrano adatti a tutti i contesti, soprattutto quelli più formali.
4. Se ciò che dobbiamo sostituire con il pronome non è un nome, ma è invece un’intera frase, ricorriamo a parole come “questo” o “ciò”, come nella frase che ora leggiamo:
“Leopardi elabora una visione profondamente pessimistica dell’esistenza, fondata sull’inesorabile conflitto tra desiderio e realtà: ciò emerge con particolare forza nello Zibaldone.”
In questa frase, ciò si riferisce alla parte sottolineata, e potrebbe essere sostituito dal pronome dimostrativo questo, oppure da il che, senza alcuna conseguenza dal punto di vista del significato; la frase, quindi, potrebbe essere riformulata come:
“Leopardi elabora una visione profondamente pessimistica dell’esistenza (…): questo emerge con particolare forza nello Zibaldone (oppure “… il che emerge con particolare forza nello Zibaldone).”
5. Punto cinque: abbiamo detto che oggi i pronomi soggetto che abbiamo a disposizione nell’italiano comune, di tutti i giorni, sono lui, lei, e loro. Ma, in realtà, quello che si fa più spesso in italiano è semplicemente omettere il pronome soggetto, come abbiamo detto (oppure, come dicono i linguisti, “usare un soggetto nullo, un soggetto zero”). L’italiano, come lo spagnolo e il portoghese, e al contrario del francese, inglese e tedesco, è una lingua in cui questo si può fare: il soggetto si può non esprimere. Questo accade tutte le volte che il riferimento del pronome (cioè la persona, animale, cosa a cui si riferisce) è facilmente recuperabile nel testo o nella situazione comunicativa. Che significa? Beh, se dico “parla italiano benissimo”, senza soggetto, capiamo dal verbo che il soggetto è un “lui” o una “lei”. Quale lui o lei? Beh:
- o si tratta di una persona che abbiamo appena menzionato nel testo o nella conversazione, quindi:
John mi ha sorpreso molto. Parla italiano benissimo!
(in cui “parla” si riferisce a John, che abbiamo appena menzionato);
- oppure, se John è qui, con me, nel luogo dove mi trovo io fisicamente, magari insieme ad altre persone, posso dire:
Guarda, parla benissimo!
Riferendomi, appunto, a John, che posso anche indicare. Insomma, non c’è bisogno di dire “LUI parla benissimo”, che è un po’ innaturale in italiano perché mette un’enfasi non necessaria. È un po’ come dire “proprio lui parla benissimo!”.Ci torniamo tra un secondo, ma prima osserva questo brano: tutti i simboli con lo zero “Ø” corrispondono a un soggetto nullo:Nello Zibaldone Leopardi riflette a lungo sulla natura del desiderio, (Ø) analizza la condizione dell’uomo moderno, (Ø) mette in discussione le illusioni del progresso, (Ø) propone una visione radicalmente pessimistica della realtà e (Ø) rifiuta ogni consolazione religiosa.Né egli, né lui. Niente. Questo perché il riferimento è chiaro: tutti i soggetti nulli si riferiscono allo stesso Leopardi, che è il soggetto menzionato all’inizio del testo.
6. Se in italiano la tendenza è questa, di omettere il soggetto, quali sono i contesti in cui l’omissione non si può fare, e invece dobbiamo esprimere il soggetto in maniera esplicita?
La risposta è: quando ciò è necessario o per evitare possibili ambiguità o per esprimere un contrasto, come nei seguenti esempi che riguardano ancora il nostro caro Giacomo Leopardi:
“Lui, a differenza di molti suoi contemporanei, non cerca consolazioni religiose o ideali.”
“Il romanticismo italiano ha cercato spesso speranza nella fede; lui, invece, ha guardato in faccia la disperazione.”
Oppure:
“Leopardi si allontana dagli altri romantici: mentre loro celebrano la nazione nascente, lui ne mette a nudo le fragilità e le illusioni.”
Ma se vuoi approfondire i casi in cui bisogna usare il pronome soggetto, beh, ti consiglio di dare un’occhiata a questo video, di qualche tempo fa; te lo lascio in descrizione, nel caso tu voglia approfondire. Oppure, ascolta quello che ho da dirti adesso: si, perché, all’inizio del video, ti ho promesso un annuncio speciale… ed eccolo qua.
A settembre inizierà una sfida: i pronomi personali. Una sfida è un corso incentrato su un argomento linguistico specifico, in questo caso pronomi personali. E quindi scoprirai tutti i segreti dietro a parole come tu, lui, lei, lo, la, gli, ci, vi, e combinazioni ostiche come te lo, glieli, se ne, ci si, lo si, se lo … i riflessivi, i verbi pronominali idiomatici, cavarsela, farcela… e molto altro ancora. Sarà un corso basato su un approccio grammaticale molto innovativo, qualcosa che nessuno ha fatto finora nel mondo dell’italiano come lingua straniera online.
Sono molto contento. Tra l’altro abbiamo già fatto, ad aprile, se ti ricordi, una sfida sul congiuntivo, che è stata super partecipata ed è piaciuta molto agli studenti. Quindi penso proprio che ti piacerà anche questa nuova sfida. Ti darò più dettagli molto presto, ma tu, se vuoi, nel frattempo puoi iscriverti alla lista d’attesa. Ti consiglio di farlo anche perché, così, avrai condizioni più vantaggiose rispetto a chi non si iscrive, dunque è una buona idea.
Ti lascio quest’altro codice QR per iscriverti alla lista d’attesa, oppure trovi il link in descrizione e tra i commenti. Non ho altro da dirti… alla prossima!
C’è una parola un po’ strana che, se impari l’italiano, potresti aver trovato in qualche grammatica, o magari in qualche lettura. Parlo di “egli”. “Egli” è un pronome soggetto, come si dice nella grammatica, ed è una parola che, in italiano moderno, praticamente non si usa più, ma che in passato si usava molto. La sua assenza ha, diciamo così, causato qualche problema, qualche imbarazzo, a volte, nell’ esprimere il pronome soggetto. Quindi guarda questo video perché… beh, è un aspetto fondamentale della grammatica.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
E lo faremo partendo dalla letteratura, dalla Grande Letteratura: partiamo dalla lingua di un grande poeta romantico dell’Ottocento per arrivare alla lingua parlata oggi. Partiamo, infatti, da Giacomo Leopardi, autore di poesie tra le più belle e studiate che siano mai state scritte nella nostra lingua, per parlare di pronomi soggetto, in particolare di quei pronomi che sono diventati nel tempo sempre più rari, fino, in alcuni casi, a scomparire del tutto, sia dalla lingua parlata che, a volte, dalla lingua scritta.
Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l’italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno, e ricorda che la trascrizione integrale di questo video, come di tutti i video, si trova sul mio sito. Ho anche preparato un PDF che riassume il contenuto di questa lezione. Puoi scaricarlo al link in descrizione, oppure scansionando questo codice QR. Dai un’occhiata perché il PDF è davvero un accompagnamento molto utile di tutte le lezioni che facciamo su YouTube.
Ah, e oggi ho anche un annuncio speciale che farò, però, dopo, alla fine del video, dunque guardalo tutto: non perderti l’annuncio!
Apriamo, dunque, un’opera in particolare di Giacomo Leopardi, lo Zibaldone di Pensieri, un’impresa di ben 4500 pagine, più di 60 quaderni scritti tra il 1817 e il 1832, e prepariamoci a quest’immersione nella sua lingua, una lingua comprensibile per un parlante dell’italiano contemporaneo, ma con alcuni tratti che la distanziano dalla lingua di oggi.
L’11 settembre 1821 Leopardi scriveva:
“L’uomo inesperto del mondo, come il giovane (…) sopravvenuto da qualche disgrazia o corporale o qualunque, dov’egli non abbia alcuna colpa, non pensa neppure che ciò debba essere agli altri oggetto di riso sul suo conto.”
In questo pensiero, sull’ingenuità e la purezza di chi ha ancora poca esperienza della vita, ci interessa, in questo video, quell’egli: un pronome che si riferisce al “giovane sopravvenuto da qualche disgrazia”. Ecco, in italiano contemporaneo, per riferirci al giovane in questione, avremmo usato il pronome soggetto “lui” oppure non avremmo usato un bel niente, omettendo, quindi, il pronome soggetto.
Passiamo ora al pensiero leopardiano del 15 dicembre 1826:
“L’invenzione del linguaggio, cosí com’ella è maravigliosissima, è pur comune a tutti i popoli, anche a’ piú separati e piú barbari.”
In questa seconda frase (un pensiero da linguista, in un certo senso) a interessarci è il pronome ella, che si riferisce in questo caso all’invenzione del linguaggio. “Ella” oggi non si userebbe più. Quale pronome allora useremmo nell’italiano contemporaneo al posto di “ella”? Non “lei”, in questo caso, perché “lei”, così come anche “lui”, si usano solo per riferirsi a entità animate, cioè vive, come persone o anche animali; dunque non funziona con “l’invenzione del linguaggio”, che non è né una persona né un animale, ma piuttosto un concetto.
Sai, allora, quale sarebbe la nostra soluzione più probabile? Non esprimere affatto il pronome, lasciarlo implicito, inespresso, ometterlo; usare quello che i linguisti chiamano “soggetto nullo” o “soggetto zero”. Diremmo, cioè, qualcosa di simile a:
“L’invenzione del linguaggio, se da un lato (Ø) è meravigliosa, dall’altro lato è comune a tutti i popoli.
Dove quel simboletto, no? Quello zero sbarrato “Ø” indica proprio il soggetto nullo. Questo è quello che si fa più spesso in italiano: non si scrive o non si dice proprio il pronome soggetto, ma si omette. Ne parliamo meglio dopo.
Passiamo ora al pensiero che Leopardi annota il 19 dicembre 1826:
“Il drammatico è ultimo dei tre generi, di tempo e di nobiltà. Esso non è un'ispirazione, ma un'invenzione; figlio della civiltà, non della natura.”
In questa frase ci interessa il pronome esso, che riprende “il (genere, sarebbe) drammatico”. Per quanto esso resista ancora oggi in alcune scritture molto formali e in alcuni linguaggi specialistici, è sempre più raro nell’italiano contemporaneo, in cui si tende a evitarlo, a sostituirlo con “questo” o “quello” o, più spesso, anche in questo caso, con niente, con un soggetto nullo.
Se Leopardi fosse nato oggi, probabilmente scriverebbe così:
“Il genere drammatico è l’ultimo tra i tre generi, per tempo e per nobiltà. Ø Non è un'ispirazione, ma un'invenzione.”
La stessa cosa vale anche per “essa”, “essi”, “esse”, che sono rispettivamente la forma femminile singolare, maschile plurale e femminile plurale di “esso”.
Ad esempio, il 23 luglio 1827 Leopardi scrive:
“I giovani non hanno patito nulla, non hanno idea sufficiente delle infelicità umane, le considerano quasi come illusioni, o certo come accidenti d’un altro mondo, perché essi non hanno negli occhi che felicità.”
In questo caso essi si riferisce a “i giovani che non hanno patito nulla”, cioè i giovani che non hanno sofferto. Rimanda, cioè, a delle persone. A “essi” e “esse”. Infatti, le forme plurali “essi” e “esse”, a differenza del singolare, quindi “esso” e “essa”, possono rimandare anche a referenti animati, a entità animate, quindi persone e animali.
Tentiamo, a questo punto, una sintesi di ciò che abbiamo scoperto immergendoci nel bellissimo italiano dello Zibaldone di Leopardi:
1. Uno: che i pronomi egli, ella, esso, essa al singolare e essi, esse al plurale si usavano in passato con la funzione di pronomi soggetto di terza persona, per riferirsi cioè a entità del mondo diverse sia dal parlante (io) o dai parlanti (quindi da noi) sia dall’ascoltatore o dagli ascoltatori (quindi tu o voi). Egli ed ella erano usati principalmente per entità animate; esso ed essa si usavano generalmente per entità inanimate, come idee, concetti, solo in casi particolari anche per persone in contesti formali o filosofici. Essi ed esse funzionavano come plurali di tutte le forme precedenti.
Nel successo di queste forme c’è lo zampino di un linguista del Cinquencento, famoso per aver prescritto le regole di buon uso della lingua italiana: sto parlando di Pietro Bembo, il quale, nella sua opera Prose della Volgar Lingua, sentenzia che i pronomi soggetto devono essere egli ed ella, e aggiunge che, se in qualche passo di Dante o Boccaccio compaiono esempi di “lui” (perché, insomma, è un fenomeno che già iniziava a svilupparsi anche all'epoca), beh, ciò accade per distrazione o, nelle sue parole, per “inavvertenza”. Certo che bisogna avere le palle per criticare l’italiano di Dante o di Boccaccio…
Comunque, a Bembo ho dedicato anche questo video se, per caso, ti interessa. Le prescrizioni di “egli”, “ella”, “essi” sono arrivati fino ai giorni nostri, nonostante, in realtà, questi pronomi non si usino nella lingua di tutti i giorni da molto tempo. Ecco, nonostante questo, ancora quando ho fatto le scuole elementari io, quindi poco meno di 20 anni fa, si imparavano ancora i verbi così (per esempio, il verbo essere: io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono). Chissà se oggi si insegnano ancora così o se si usa lui, lei e loro. Ecco, se qualche italiano all’ascolto insegna alle elementari, può lasciarmi un commento, perché io non lo so…non ne ho idea. Però, agli stranieri, normalmente, come sai, si insegnano lui lei e loro. Ma adesso ci arriviamo.
2. Punto due: ti può capitare di imbatterti in questi pronomi che oggi suonano decisamente “antichi” leggendo le opere di autori o autrici precedenti al Novecento, come ad esempio, oltre a Leopardi, Alessandro Manzoni, che nel suo capolavoro, I Promessi Sposi, scrive:
Egli entrò nella stanza con passo misurato.
Ella rimase muta, col capo chino.
O Ugo Foscolo, che nel suo celebre Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis scrive:
Ella non mi ama, e io l’adoro.
Egli è troppo grande per questa terra.
O, andando ancora più indietro, Ludovico Ariosto, che nell’Orlando furioso scrive:
Egli partì, pieno d’onore e gloria.
Ma anche:
Essa piangea la sorte sua, infelice.
Ah, a proposito di Manzoni (il primo degli autori che abbiamo citato, e di cui dovremmo parlare, prima o poi, su questo canale): c’è da riconoscergli il merito di essersi reso conto per primo che egli, ma anche ella, cominciava a suonare antico e artificiale; proprio per questo ha scritto e riscritto molte volte il suo capolavoro, I Promessi Sposi, nel tentativo di “svecchiare”, di rendere un po’ più moderna la lingua, anche dal punto di vista dei pronomi soggetto: così, nell’edizione del 1827 del suo romanzo egli ricorreva 862 volte; pensa, nel 1840, 13 anni dopo, le volte erano solo 64, di egli, con riferimento, spesso, a Dio; lui, che nel ‘27 non compariva mai come soggetto, nel ‘40 ricorreva 200 volte. Ma cosa sarà accaduto agli altri 500 egli? Beh, l’autore non ha fatto altro che quello che facciamo noi ancora oggi: ha semplicemente lasciato il soggetto implicito, inespresso, omesso. Cioè… lo ha tolto. L’esempio di Manzoni è poi stato seguito da molti scrittori dell’Ottocento e del Novecento.
3. Tre: nell’italiano contemporaneo i pronomi di cui abbiamo parlato non si usano più, ad eccezione, forse, di “egli”, che resiste nei registri molto formali (ad esempio negli scritti scientifici o giuridici). “Ella” è invece praticamente scomparso. Al posto di egli, ella, esso, essa, essi, i pronomi soggetto di terza persona che usiamo nell’italiano contemporaneo, soprattutto nel parlato, per riferirci ad entità animate sono:
lui per un’entità animata maschile singolare;
lei per un’entità animata femminile singolare;
loro al plurale, indifferentemente al maschile o femminile.
Questi, in origine, erano le forme usate per l’oggetto diretto, oppure anche indiretto, nello specifico le forme toniche, quindi “ho visto lui”, “ho visto lei”. Le forme come queste di sarebbero usate in casi come “è lui che ha mangiato la torta”: non si sarebbe mai detto “è egli”. Ecco perché ci sono, c’erano, casi in cui egli o ella o essi non si potevano usare, non funzionavano. È proprio per questo che, secondo i linguisti, questi pronomi hanno perso forza, e sono stati sostituiti invece da lui, lei, loro, che invece si possono usare in più casi.
Qual è il problema, però? Che lui, lei, loro, ad alcuni, possono sembrare leggermente informali, soprattutto in contesti un po’ più… appunto, più formali, come, ad esempio, la lingua scritta. Il che porta a un imbarazzo: da un lato egli, ella, esso, essa, essi che sanno davvero di vecchio, di antico; dall’altro abbiamo lui, lei, loro che si usano molto ma non sembrano adatti a tutti i contesti, soprattutto quelli più formali.
4. Se ciò che dobbiamo sostituire con il pronome non è un nome, ma è invece un’intera frase, ricorriamo a parole come “questo” o “ciò”, come nella frase che ora leggiamo:
“Leopardi elabora una visione profondamente pessimistica dell’esistenza, fondata sull’inesorabile conflitto tra desiderio e realtà: ciò emerge con particolare forza nello Zibaldone.”
In questa frase, ciò si riferisce alla parte sottolineata, e potrebbe essere sostituito dal pronome dimostrativo questo, oppure da il che, senza alcuna conseguenza dal punto di vista del significato; la frase, quindi, potrebbe essere riformulata come:
“Leopardi elabora una visione profondamente pessimistica dell’esistenza (…): questo emerge con particolare forza nello Zibaldone (oppure “… il che emerge con particolare forza nello Zibaldone).”
5. Punto cinque: abbiamo detto che oggi i pronomi soggetto che abbiamo a disposizione nell’italiano comune, di tutti i giorni, sono lui, lei, e loro. Ma, in realtà, quello che si fa più spesso in italiano è semplicemente omettere il pronome soggetto, come abbiamo detto (oppure, come dicono i linguisti, “usare un soggetto nullo, un soggetto zero”). L’italiano, come lo spagnolo e il portoghese, e al contrario del francese, inglese e tedesco, è una lingua in cui questo si può fare: il soggetto si può non esprimere. Questo accade tutte le volte che il riferimento del pronome (cioè la persona, animale, cosa a cui si riferisce) è facilmente recuperabile nel testo o nella situazione comunicativa. Che significa? Beh, se dico “parla italiano benissimo”, senza soggetto, capiamo dal verbo che il soggetto è un “lui” o una “lei”. Quale lui o lei? Beh:
- o si tratta di una persona che abbiamo appena menzionato nel testo o nella conversazione, quindi:
John mi ha sorpreso molto. Parla italiano benissimo!
(in cui “parla” si riferisce a John, che abbiamo appena menzionato);
- oppure, se John è qui, con me, nel luogo dove mi trovo io fisicamente, magari insieme ad altre persone, posso dire:
Guarda, parla benissimo!
Riferendomi, appunto, a John, che posso anche indicare. Insomma, non c’è bisogno di dire “LUI parla benissimo”, che è un po’ innaturale in italiano perché mette un’enfasi non necessaria. È un po’ come dire “proprio lui parla benissimo!”.Ci torniamo tra un secondo, ma prima osserva questo brano: tutti i simboli con lo zero “Ø” corrispondono a un soggetto nullo:Nello Zibaldone Leopardi riflette a lungo sulla natura del desiderio, (Ø) analizza la condizione dell’uomo moderno, (Ø) mette in discussione le illusioni del progresso, (Ø) propone una visione radicalmente pessimistica della realtà e (Ø) rifiuta ogni consolazione religiosa.Né egli, né lui. Niente. Questo perché il riferimento è chiaro: tutti i soggetti nulli si riferiscono allo stesso Leopardi, che è il soggetto menzionato all’inizio del testo.
6. Se in italiano la tendenza è questa, di omettere il soggetto, quali sono i contesti in cui l’omissione non si può fare, e invece dobbiamo esprimere il soggetto in maniera esplicita?
La risposta è: quando ciò è necessario o per evitare possibili ambiguità o per esprimere un contrasto, come nei seguenti esempi che riguardano ancora il nostro caro Giacomo Leopardi:
“Lui, a differenza di molti suoi contemporanei, non cerca consolazioni religiose o ideali.”
“Il romanticismo italiano ha cercato spesso speranza nella fede; lui, invece, ha guardato in faccia la disperazione.”
Oppure:
“Leopardi si allontana dagli altri romantici: mentre loro celebrano la nazione nascente, lui ne mette a nudo le fragilità e le illusioni.”
Ma se vuoi approfondire i casi in cui bisogna usare il pronome soggetto, beh, ti consiglio di dare un’occhiata a questo video, di qualche tempo fa; te lo lascio in descrizione, nel caso tu voglia approfondire. Oppure, ascolta quello che ho da dirti adesso: si, perché, all’inizio del video, ti ho promesso un annuncio speciale… ed eccolo qua.
A settembre inizierà una sfida: i pronomi personali. Una sfida è un corso incentrato su un argomento linguistico specifico, in questo caso pronomi personali. E quindi scoprirai tutti i segreti dietro a parole come tu, lui, lei, lo, la, gli, ci, vi, e combinazioni ostiche come te lo, glieli, se ne, ci si, lo si, se lo … i riflessivi, i verbi pronominali idiomatici, cavarsela, farcela… e molto altro ancora. Sarà un corso basato su un approccio grammaticale molto innovativo, qualcosa che nessuno ha fatto finora nel mondo dell’italiano come lingua straniera online.
Sono molto contento. Tra l’altro abbiamo già fatto, ad aprile, se ti ricordi, una sfida sul congiuntivo, che è stata super partecipata ed è piaciuta molto agli studenti. Quindi penso proprio che ti piacerà anche questa nuova sfida. Ti darò più dettagli molto presto, ma tu, se vuoi, nel frattempo puoi iscriverti alla lista d’attesa. Ti consiglio di farlo anche perché, così, avrai condizioni più vantaggiose rispetto a chi non si iscrive, dunque è una buona idea.
Ti lascio quest’altro codice QR per iscriverti alla lista d’attesa, oppure trovi il link in descrizione e tra i commenti. Non ho altro da dirti… alla prossima!




.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
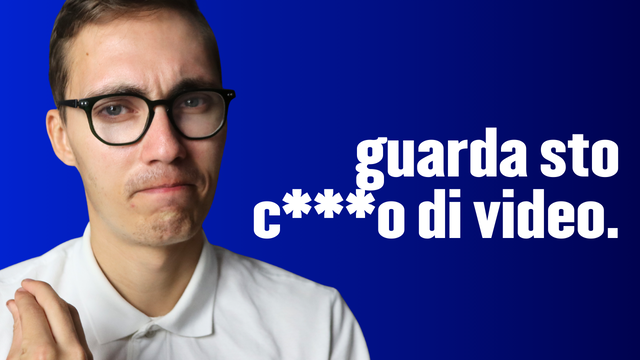
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)






























