5 STEREOTIPI sugli italiani
Gli italiani mangiano pasta tutti i giorni? Parlano l'italiano perfetto a Firenze? Sono tutti eleganti? In questo video analizzo 5 stereotipi comuni sugli italiani per capire quanto c'è di vero e quanto di falso. Scopriremo che molte idee diffuse all'estero (e anche in Italia!) non corrispondono alla realtà contemporanea.
Scarica il PDF gratuito con il riassunto della lezione
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
Noi italiani mangiamo spaghetti tutti i giorni, e lo facciamo indossando vestiti Armani e Dolce e Gabbana. Al ristorante, noi uomini non possiamo fare a meno di abbordare, con commenti piccanti, la vicina di tavolo che sta tranquillamente pranzando da sola, e questo perché siamo dei gran seduttori; e se siamo pure fiorentini, la seduciamo anche grazie alla nostra pronuncia perfetta.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Sì, forse questa è l’idea che hai in testa di noi italiani o, se non tu, i tuoi connazionali che sanno poco, a dire il vero, dell’Italia. Molti di voi mi chiedono se questi stereotipi sono veri, se gli italiani corrispondo a questi luoghi comuni. Molti non italiani pretendono di sapere come siamo fatti, noi italiani: come viviamo, come parliamo, come mangiamo, perfino come facciamo l’amore. E sentono la necessità di informare il resto del mondo su come siamo noi. E non mi riferisco soltanto a Madonna e al suo celebre Italians do it better, slogan del 1986 legato al video di Papa don’t preach, origine delle ansie da prestazione di molti maschi italiani; mi riferisco anche a persone famose di varie nazionalità e origini che, una volta entrati in contatto con gli italiani, hanno sentito la necessità anche loro di descriverli e definirli.
A partire da Winston Churchill, secondo cui “gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio”. Beh, la prima parte è sicuramente vera. Proseguendo con Catherine Deneuve, per la quale “gli italiani hanno solo due cose per la testa: l’altra sono gli spaghetti”. Passando per Jean Cocteau, secondo cui “gli italiani sono dei francesi di buon umore”. Ok. Concludendo con Wilhelm Mühs, che nota che “gli italiani si lamentano molto, quindi stanno bene”.
In questo video analizziamo 5 tra gli stereotipi, i miti, le leggende che circolano all’estero su noi italiani, per capire fino a che punto queste narrazioni reggono il confronto con la realtà, fino a che punto rispecchiano il vero e quanto, invece, contengono di fantasia.
Ah, io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l’italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. La trascrizione integrale è sul mio sito, podcastitaliano.com. Tra l’altro abbiamo rifatto questa sezione del sito, ora è molto più bella e facile da usare, quindi provala. Ho anche preparato, come sempre, un PDF che accompagna il video. Nel PDF troverai un quiz, una sorta di gioco che ti permetterà di metterti alla prova su questi e altri stereotipi italiani: quali sono veri e quali sono falsi. È un gioco divertente, sono sicuro che ti piacerà e ti permetterà di imparare molto. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR.
- Il primo mito che voglio mettere alla prova riguarda qualcosa che è al centro dei miei e dei tuoi interessi: la lingua italiana. Si dice, si sente dire, che “l’italiano standard è quello che si parla a Firenze”. Secondo questa idea, i fiorentini, ancora oggi, sette secoli dopo Dante, Petrarca e Boccaccio, continuerebbero a essere i detentori della varietà più prestigiosa, di italiano, anche a livello di pronuncia. Ma sarà davvero così?
Per rispondere, ascoltiamo qualche secondo di un intervento di Biancamaria Gismondi, laureata in Glottologia all’Università di Firenze, una parlante nativa che è probabile si trovi con una certa frequenza a esprimersi in contesti estremamente formali, in cui bisogna parlare un italiano forbito, controllato e standard. Nell’intervento in questione, Gismondi introduce una lezione sul rapporto tra italiano e fiorentino che sarà tenuta da Paolo d’Achille, il presidente dell’Accademia della Crusca, quindi è un contesto molto formale, ecco.
Nel corso dei suo studi, della sua carriera, il professor D’Achille si è occupato di moltissimi temi, riguardante la storia e l’evoluzione della lingua italiana, studiando in particolare rapporti tra il parlato e lo scritto. Più di recente, si è focalizzato soprattutto su aspetti dell’italiano contemporaneo…
Ecco, qualsiasi italiano che non conoscesse Gismondi e non sapesse che è nata a Firenze, vedendo questo video indovinerebbe subito, se non proprio che è fiorentina, almeno che è toscana, e lo indovinerebbe per il modo non-standard (nel senso contemporaneo del termine, ci torniamo fra un attimo), per il modo cioè fortemente caratterizzato come specifico di un luogo, di una regione e, per l’orecchio più raffinato, di una città, con cui pronuncia alcune parole o gruppi di parole.Per esempio dice “partiholare” al posto di “particolare”, “lessiho” al posto di “lessico”, “poho” al posto di “poco”. Questa C aspirata tra vocali è una delle caratteristiche più tipiche del fiorentino e del toscano. Ma poi anche “parlatho” al posto di “parlato” e “risherche” al posto di “ricerche”: tutte caratteristiche fonetiche tipicamente fiorentine e toscane, che popolarmente vengono chiamate gorgia toscana. Se vuoi approfondire l’accento fiorentino in molto più dettaglio, dai un’occhiata a questo video che ho fatto qualche anno fa.
Come insegnano i linguisti Sobrero e Miglietta, “nonostante i parlanti toscani siano molto sicuri di essere loro i padroni dello standard, (…) nel corso del Novecento la loro parlata ha perso prestigio. Di conseguenza, i tratti caratteristici di questa parlata, che fino alla prima metà del Novecento erano presentati nelle grammatiche come regole da seguire, (…) sono ora trattati come fenomeni locali e, fuori dalla Toscana, sono oggi percepiti come regionali (o provinciali).” Cioè, toscani, appunto.
A questo punto, viene da chiedersi: se lo standard contemporaneo, dal punto di vista della pronuncia, non è il fiorentino, allora qual è? La risposta a questa domanda richiede un video a parte che, buona notizia, ho già fatto! È questo. Qui mi limito, dunque, a ricordarti che l’italiano considerato “standard”, dal punto di vista fonologico e fonetico, è quello parlato da qualcuno di cui, ascoltandolo, non saremmo in grado di indovinare la provenienza regionale, di cui non sapremmo, cioè, dire da dove viene, in Italia. L’italiano degli attori di teatro, di alcuni attori del cinema, degli speaker radiofonici, di alcuni giornalisti televisivi, in generale di chi ha fatto corsi di dizione o di chi è cresciuto tra parlanti dello standard (per motivi professionali o di estrazione sociale), ha imparato lo standard, l’italiano neutro a livello di accento. Ma ti rimando a questo video, se vuoi saperne di più.
- Italia, Paese dell'eleganza; Milano, capitale della moda. Patria di Valentino, di Armani, Gucci, Dolce e Gabbana. In Italia, chiunque, anche chi non può permettersi di acquistare capi di abbigliamento nelle vie milanesi e romane dell’alta moda, gode comunque… come dire, dell’influsso positivo di una sorta di battesimo di stile, di battesimo del buon gusto, che gli deriva dal solo fatto di essere italiano o italiana. Ma è davvero così? Beh, camminando per le vie di alcune grandi città, prima tra tutte Milano, in effetti, si può avere l’impressione di trovarsi di fronte alla passerella di una sfilata di moda, di imbattersi in persone che prima di uscire di casa non hanno certo tirato fuori dall’armadio la prima cosa che si sono ritrovati in mano… come me.
Ma è davvero così per tutti gli italiani? Io stesso, lo confesso, considero il vestirmi bene l’ultima delle mie priorità, o poco ci manca. Ma io, forse, sono un caso a parte perché, bisogna dirlo, passo molto tempo a casa. Ma, al di là dell’esempio personale, andiamo ad analizzare alcuni fenomeni di costume che lasciano tracce anche nella lingua italiana, che negli ultimi decenni si è arricchita di parole come “tamarro” (termine meridionale, del Sud), “tascio” (parola siciliana), “truzzo” (parola settentrionale, del Nord), “maranza” (altra parola di origine meridionale) o “coatto” (usato molto a Roma).
Per capire a quale stile di abbigliamento si riferiscono queste parole, facciamo una semplice ricerca online. Cercando “tamarro” o “tamarra” otteniamo risultati come questi. Cercando, invece, “tascio” capiamo che non c’è grande differenza da “tamarro”. La diseleganza di tamarri e tasci segue, più o meno, gli stessi canoni: ostentazione della massa muscolare e del pelo del torace, predilezione per la canottiera rispetto alla t-shirt, vistose catene con croci, così grosse da sembrare rosari o ornamenti sacerdotali, e preferenza per materiali sintetici, pelle e similpelle.
Cercando “truzzo”, termine che si usava molto 15 anni fa, quando ero giovane io, ma che ora penso i giovani non usino affatto (e magari lo trovano pure “cringe”, non lo so)… dicevo, cercando truzzo, siamo in grado di concludere che anche il Nord non si fa mancare il kitsch, benché forse questo sia diversamente declinato in termini di colori forti, sneakers voluminose, occhiali da sole stravaganti, tagli di capelli sfilzati e pantaloni di taglie troppo larghe. Ai miei tempi (mi fa sentire vecchio questa espressione), se eri uomo, inoltre, era comune anche tenere i pantaloni così bassi da mettere in bella mostra le mutande. Un uso che, io, francamente, ho sempre trovato disgustoso. Un abominio. Però si faceva molto spesso, era… era la norma, alle scuole medie, quando facevo io le medie.
Un fenomeno di scarsa eleganza che merita un trattamento a parte è quello definito dal termine di origine milanese “maranza”, oggi il più comune, forse, per identificare questo tipo umano. L’Accademia della Crusca lo definisce così: “ragazzo, meno frequentemente, ragazza, che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d’abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare”.
Da questa definizione non si capisce benissimo in cosa il maranza si differenzi, dal punto di vista dell’abbigliamento, dal tamarro, dal tascio, dal truzzo. Di nuovo, Google può venire in nostro soccorso. Cercando “maranza” otteniamo risultati come questo. Il maranza è particolarmente affezionato ad un capo di vestiario, alla tuta, che sia di felpa o di acetato, di cui fa ampio uso del cappuccio, dentro il quale si nasconde più che può. Altri capi di abbigliamento tipici sono le maglie di squadre di calcio, le giacche smanicate, i cappellini con visiera, i borselli griffati (ma falsi) a indossati a tracolla, collane e orologi vistosi, nonché ciabatte, sempre griffate, abbinate a calzini. Dunque, se pensavi che noi italiani fossimo maestri di eleganza e stile… beh, ok, non voglio dire che lo stereotipo sia completamente falso, sia campato per aria, perché ha un fondo di verità, ma sappi che la realtà, come quasi sempre, è più complessa.
- Si parla sempre di questa Dolce Vita, ma cos’è, esattamente? Esiste davvero o è un mito? Io non l’ho ancora capito. Dolce Vita è un’espressione che indica uno stile di vita spensierato, agiato e dedito ai piaceri, come il buon cibo, l’arte, la cultura, il lusso e la bellezza. Il termine è diventato celebre grazie al film omonimo del 1960 di Federico Fellini, gigante del cinema italiano, che ritrae un'Italia, allora, vivacemente mondana, anche se già decadente. Chiediamoci: nell’Italia di oggi, gli italiani sono ancora dediti alla Dolce Vita (se lo sono mai stati, poi)? Passano ancora il loro tempo tra aperitivi e ristoranti di classe, musei e concerti, eventi e ricevimenti di lusso dove far sfoggio della loro arte del buon vivere? Se diamo un’occhiata ai dati Eurostat sulle ore lavorate in Italia dagli italiani, ci viene qualche dubbio sul fatto che a questi resti del tempo non solo per una vita dolce, ma anche semplicemente per un vita qualsiasi. Nel 2023 il 9,4% degli italiani ha trascorso, in media, più di 48 ore a settimana al lavoro. In media, nello stesso anno, gli italiani hanno trascorso 36,1 ore a settimana al lavoro. Decisamente più liberi degli italiani sono gli olandesi, che hanno la settimana lavorativa più corta d'Europa, con 32,2 ore, seguiti da vicino dagli austriaci, con 33,6 ore, e dai norvegesi, con 33,9 ore. Se sei di uno di questi Paesi, scrivi un commento e fammi sapere com’è lavorare nel tuo Paese, se è vera questa cosa.
Comunque, forse, se si vuole fare la Dolce Vita, più che Roma o Milano, si dovrebbe andare ad Amsterdam, o a Vienna, o a Oslo. Specialmente se si è donne: In Italia, le donne svolgono 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito, non pagato, di assistenza e cura al giorno, mentre gli uomini soltanto un’ora e 48 minuti. Le donne italiane, quindi, si fanno carico del 74% del totale delle ore di lavoro non retribuito di assistenza e cura. Nei Paesi vicini, la proporzione di lavoro non retribuito di assistenza svolto dalle donne è inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto all’Italia (in Francia è pari al 61% e in Germania al 62%). Quindi, donne all’ascolto: volete un fidanzato straniero con cui godervi la dolce vita? Eh, forse, tenetevi lontane dagli italiani e trovatevene uno francese o tedesco: avrete qualche probabilità di avere quantomeno un vita meno amara.
- Gli italiani, nella storia, nascono pastari e pastari moriranno. Sono pastari da sempre e sempre lo saranno. Ma è davvero così? Nella podcast Denominazione di Origine Inventata, Alberto Grandi, docente di Storia dell’Alimentazione all’Università di Parma, mette in discussione le origini della cucina italiana, sfatando quelle che definisce fake news e che riguardano alcuni dei cibi più comuni, ritenuti, “spesso a torto”, dice, tradizionali. Tra cui la pasta, appunto. Grandi sostiene che, fino al secolo scorso, gli italiani non mangiavano tanta pasta, il cui consumo si concentrava per lo più a Napoli, dove si era affermata a partire dalla metà del XVII secolo. La pasta era conosciuta anche in Sicilia, ma non era diffusa come nel capoluogo campano. E al Nord, praticamente, era sconosciuta.
“Gli italiani non originari di Napoli e della Sicilia hanno conosciuto la pasta quando sono emigrati in America e hanno iniziato a cucinarla perché era un alimento molto comodo, economico, facile da preparare e da conservare”, osserva Grandi. “Così la pasta è diventata il cibo per eccellenza degli italiani. I primi pastifici industriali sono nati negli Stati Uniti e a Genova, città che, all’epoca, produceva una gran quantità di pasta destinata agli emigrati italiani».
Dunque, pastari sì (ne consumiamo in media 23 kg pro capite all’anno), ma non da sempre, e non tutti allo stesso modo. Comunque, ai miti gastronomici, alle bufale che raccontiamo sulla cucina italiana (che sono moltissime) ho dedicato un intero episodio del corso avanzato Dentro l’Italia, un corso di lingua che, da un lato affronta e cerca di spiegare l’Italia di oggi attraverso i fenomeni culturali e sociali dell’Italia del Novecento (soprattutto quella del secondo dopoguerra), e che dall’altro è un vero e proprio corso di lingua, e quindi ti insegna le strutture grammaticali che devi sapere al livello C1. Quindi un livello avanzato. Se vuoi dare un’occhiata a Dentro l’Italia, ti lascio il link nella descrizione del video.
- Gli italiani sono passionali, sono dei gran seduttori.
La lingua italiana sembrerebbe confermarlo. Esiste nel vocabolario dell’italiano un gran numero di parole per riferirsi al maschio seduttore, alcune di queste, anche di origine straniera: casanova, dongiovanni, donnaiolo, playboy, conquistatore, bellimbusto, tombeur de femmes, cicisbeo, gigolò.
Chiediamoci, anche in questo caso, quanto ci sia di vero in questa rappresentazione del maschio italiano come macchina di conquista e stallone del sesso. Ci vengono in aiuto alcuni articoli di giornale. In un’inchiesta del 19 settembre 2022, L’Espresso allertava sulla crescita della “generazione dei senza desiderio”. In un articolo di Nina Verdelli, pubblicato su Vanity Fair l’8 febbraio 2023, si scopre che l’ultimo rapporto Censis-Bayer sui comportamenti sessuali degli italiani rileva che 1,6 milioni di persone tra i 18 e i 40 anni non fanno sesso. A questi vanno aggiunte le 220 mila “coppie bianche”, ossia con relazioni affettive stabili ma senza alcun rapporto sessuale, e le 700 mila che dichiarano di non essere interessate al sesso in questo momento.
Lo psicanalista Luigi Zoja, che a questo tema ha dedicato il suo ultimo saggio, Il declino del desiderio, spiega le ragioni di questa recessione con una metafora: “di fronte alle sempre maggiori libertà sessuali che la società civile ha conquistato, dagli anni ’70 in poi, l’uomo si ritira impaurito come uno scalatore che, arrivato in alto, si spaventa per l’abisso che proprio lui aveva voluto sfidare”. Insomma: se venite in Italia alla ricerca di avventure, soprattutto se siete più giovani, potreste, forse, essere deluse, non lo so.
Concludo così: gli stereotipi fanno parte della natura umana e saperci ridere su, sapendo fare auto-ironia, quando sono stereotipi un po’ negativi, è importante. Non bisogna essere troppo permalosi. E, secondo me, gli italiani, a volte, lo sono. Per esempio, qualche tempo fa, si sono incazzati per la canzone del caffè macchiato… cos’era? Una canzone estone… dell’Eurovision, che aveva un sacco di stereotipi. Ma va bene, è per divertirsi! A me non importa niente. Il problema è quando gli stereotipi portano le persone a credere a idee sbagliate o poco accurate, ecco. Ed è in questo caso, secondo me, che diventa necessario fare chiarezza. Spero di esserci riuscito.
Ma, a questo proposito, sono curioso di sapere da te: quali sorprese ti ha riservato questo video? Cosa non avresti mai sospettato, cosa hai scoperto da me? E come ti senti ora che la verità è stata riportata a galla?
Raccontaci anche, se vuoi, le tue esperienze personali di incontro con fatti o persone d’Italia che non confermano, o che confermano, gli stereotipi. Mi interessa. Ti aspetto nei commenti! Ora, se invece vuoi metterti alla prova con il gioco che abbiamo preparato per te, questo quiz che ti permetterà di metterti alla prova su questi e altri stereotipi italiani e scoprire molte cose che non conoscevi, scarica il PDF. Ti aiuterà a evitare brutte figure nel tuo prossimo viaggio, o almeno spero. Questo è tutto: alla prossima!
Noi italiani mangiamo spaghetti tutti i giorni, e lo facciamo indossando vestiti Armani e Dolce e Gabbana. Al ristorante, noi uomini non possiamo fare a meno di abbordare, con commenti piccanti, la vicina di tavolo che sta tranquillamente pranzando da sola, e questo perché siamo dei gran seduttori; e se siamo pure fiorentini, la seduciamo anche grazie alla nostra pronuncia perfetta.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Sì, forse questa è l’idea che hai in testa di noi italiani o, se non tu, i tuoi connazionali che sanno poco, a dire il vero, dell’Italia. Molti di voi mi chiedono se questi stereotipi sono veri, se gli italiani corrispondo a questi luoghi comuni. Molti non italiani pretendono di sapere come siamo fatti, noi italiani: come viviamo, come parliamo, come mangiamo, perfino come facciamo l’amore. E sentono la necessità di informare il resto del mondo su come siamo noi. E non mi riferisco soltanto a Madonna e al suo celebre Italians do it better, slogan del 1986 legato al video di Papa don’t preach, origine delle ansie da prestazione di molti maschi italiani; mi riferisco anche a persone famose di varie nazionalità e origini che, una volta entrati in contatto con gli italiani, hanno sentito la necessità anche loro di descriverli e definirli.
A partire da Winston Churchill, secondo cui “gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio”. Beh, la prima parte è sicuramente vera. Proseguendo con Catherine Deneuve, per la quale “gli italiani hanno solo due cose per la testa: l’altra sono gli spaghetti”. Passando per Jean Cocteau, secondo cui “gli italiani sono dei francesi di buon umore”. Ok. Concludendo con Wilhelm Mühs, che nota che “gli italiani si lamentano molto, quindi stanno bene”.
In questo video analizziamo 5 tra gli stereotipi, i miti, le leggende che circolano all’estero su noi italiani, per capire fino a che punto queste narrazioni reggono il confronto con la realtà, fino a che punto rispecchiano il vero e quanto, invece, contengono di fantasia.
Ah, io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l’italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. La trascrizione integrale è sul mio sito, podcastitaliano.com. Tra l’altro abbiamo rifatto questa sezione del sito, ora è molto più bella e facile da usare, quindi provala. Ho anche preparato, come sempre, un PDF che accompagna il video. Nel PDF troverai un quiz, una sorta di gioco che ti permetterà di metterti alla prova su questi e altri stereotipi italiani: quali sono veri e quali sono falsi. È un gioco divertente, sono sicuro che ti piacerà e ti permetterà di imparare molto. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR.
- Il primo mito che voglio mettere alla prova riguarda qualcosa che è al centro dei miei e dei tuoi interessi: la lingua italiana. Si dice, si sente dire, che “l’italiano standard è quello che si parla a Firenze”. Secondo questa idea, i fiorentini, ancora oggi, sette secoli dopo Dante, Petrarca e Boccaccio, continuerebbero a essere i detentori della varietà più prestigiosa, di italiano, anche a livello di pronuncia. Ma sarà davvero così?
Per rispondere, ascoltiamo qualche secondo di un intervento di Biancamaria Gismondi, laureata in Glottologia all’Università di Firenze, una parlante nativa che è probabile si trovi con una certa frequenza a esprimersi in contesti estremamente formali, in cui bisogna parlare un italiano forbito, controllato e standard. Nell’intervento in questione, Gismondi introduce una lezione sul rapporto tra italiano e fiorentino che sarà tenuta da Paolo d’Achille, il presidente dell’Accademia della Crusca, quindi è un contesto molto formale, ecco.
Nel corso dei suo studi, della sua carriera, il professor D’Achille si è occupato di moltissimi temi, riguardante la storia e l’evoluzione della lingua italiana, studiando in particolare rapporti tra il parlato e lo scritto. Più di recente, si è focalizzato soprattutto su aspetti dell’italiano contemporaneo…
Ecco, qualsiasi italiano che non conoscesse Gismondi e non sapesse che è nata a Firenze, vedendo questo video indovinerebbe subito, se non proprio che è fiorentina, almeno che è toscana, e lo indovinerebbe per il modo non-standard (nel senso contemporaneo del termine, ci torniamo fra un attimo), per il modo cioè fortemente caratterizzato come specifico di un luogo, di una regione e, per l’orecchio più raffinato, di una città, con cui pronuncia alcune parole o gruppi di parole.Per esempio dice “partiholare” al posto di “particolare”, “lessiho” al posto di “lessico”, “poho” al posto di “poco”. Questa C aspirata tra vocali è una delle caratteristiche più tipiche del fiorentino e del toscano. Ma poi anche “parlatho” al posto di “parlato” e “risherche” al posto di “ricerche”: tutte caratteristiche fonetiche tipicamente fiorentine e toscane, che popolarmente vengono chiamate gorgia toscana. Se vuoi approfondire l’accento fiorentino in molto più dettaglio, dai un’occhiata a questo video che ho fatto qualche anno fa.
Come insegnano i linguisti Sobrero e Miglietta, “nonostante i parlanti toscani siano molto sicuri di essere loro i padroni dello standard, (…) nel corso del Novecento la loro parlata ha perso prestigio. Di conseguenza, i tratti caratteristici di questa parlata, che fino alla prima metà del Novecento erano presentati nelle grammatiche come regole da seguire, (…) sono ora trattati come fenomeni locali e, fuori dalla Toscana, sono oggi percepiti come regionali (o provinciali).” Cioè, toscani, appunto.
A questo punto, viene da chiedersi: se lo standard contemporaneo, dal punto di vista della pronuncia, non è il fiorentino, allora qual è? La risposta a questa domanda richiede un video a parte che, buona notizia, ho già fatto! È questo. Qui mi limito, dunque, a ricordarti che l’italiano considerato “standard”, dal punto di vista fonologico e fonetico, è quello parlato da qualcuno di cui, ascoltandolo, non saremmo in grado di indovinare la provenienza regionale, di cui non sapremmo, cioè, dire da dove viene, in Italia. L’italiano degli attori di teatro, di alcuni attori del cinema, degli speaker radiofonici, di alcuni giornalisti televisivi, in generale di chi ha fatto corsi di dizione o di chi è cresciuto tra parlanti dello standard (per motivi professionali o di estrazione sociale), ha imparato lo standard, l’italiano neutro a livello di accento. Ma ti rimando a questo video, se vuoi saperne di più.
- Italia, Paese dell'eleganza; Milano, capitale della moda. Patria di Valentino, di Armani, Gucci, Dolce e Gabbana. In Italia, chiunque, anche chi non può permettersi di acquistare capi di abbigliamento nelle vie milanesi e romane dell’alta moda, gode comunque… come dire, dell’influsso positivo di una sorta di battesimo di stile, di battesimo del buon gusto, che gli deriva dal solo fatto di essere italiano o italiana. Ma è davvero così? Beh, camminando per le vie di alcune grandi città, prima tra tutte Milano, in effetti, si può avere l’impressione di trovarsi di fronte alla passerella di una sfilata di moda, di imbattersi in persone che prima di uscire di casa non hanno certo tirato fuori dall’armadio la prima cosa che si sono ritrovati in mano… come me.
Ma è davvero così per tutti gli italiani? Io stesso, lo confesso, considero il vestirmi bene l’ultima delle mie priorità, o poco ci manca. Ma io, forse, sono un caso a parte perché, bisogna dirlo, passo molto tempo a casa. Ma, al di là dell’esempio personale, andiamo ad analizzare alcuni fenomeni di costume che lasciano tracce anche nella lingua italiana, che negli ultimi decenni si è arricchita di parole come “tamarro” (termine meridionale, del Sud), “tascio” (parola siciliana), “truzzo” (parola settentrionale, del Nord), “maranza” (altra parola di origine meridionale) o “coatto” (usato molto a Roma).
Per capire a quale stile di abbigliamento si riferiscono queste parole, facciamo una semplice ricerca online. Cercando “tamarro” o “tamarra” otteniamo risultati come questi. Cercando, invece, “tascio” capiamo che non c’è grande differenza da “tamarro”. La diseleganza di tamarri e tasci segue, più o meno, gli stessi canoni: ostentazione della massa muscolare e del pelo del torace, predilezione per la canottiera rispetto alla t-shirt, vistose catene con croci, così grosse da sembrare rosari o ornamenti sacerdotali, e preferenza per materiali sintetici, pelle e similpelle.
Cercando “truzzo”, termine che si usava molto 15 anni fa, quando ero giovane io, ma che ora penso i giovani non usino affatto (e magari lo trovano pure “cringe”, non lo so)… dicevo, cercando truzzo, siamo in grado di concludere che anche il Nord non si fa mancare il kitsch, benché forse questo sia diversamente declinato in termini di colori forti, sneakers voluminose, occhiali da sole stravaganti, tagli di capelli sfilzati e pantaloni di taglie troppo larghe. Ai miei tempi (mi fa sentire vecchio questa espressione), se eri uomo, inoltre, era comune anche tenere i pantaloni così bassi da mettere in bella mostra le mutande. Un uso che, io, francamente, ho sempre trovato disgustoso. Un abominio. Però si faceva molto spesso, era… era la norma, alle scuole medie, quando facevo io le medie.
Un fenomeno di scarsa eleganza che merita un trattamento a parte è quello definito dal termine di origine milanese “maranza”, oggi il più comune, forse, per identificare questo tipo umano. L’Accademia della Crusca lo definisce così: “ragazzo, meno frequentemente, ragazza, che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d’abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare”.
Da questa definizione non si capisce benissimo in cosa il maranza si differenzi, dal punto di vista dell’abbigliamento, dal tamarro, dal tascio, dal truzzo. Di nuovo, Google può venire in nostro soccorso. Cercando “maranza” otteniamo risultati come questo. Il maranza è particolarmente affezionato ad un capo di vestiario, alla tuta, che sia di felpa o di acetato, di cui fa ampio uso del cappuccio, dentro il quale si nasconde più che può. Altri capi di abbigliamento tipici sono le maglie di squadre di calcio, le giacche smanicate, i cappellini con visiera, i borselli griffati (ma falsi) a indossati a tracolla, collane e orologi vistosi, nonché ciabatte, sempre griffate, abbinate a calzini. Dunque, se pensavi che noi italiani fossimo maestri di eleganza e stile… beh, ok, non voglio dire che lo stereotipo sia completamente falso, sia campato per aria, perché ha un fondo di verità, ma sappi che la realtà, come quasi sempre, è più complessa.
- Si parla sempre di questa Dolce Vita, ma cos’è, esattamente? Esiste davvero o è un mito? Io non l’ho ancora capito. Dolce Vita è un’espressione che indica uno stile di vita spensierato, agiato e dedito ai piaceri, come il buon cibo, l’arte, la cultura, il lusso e la bellezza. Il termine è diventato celebre grazie al film omonimo del 1960 di Federico Fellini, gigante del cinema italiano, che ritrae un'Italia, allora, vivacemente mondana, anche se già decadente. Chiediamoci: nell’Italia di oggi, gli italiani sono ancora dediti alla Dolce Vita (se lo sono mai stati, poi)? Passano ancora il loro tempo tra aperitivi e ristoranti di classe, musei e concerti, eventi e ricevimenti di lusso dove far sfoggio della loro arte del buon vivere? Se diamo un’occhiata ai dati Eurostat sulle ore lavorate in Italia dagli italiani, ci viene qualche dubbio sul fatto che a questi resti del tempo non solo per una vita dolce, ma anche semplicemente per un vita qualsiasi. Nel 2023 il 9,4% degli italiani ha trascorso, in media, più di 48 ore a settimana al lavoro. In media, nello stesso anno, gli italiani hanno trascorso 36,1 ore a settimana al lavoro. Decisamente più liberi degli italiani sono gli olandesi, che hanno la settimana lavorativa più corta d'Europa, con 32,2 ore, seguiti da vicino dagli austriaci, con 33,6 ore, e dai norvegesi, con 33,9 ore. Se sei di uno di questi Paesi, scrivi un commento e fammi sapere com’è lavorare nel tuo Paese, se è vera questa cosa.
Comunque, forse, se si vuole fare la Dolce Vita, più che Roma o Milano, si dovrebbe andare ad Amsterdam, o a Vienna, o a Oslo. Specialmente se si è donne: In Italia, le donne svolgono 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito, non pagato, di assistenza e cura al giorno, mentre gli uomini soltanto un’ora e 48 minuti. Le donne italiane, quindi, si fanno carico del 74% del totale delle ore di lavoro non retribuito di assistenza e cura. Nei Paesi vicini, la proporzione di lavoro non retribuito di assistenza svolto dalle donne è inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto all’Italia (in Francia è pari al 61% e in Germania al 62%). Quindi, donne all’ascolto: volete un fidanzato straniero con cui godervi la dolce vita? Eh, forse, tenetevi lontane dagli italiani e trovatevene uno francese o tedesco: avrete qualche probabilità di avere quantomeno un vita meno amara.
- Gli italiani, nella storia, nascono pastari e pastari moriranno. Sono pastari da sempre e sempre lo saranno. Ma è davvero così? Nella podcast Denominazione di Origine Inventata, Alberto Grandi, docente di Storia dell’Alimentazione all’Università di Parma, mette in discussione le origini della cucina italiana, sfatando quelle che definisce fake news e che riguardano alcuni dei cibi più comuni, ritenuti, “spesso a torto”, dice, tradizionali. Tra cui la pasta, appunto. Grandi sostiene che, fino al secolo scorso, gli italiani non mangiavano tanta pasta, il cui consumo si concentrava per lo più a Napoli, dove si era affermata a partire dalla metà del XVII secolo. La pasta era conosciuta anche in Sicilia, ma non era diffusa come nel capoluogo campano. E al Nord, praticamente, era sconosciuta.
“Gli italiani non originari di Napoli e della Sicilia hanno conosciuto la pasta quando sono emigrati in America e hanno iniziato a cucinarla perché era un alimento molto comodo, economico, facile da preparare e da conservare”, osserva Grandi. “Così la pasta è diventata il cibo per eccellenza degli italiani. I primi pastifici industriali sono nati negli Stati Uniti e a Genova, città che, all’epoca, produceva una gran quantità di pasta destinata agli emigrati italiani».
Dunque, pastari sì (ne consumiamo in media 23 kg pro capite all’anno), ma non da sempre, e non tutti allo stesso modo. Comunque, ai miti gastronomici, alle bufale che raccontiamo sulla cucina italiana (che sono moltissime) ho dedicato un intero episodio del corso avanzato Dentro l’Italia, un corso di lingua che, da un lato affronta e cerca di spiegare l’Italia di oggi attraverso i fenomeni culturali e sociali dell’Italia del Novecento (soprattutto quella del secondo dopoguerra), e che dall’altro è un vero e proprio corso di lingua, e quindi ti insegna le strutture grammaticali che devi sapere al livello C1. Quindi un livello avanzato. Se vuoi dare un’occhiata a Dentro l’Italia, ti lascio il link nella descrizione del video.
- Gli italiani sono passionali, sono dei gran seduttori.
La lingua italiana sembrerebbe confermarlo. Esiste nel vocabolario dell’italiano un gran numero di parole per riferirsi al maschio seduttore, alcune di queste, anche di origine straniera: casanova, dongiovanni, donnaiolo, playboy, conquistatore, bellimbusto, tombeur de femmes, cicisbeo, gigolò.
Chiediamoci, anche in questo caso, quanto ci sia di vero in questa rappresentazione del maschio italiano come macchina di conquista e stallone del sesso. Ci vengono in aiuto alcuni articoli di giornale. In un’inchiesta del 19 settembre 2022, L’Espresso allertava sulla crescita della “generazione dei senza desiderio”. In un articolo di Nina Verdelli, pubblicato su Vanity Fair l’8 febbraio 2023, si scopre che l’ultimo rapporto Censis-Bayer sui comportamenti sessuali degli italiani rileva che 1,6 milioni di persone tra i 18 e i 40 anni non fanno sesso. A questi vanno aggiunte le 220 mila “coppie bianche”, ossia con relazioni affettive stabili ma senza alcun rapporto sessuale, e le 700 mila che dichiarano di non essere interessate al sesso in questo momento.
Lo psicanalista Luigi Zoja, che a questo tema ha dedicato il suo ultimo saggio, Il declino del desiderio, spiega le ragioni di questa recessione con una metafora: “di fronte alle sempre maggiori libertà sessuali che la società civile ha conquistato, dagli anni ’70 in poi, l’uomo si ritira impaurito come uno scalatore che, arrivato in alto, si spaventa per l’abisso che proprio lui aveva voluto sfidare”. Insomma: se venite in Italia alla ricerca di avventure, soprattutto se siete più giovani, potreste, forse, essere deluse, non lo so.
Concludo così: gli stereotipi fanno parte della natura umana e saperci ridere su, sapendo fare auto-ironia, quando sono stereotipi un po’ negativi, è importante. Non bisogna essere troppo permalosi. E, secondo me, gli italiani, a volte, lo sono. Per esempio, qualche tempo fa, si sono incazzati per la canzone del caffè macchiato… cos’era? Una canzone estone… dell’Eurovision, che aveva un sacco di stereotipi. Ma va bene, è per divertirsi! A me non importa niente. Il problema è quando gli stereotipi portano le persone a credere a idee sbagliate o poco accurate, ecco. Ed è in questo caso, secondo me, che diventa necessario fare chiarezza. Spero di esserci riuscito.
Ma, a questo proposito, sono curioso di sapere da te: quali sorprese ti ha riservato questo video? Cosa non avresti mai sospettato, cosa hai scoperto da me? E come ti senti ora che la verità è stata riportata a galla?
Raccontaci anche, se vuoi, le tue esperienze personali di incontro con fatti o persone d’Italia che non confermano, o che confermano, gli stereotipi. Mi interessa. Ti aspetto nei commenti! Ora, se invece vuoi metterti alla prova con il gioco che abbiamo preparato per te, questo quiz che ti permetterà di metterti alla prova su questi e altri stereotipi italiani e scoprire molte cose che non conoscevi, scarica il PDF. Ti aiuterà a evitare brutte figure nel tuo prossimo viaggio, o almeno spero. Questo è tutto: alla prossima!


.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
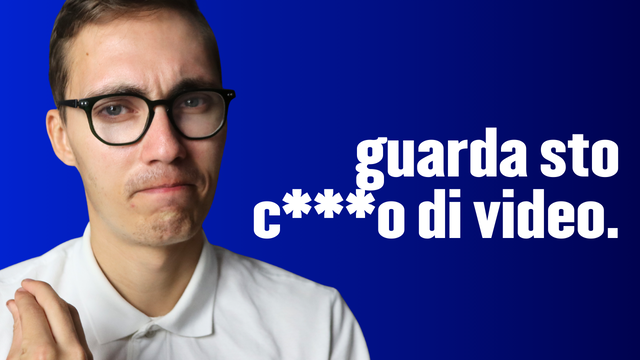
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)
































