Quanto sei MALEDUCATO in italiano? TEST
In questo video metto alla prova la tua capacità di usare l'italiano in modo appropriato nelle diverse situazioni sociali. Attraverso 7 scenari pratici, scoprirai se sai davvero "agire" in italiano, non solo parlarlo.
Scarica il PDF gratuito con il riassunto della lezione
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
“Guardati ‘sto video e zitto, co*ne!”
Cosa? Come?
No, non chiudere il video! Non sono impazzito... del tutto.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Ho iniziato il video così per offrirti un esempio estremo, caricaturale di come NON si usa l’italiano, di come non AGIRE in italiano (e forse in nessuna lingua). In che senso “agire”?
Quando usi il linguaggio, quindi quando parli qualsiasi lingua, non solo “dici” qualcosa, ma “fai” anche qualcosa. Compi, cioè, degli atti, delle azioni che generano conseguenze sull’altro o sull’altra che ti ascolta. E dunque non è poi così vero, forse, che le parole e i fatti sono sempre contrapposti.
Facendo esempi meno bizzarri, chi pronuncia la frase “vi dichiaro marito e moglie” non si limita ad affermare qualcosa, a raccontarla o a descriverla (come quando scriviamo tra i commenti “Podcast Italiano è il miglior canale per imparare l’italiano”), ma compie un’azione linguistica, appunto, che genera conseguenze concrete: quelle due persone, da quel momento in poi, sono sposate.
Questa frase ha il potere di cambiare la realtà, in qualche modo. Non è una figata?
Oppure chi pronuncia la frase “prometto che domani sarò puntuale” non fa solo un’affermazione, ma genera delle attese, delle aspettative.
O ancora, chi pronuncia la frase “ti ordino di andartene” può generare una tra due conseguenze: o mi ubbidisci o mi disubbidisci. Quale scegli?
Ho pensato a questo quiz per aiutarti a capire quanto te la cavi tu nel compiere azioni linguistiche in italiano. Per esempio, fare una richiesta, rifiutare un invito, fare una critica, una promessa, una domanda, rispondere a una domanda. Vedi, questo è un argomento molto importante in una lingua straniera e cultura straniera, dove, per differenze linguistiche e culturali, si può rischiare di dire cose inappropriate e di risultare poco simpatici, o scortesi, offensivi, strani… e via dicendo.
Ah, io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l’italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. Poi, ricorda che la trascrizione integrale si trova sul mio sito, podcastitaliano.com, e che ho preparato un PDF che accompagna il quiz. Potrai usarlo per dare un’occhiata a tutte le domande mentre guardi il video e controllare le risposte, che saranno accompagnate anche da altri esempi. Ti consiglio di stamparlo, a proposito, perché ti tornerà molto utile. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR.
Dunque, ti farò 7 domande.
Per ogni domanda, fai molta attenzione alla descrizione che ti darò della situazione.
Il test, in totale, vale 7 punti, e guadagnerai 1 punto per ogni risposta esatta.
Pronto? Pronta? Andiamo!
1) SITUAZIONE: Due colleghi condividono lo stesso ufficio. Il primo collega sta parlando al telefono con un cliente a voce troppo alta. Il secondo collega ne è disturbato. Cosa dice il secondo collega al primo?
A. “Vengo, con la presente, a chiederle cortesemente di abbassare il volume della Sua voce.”
B. “Non è che, gentilmente, abbasseresti la voce? È che mi deconcentro, se no.”
C. "Abbassa immediatamente ‘sta cazzo di voce."
Ok, questa era facile, vero? La risposta appropriata è B. In B, la richiesta viene mitigata, viene “addolcita” con una costruzione nota, tecnicamente, come frase scissa , usata due volte (non è che… e è che…); ma anche alla formula di cortesia “gentilmente”, all’uso del condizionale (”abbasseresti”), alla giustificazione (”mi deconcentro così”). Massimo dei voti.
La risposta A, invece, è inappropriata perché è troppo formale: così si elaborano solo richieste scritte, molto formali, in contesti burocratici: vedi il video sul burocratese. Non ci si rivolgerebbe mai così nel parlato a un proprio pari con cui si è in intimità.
La risposta C, invece, non va bene perché la richiesta è troppo diretta. Innanzitutto, ricorre al modo imperativo che, in italiano, già di per sé, è spesso troppo diretto. Inoltre, è resa più aggressiva dall’intensificatore “immediatamente”, e dalla parolaccia “ ‘sta cazzo di voce”. Ok, spero che questa non l’abbia scelta nessuno, se no… inizio a preoccuparmi.
Segnati un punto sul foglio se hai indovinato.
2) OK. SITUAZIONE: Uno studente universitario scrive un’e-mail al proprio professore, per chiedergli aiuto nella preparazione di un esame. Quale formulazione è appropriata alla relazione tra i parlanti ma anche appropriata all’obiettivo della comunicazione?
A. "Ciao prof, tutto ok? Ho bisogno che mi dai una mano con l'esame.”
B. "Buongiorno professore, come sta? Mi aiuta con l’esame?”
C. "Buongiorno professore, spero di trovarla bene. Le vorrei chiedere se cortesemente potrebbe aiutarmi con l’esame. Ho perso alcune lezioni e non riesco a comprendere alcune parti del programma.”
SOLUZIONE: la risposta appropriata è C. Beh, anche questa era facile, vero? La risposta A, in cui si usa il “tu”, l’abbreviazione “prof” e l’espressione colloquiale “dare una mano” è troppo informale rispetto alla relazione gerarchica tra studente e professore. Insomma, mica siamo al bar.
La risposta B è un pochino meglio di A, perché dal “ciao” si passa al “buongiorno” (ricorda che ”ciao” in italiano è informale, quindi fai attenzione, se non vuoi essere informale!), e dal “tu” si passa anche al “Lei”. Il “come sta?” risulta ancora troppo informale nella lingua scritta, anche se usa il Lei. Inoltre, la richiesta di aiuto, “mi aiuta con l’esame”, è formulata in maniera troppo diretta.
La risposta C è appropriata per la scelta del “Lei” di cortesia, perché dimostra interesse per il professore (probabilmente interesse falso, ma non importa), cioè quel “spero di trovarla bene”, perché è resa meno diretta da formule come come “le vorrei chiedere se cortesemente potrebbe…”, e perché contiene una giustificazione, “ho perso alcune lezioni e non riesco a comprendere alcune parti del programma”.
Hai indovinato? Di nuovo, un punto. Segnatelo, mi raccomando, perché poi voglio sapere quanti punti fai.
3) SITUAZIONE: Due amici, Giulio e Stefano, stanno conversando durante una cena. Ecco che cosa si dicono:
Giulio: "Stavo dicendo che ieri sono andato a…"
Stefano: "Ah sì, anch’io sono andato in centro!"
Perché il comportamento linguistico di Stefano è inappropriato?
A. Perché anticipa Giulio.
B. Perché interrompe Giulio.
C. Perché fraintende Giulio.
La risposta è B: Stefano interrompe Giulio prima che questo finisca la sua frase. Così Stefano vìola una norma implicita della conversazione, in particolare quella relativa alla gestione dei turni di parola (cioè chi parla in ciascun momento), che dice: “aspetta il tuo turno di parola, non parlare prima che l’altro abbia terminato il suo turno”. Interrompere le altre persone non è scortese allo stesso modo in tutte le culture, e in italiano probabilmente è più comune che in altre lingue e altre culture: insomma, in italiano, a volte, ci parliamo un po’ addosso, ecco, soprattutto dalla prospettiva… che ne so, di un finlandese, per esempio. Tuttavia, in questo caso l’interruzione non è il massimo, anzi, è abbastanza antipatica. Non va bene.
Un punto, se hai indovinato.
4) Due amici, Angelo e Alessio, stanno facendo aperitivo al bar. Ecco che cosa si dicono:
Angelo: "Ieri sono andato a un concerto con mio fratello e il suo amico Marco. Prima mi ha mandato un messaggio dicendomi che ci avrebbe raggiunti più tardi, forse per cena."
Alessio: "Ma chi vuole raggiungerci? Tuo fratello o l’amico?"
Perché Alessio è confuso?
A. Angelo usa un verbo alla terza persona “ha detto” con soggetto implicito. Non è chiaro a chi si riferisca questo soggetto, se a “mio fratello” o “al suo amico Marco”, e ciò crea ambiguità.
B. Angelo usa dei pronomi personali, “mi” e “ci”, che non è chiaro a chi si riferiscano.
C. Al posto del verbo alla terza persona singolare “ha detto”, Angelo avrebbe dovuto usare un verbo alla terza persona plurale, “hanno detto”, per includere sia il fratello che il suo amico Marco.
La risposta è A. Qui, l’azione linguistica di Angelo non è appropriata perché Angelo non fornisce riferimenti linguistici chiari che permettano ad Alessio di comprendere chi è il soggetto della frase (mio fratello, o il suo amico Marco?), e questo rompe la coesione della comunicazione, il buon collegamento tra le parti.
Un punto se hai indovinato.
5) DOMANDA 5: In un’agenzia di organizzazione di eventi, durante una riunione di lavoro, il responsabile dell’evento oggetto della discussione chiede a un collega: "Hai prenotato il ristorante per la cena di gala dopo l’Assemblea dei Soci?"
Quale risposta può essere considerata appropriata?
A. "Sai che proprio ieri ho cenato in quel ristorante con mia moglie?"
B. "Per che ora abbiamo programmato l’Assemblea dei Soci?”
C. “Sì, è stata la prima cosa che ho fatto una volta confermato il numero dei partecipanti”
La risposta corretta è C. Sia in A che in B, il collega risponde con un'informazione completamente fuori tema, non pertinente alla domanda. Il tema della domanda è la prenotazione del ristorante per la cena di gala, ma nella risposta A il collega si mette a parlare de “la mia esperienza di quel ristorante” (che c’entra?!?); mentre nella risposta B il tema su cui si sposta è “l’orario dell’Assemblea dei Soci”. In entrambe le risposte, B vìola un’altra importante regola, la regola della relazione (o pertinenza), secondo cui, quello che diciamo in una conversazione deve essere rilevante, deve essere pertinente rispetto alla discussione. Cambiare argomento a caso rischia di generare confusione o frustrazione in chi ascolta. So che sembra banale, ma conosco alcune persone che fanno così e… diciamo che quando lo fanno mi dà un po’ fastidio.
Un punto se hai indovinato.
6) Due compagni di corso, Massimo e Dario, parlano a fine giornata lavorativa. Dario e Massimo non sono ancora intimi, ma Dario vuole approfondire l’amicizia, per questo invita Massimo a una cena tra amici a casa sua:
Daria: "Volevo dirti, stasera ho organizzato una festa per il compleanno per mia moglie. Per caso ti va di venire? Una cosa semplice, tra amici…”
Massimo non ha voglia di andare. Cosa dice?
A. “No, non mi va, scusa.”
B. “Grazie per l’invito, sei molto gentile, ma… mi dispiace, stasera ho bisogno di una serata tranquilla, a casa. Ho dormito poco stanotte.
C. “Grazie, ma non c’ho molta voglia. Stasera ho proprio voglia di rilassarmi e non fare un cazzo, una volta ogni tanto”.
La risposta appropriata è B.
Nella risposta A, Massimo rifiuta l’invito in maniera un po’ troppo diretta, “non mi va”, e la formula di riparazione “scusa” non basta ad addolcire il “no”. In questo modo, Massimo non rispetta il desiderio di Dario di essere “accolto” e trattato con considerazione; non si prende cura della necessità di mantenere un buon rapporto con la collega, che infatti potrebbe sentirsi offeso o ferito. Attenzione, che in altre lingue, una risposta del genere sarebbe invece del tutto accettabile: non in italiano.
La risposta C andrebbe, forse, bene se Dario e Massimo fossero amici abbastanza intimi o comunque abituati a esprimersi in maniera molto informale. Formulata così, non va bene, perché è sia molto sincera, troppo, sia perché è molto informale, con quel “c’ho” al posto di “ho”, che qui stona un po’, e soprattutto, poi, c’è quell’espressione volgare…
Non l’hai scelta, vero?
La risposta appropriata è B perché è l’unica in cui il rifiuto è attenuato, attraverso strategie come il ringraziamento (”grazie per l’invito”), le scuse (”mi dispiace”) oltre a un’offerta di giustificazione (”stanotte ho dormito poco”).
Un punto, come sempre, se hai indovinato.
7) Sei al ristorante, un ristorante nuovo per te, in cui vai per la prima volta. Hai appena finito di cenare. Dopo aver chiesto il conto, ti rendi conto di aver dimenticato il portafoglio a casa. Cosa dici?
A. Ah! Aspetta dieci minuti: vado a casa, prendo il portafoglio e torno.
B. Mi scusi, aspetti dieci minuti, per cortesia: vado a casa a prendere il portafoglio e torno subito a pagare.
C. Non posso crederci, sono desolato. Ho dimenticato il portafoglio a casa. Sarebbe così cortese da darmi dieci minuti per andare a prenderlo? Abito qui vicino, posso lasciarle il documento, nel frattempo.
La risposta migliore qui è C. Trovarsi a non poter pagare un conto a una persona che non conosciamo bene è una situazione estremamente “minacciosa” dal punto di vista dell’immagine che proiettiamo di noi all’esterno e della relazione con l’altro. Per questo, richiede di usare numerose strategie di riparazione, tra cui:
- esprimere il proprio dispiacere (”sono desolato”)
- spiegare la causa del problema (”ho dimenticato il portafoglio a casa”)
- non dare per scontato che l’altro accetterà la nostra soluzione, ed essere estremamente cortesi nel chiederla (da cui l’uso dell’espressione al condizionale “sarebbe così cortese da…”)
- e anche offrire una garanzia (”posso lasciarle un documento”).
La risposta B, anche se non va così male, perché quanto meno ricorre al Lei formale, alla formula “per cortesia” e poi rassicura l’interlocutore dicendo “torno subito”, non è ancora sufficiente.
E poi vabbè, la risposta A qui non funziona proprio. Il parlante usa il “tu” al posto del “Lei”, che è troppo informale; usa l’imperativo, che è troppo diretto, specie in una situazione in cui sei dalla parte del torto, non hai ragione; e poi non offre all’ascoltatore la possibilità di accettare o rifiutare la proposta, ma invece la impone. Ecco, spero che tu non l’abbia scelta, anche questa!
Un punto, se hai indovinato.
Bene, il nostro test di oggi è finito. Come te la sei cavata? Quanti punti hai fatto?
Fammi sapere nei commenti.
Se hai fatto meno di 3 punti: beh, ti consiglierei di fare attenzione, perché, senza esagerare, rischi davvero di rovinare i tuoi rapporti con gli italiani.
Se hai fatto dai 4 ai 6 punti: bene, puoi migliorare, ancora!
Se hai fatto 7 punti, ovvero il massimo dei punti: ottimo lavoro!
Sono curioso di vedere i vostri risultati. Mi aspetto che questo quiz sia più semplice degli altri che abbiamo fatto ultimamente, ma, se questo argomento vi interessa, magari ne farò un altro simile, e perché no, anche altri contenuti su questo argomento.
Un’informazione per i più curiosi: il ramo della linguistica che si occupa dell’“agire attraverso la lingua” si chiama pragmatica. Ed è interessantissimo. Così, una frase grammaticalmente corretta, cioè giusta dal punto di vista del vocabolario, della coniugazione dei verbi, della scelta delle preposizioni e dei connettivi etc., può essere PRAGMATICAMENTE APPROPRIATA o INAPPROPRIATA, cioè adatta o inadatta al contesto, alla relazione tra i parlanti o agli obiettivi della comunicazione. Questo quiz, dunque, è un quiz di pragmatica, di pragmatica linguistica. Se te lo avessi venduto così, probabilmente avresti chiuso il video dopo 2 secondi per aprire un video di gattini, o di… ricette, non lo so. Vero? Ti conosco…
Attenzione: anche i parlanti madrelingua commettono errori pragmatici e capita spesso a noi italiani (ma ripeto, questo vale per qualsiasi lingua) di arrabbiarci o offenderci quando parliamo con nostri connazionali che vìolano sistematicamente le regole pragmatiche. Mi riferisco a persone che interrompono, che cambiano argomento, che dicono cose non pertinenti… ma la sfida ulteriore, per i parlanti non madrelingua come te, come dicevo all’inizio del video, è data dal fatto che le regole pragmatiche non sono le stesse in tutte le lingue e culture: ciò che suona scortese in una, potrebbe suonare diversamente nell’altra, e viceversa. E non è detto che i parlanti te lo facciano sempre notare, specie se non hanno il giusto livello di intimità, magari, per farti una critica.
E ora, dimmi: ti è piaciuto questo test? Hai imparato delle cose nuove? Fammelo sapere, magari faremo altri video di pragmatica. Se invece ti interessa un test per valutare il tuo livello generale di italiano (niente pragmatica), te lo lascio qui a schermo. A presto!
“Guardati ‘sto video e zitto, co*ne!”
Cosa? Come?
No, non chiudere il video! Non sono impazzito... del tutto.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Ho iniziato il video così per offrirti un esempio estremo, caricaturale di come NON si usa l’italiano, di come non AGIRE in italiano (e forse in nessuna lingua). In che senso “agire”?
Quando usi il linguaggio, quindi quando parli qualsiasi lingua, non solo “dici” qualcosa, ma “fai” anche qualcosa. Compi, cioè, degli atti, delle azioni che generano conseguenze sull’altro o sull’altra che ti ascolta. E dunque non è poi così vero, forse, che le parole e i fatti sono sempre contrapposti.
Facendo esempi meno bizzarri, chi pronuncia la frase “vi dichiaro marito e moglie” non si limita ad affermare qualcosa, a raccontarla o a descriverla (come quando scriviamo tra i commenti “Podcast Italiano è il miglior canale per imparare l’italiano”), ma compie un’azione linguistica, appunto, che genera conseguenze concrete: quelle due persone, da quel momento in poi, sono sposate.
Questa frase ha il potere di cambiare la realtà, in qualche modo. Non è una figata?
Oppure chi pronuncia la frase “prometto che domani sarò puntuale” non fa solo un’affermazione, ma genera delle attese, delle aspettative.
O ancora, chi pronuncia la frase “ti ordino di andartene” può generare una tra due conseguenze: o mi ubbidisci o mi disubbidisci. Quale scegli?
Ho pensato a questo quiz per aiutarti a capire quanto te la cavi tu nel compiere azioni linguistiche in italiano. Per esempio, fare una richiesta, rifiutare un invito, fare una critica, una promessa, una domanda, rispondere a una domanda. Vedi, questo è un argomento molto importante in una lingua straniera e cultura straniera, dove, per differenze linguistiche e culturali, si può rischiare di dire cose inappropriate e di risultare poco simpatici, o scortesi, offensivi, strani… e via dicendo.
Ah, io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l’italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. Poi, ricorda che la trascrizione integrale si trova sul mio sito, podcastitaliano.com, e che ho preparato un PDF che accompagna il quiz. Potrai usarlo per dare un’occhiata a tutte le domande mentre guardi il video e controllare le risposte, che saranno accompagnate anche da altri esempi. Ti consiglio di stamparlo, a proposito, perché ti tornerà molto utile. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR.
Dunque, ti farò 7 domande.
Per ogni domanda, fai molta attenzione alla descrizione che ti darò della situazione.
Il test, in totale, vale 7 punti, e guadagnerai 1 punto per ogni risposta esatta.
Pronto? Pronta? Andiamo!
1) SITUAZIONE: Due colleghi condividono lo stesso ufficio. Il primo collega sta parlando al telefono con un cliente a voce troppo alta. Il secondo collega ne è disturbato. Cosa dice il secondo collega al primo?
A. “Vengo, con la presente, a chiederle cortesemente di abbassare il volume della Sua voce.”
B. “Non è che, gentilmente, abbasseresti la voce? È che mi deconcentro, se no.”
C. "Abbassa immediatamente ‘sta cazzo di voce."
Ok, questa era facile, vero? La risposta appropriata è B. In B, la richiesta viene mitigata, viene “addolcita” con una costruzione nota, tecnicamente, come frase scissa , usata due volte (non è che… e è che…); ma anche alla formula di cortesia “gentilmente”, all’uso del condizionale (”abbasseresti”), alla giustificazione (”mi deconcentro così”). Massimo dei voti.
La risposta A, invece, è inappropriata perché è troppo formale: così si elaborano solo richieste scritte, molto formali, in contesti burocratici: vedi il video sul burocratese. Non ci si rivolgerebbe mai così nel parlato a un proprio pari con cui si è in intimità.
La risposta C, invece, non va bene perché la richiesta è troppo diretta. Innanzitutto, ricorre al modo imperativo che, in italiano, già di per sé, è spesso troppo diretto. Inoltre, è resa più aggressiva dall’intensificatore “immediatamente”, e dalla parolaccia “ ‘sta cazzo di voce”. Ok, spero che questa non l’abbia scelta nessuno, se no… inizio a preoccuparmi.
Segnati un punto sul foglio se hai indovinato.
2) OK. SITUAZIONE: Uno studente universitario scrive un’e-mail al proprio professore, per chiedergli aiuto nella preparazione di un esame. Quale formulazione è appropriata alla relazione tra i parlanti ma anche appropriata all’obiettivo della comunicazione?
A. "Ciao prof, tutto ok? Ho bisogno che mi dai una mano con l'esame.”
B. "Buongiorno professore, come sta? Mi aiuta con l’esame?”
C. "Buongiorno professore, spero di trovarla bene. Le vorrei chiedere se cortesemente potrebbe aiutarmi con l’esame. Ho perso alcune lezioni e non riesco a comprendere alcune parti del programma.”
SOLUZIONE: la risposta appropriata è C. Beh, anche questa era facile, vero? La risposta A, in cui si usa il “tu”, l’abbreviazione “prof” e l’espressione colloquiale “dare una mano” è troppo informale rispetto alla relazione gerarchica tra studente e professore. Insomma, mica siamo al bar.
La risposta B è un pochino meglio di A, perché dal “ciao” si passa al “buongiorno” (ricorda che ”ciao” in italiano è informale, quindi fai attenzione, se non vuoi essere informale!), e dal “tu” si passa anche al “Lei”. Il “come sta?” risulta ancora troppo informale nella lingua scritta, anche se usa il Lei. Inoltre, la richiesta di aiuto, “mi aiuta con l’esame”, è formulata in maniera troppo diretta.
La risposta C è appropriata per la scelta del “Lei” di cortesia, perché dimostra interesse per il professore (probabilmente interesse falso, ma non importa), cioè quel “spero di trovarla bene”, perché è resa meno diretta da formule come come “le vorrei chiedere se cortesemente potrebbe…”, e perché contiene una giustificazione, “ho perso alcune lezioni e non riesco a comprendere alcune parti del programma”.
Hai indovinato? Di nuovo, un punto. Segnatelo, mi raccomando, perché poi voglio sapere quanti punti fai.
3) SITUAZIONE: Due amici, Giulio e Stefano, stanno conversando durante una cena. Ecco che cosa si dicono:
Giulio: "Stavo dicendo che ieri sono andato a…"
Stefano: "Ah sì, anch’io sono andato in centro!"
Perché il comportamento linguistico di Stefano è inappropriato?
A. Perché anticipa Giulio.
B. Perché interrompe Giulio.
C. Perché fraintende Giulio.
La risposta è B: Stefano interrompe Giulio prima che questo finisca la sua frase. Così Stefano vìola una norma implicita della conversazione, in particolare quella relativa alla gestione dei turni di parola (cioè chi parla in ciascun momento), che dice: “aspetta il tuo turno di parola, non parlare prima che l’altro abbia terminato il suo turno”. Interrompere le altre persone non è scortese allo stesso modo in tutte le culture, e in italiano probabilmente è più comune che in altre lingue e altre culture: insomma, in italiano, a volte, ci parliamo un po’ addosso, ecco, soprattutto dalla prospettiva… che ne so, di un finlandese, per esempio. Tuttavia, in questo caso l’interruzione non è il massimo, anzi, è abbastanza antipatica. Non va bene.
Un punto, se hai indovinato.
4) Due amici, Angelo e Alessio, stanno facendo aperitivo al bar. Ecco che cosa si dicono:
Angelo: "Ieri sono andato a un concerto con mio fratello e il suo amico Marco. Prima mi ha mandato un messaggio dicendomi che ci avrebbe raggiunti più tardi, forse per cena."
Alessio: "Ma chi vuole raggiungerci? Tuo fratello o l’amico?"
Perché Alessio è confuso?
A. Angelo usa un verbo alla terza persona “ha detto” con soggetto implicito. Non è chiaro a chi si riferisca questo soggetto, se a “mio fratello” o “al suo amico Marco”, e ciò crea ambiguità.
B. Angelo usa dei pronomi personali, “mi” e “ci”, che non è chiaro a chi si riferiscano.
C. Al posto del verbo alla terza persona singolare “ha detto”, Angelo avrebbe dovuto usare un verbo alla terza persona plurale, “hanno detto”, per includere sia il fratello che il suo amico Marco.
La risposta è A. Qui, l’azione linguistica di Angelo non è appropriata perché Angelo non fornisce riferimenti linguistici chiari che permettano ad Alessio di comprendere chi è il soggetto della frase (mio fratello, o il suo amico Marco?), e questo rompe la coesione della comunicazione, il buon collegamento tra le parti.
Un punto se hai indovinato.
5) DOMANDA 5: In un’agenzia di organizzazione di eventi, durante una riunione di lavoro, il responsabile dell’evento oggetto della discussione chiede a un collega: "Hai prenotato il ristorante per la cena di gala dopo l’Assemblea dei Soci?"
Quale risposta può essere considerata appropriata?
A. "Sai che proprio ieri ho cenato in quel ristorante con mia moglie?"
B. "Per che ora abbiamo programmato l’Assemblea dei Soci?”
C. “Sì, è stata la prima cosa che ho fatto una volta confermato il numero dei partecipanti”
La risposta corretta è C. Sia in A che in B, il collega risponde con un'informazione completamente fuori tema, non pertinente alla domanda. Il tema della domanda è la prenotazione del ristorante per la cena di gala, ma nella risposta A il collega si mette a parlare de “la mia esperienza di quel ristorante” (che c’entra?!?); mentre nella risposta B il tema su cui si sposta è “l’orario dell’Assemblea dei Soci”. In entrambe le risposte, B vìola un’altra importante regola, la regola della relazione (o pertinenza), secondo cui, quello che diciamo in una conversazione deve essere rilevante, deve essere pertinente rispetto alla discussione. Cambiare argomento a caso rischia di generare confusione o frustrazione in chi ascolta. So che sembra banale, ma conosco alcune persone che fanno così e… diciamo che quando lo fanno mi dà un po’ fastidio.
Un punto se hai indovinato.
6) Due compagni di corso, Massimo e Dario, parlano a fine giornata lavorativa. Dario e Massimo non sono ancora intimi, ma Dario vuole approfondire l’amicizia, per questo invita Massimo a una cena tra amici a casa sua:
Daria: "Volevo dirti, stasera ho organizzato una festa per il compleanno per mia moglie. Per caso ti va di venire? Una cosa semplice, tra amici…”
Massimo non ha voglia di andare. Cosa dice?
A. “No, non mi va, scusa.”
B. “Grazie per l’invito, sei molto gentile, ma… mi dispiace, stasera ho bisogno di una serata tranquilla, a casa. Ho dormito poco stanotte.
C. “Grazie, ma non c’ho molta voglia. Stasera ho proprio voglia di rilassarmi e non fare un cazzo, una volta ogni tanto”.
La risposta appropriata è B.
Nella risposta A, Massimo rifiuta l’invito in maniera un po’ troppo diretta, “non mi va”, e la formula di riparazione “scusa” non basta ad addolcire il “no”. In questo modo, Massimo non rispetta il desiderio di Dario di essere “accolto” e trattato con considerazione; non si prende cura della necessità di mantenere un buon rapporto con la collega, che infatti potrebbe sentirsi offeso o ferito. Attenzione, che in altre lingue, una risposta del genere sarebbe invece del tutto accettabile: non in italiano.
La risposta C andrebbe, forse, bene se Dario e Massimo fossero amici abbastanza intimi o comunque abituati a esprimersi in maniera molto informale. Formulata così, non va bene, perché è sia molto sincera, troppo, sia perché è molto informale, con quel “c’ho” al posto di “ho”, che qui stona un po’, e soprattutto, poi, c’è quell’espressione volgare…
Non l’hai scelta, vero?
La risposta appropriata è B perché è l’unica in cui il rifiuto è attenuato, attraverso strategie come il ringraziamento (”grazie per l’invito”), le scuse (”mi dispiace”) oltre a un’offerta di giustificazione (”stanotte ho dormito poco”).
Un punto, come sempre, se hai indovinato.
7) Sei al ristorante, un ristorante nuovo per te, in cui vai per la prima volta. Hai appena finito di cenare. Dopo aver chiesto il conto, ti rendi conto di aver dimenticato il portafoglio a casa. Cosa dici?
A. Ah! Aspetta dieci minuti: vado a casa, prendo il portafoglio e torno.
B. Mi scusi, aspetti dieci minuti, per cortesia: vado a casa a prendere il portafoglio e torno subito a pagare.
C. Non posso crederci, sono desolato. Ho dimenticato il portafoglio a casa. Sarebbe così cortese da darmi dieci minuti per andare a prenderlo? Abito qui vicino, posso lasciarle il documento, nel frattempo.
La risposta migliore qui è C. Trovarsi a non poter pagare un conto a una persona che non conosciamo bene è una situazione estremamente “minacciosa” dal punto di vista dell’immagine che proiettiamo di noi all’esterno e della relazione con l’altro. Per questo, richiede di usare numerose strategie di riparazione, tra cui:
- esprimere il proprio dispiacere (”sono desolato”)
- spiegare la causa del problema (”ho dimenticato il portafoglio a casa”)
- non dare per scontato che l’altro accetterà la nostra soluzione, ed essere estremamente cortesi nel chiederla (da cui l’uso dell’espressione al condizionale “sarebbe così cortese da…”)
- e anche offrire una garanzia (”posso lasciarle un documento”).
La risposta B, anche se non va così male, perché quanto meno ricorre al Lei formale, alla formula “per cortesia” e poi rassicura l’interlocutore dicendo “torno subito”, non è ancora sufficiente.
E poi vabbè, la risposta A qui non funziona proprio. Il parlante usa il “tu” al posto del “Lei”, che è troppo informale; usa l’imperativo, che è troppo diretto, specie in una situazione in cui sei dalla parte del torto, non hai ragione; e poi non offre all’ascoltatore la possibilità di accettare o rifiutare la proposta, ma invece la impone. Ecco, spero che tu non l’abbia scelta, anche questa!
Un punto, se hai indovinato.
Bene, il nostro test di oggi è finito. Come te la sei cavata? Quanti punti hai fatto?
Fammi sapere nei commenti.
Se hai fatto meno di 3 punti: beh, ti consiglierei di fare attenzione, perché, senza esagerare, rischi davvero di rovinare i tuoi rapporti con gli italiani.
Se hai fatto dai 4 ai 6 punti: bene, puoi migliorare, ancora!
Se hai fatto 7 punti, ovvero il massimo dei punti: ottimo lavoro!
Sono curioso di vedere i vostri risultati. Mi aspetto che questo quiz sia più semplice degli altri che abbiamo fatto ultimamente, ma, se questo argomento vi interessa, magari ne farò un altro simile, e perché no, anche altri contenuti su questo argomento.
Un’informazione per i più curiosi: il ramo della linguistica che si occupa dell’“agire attraverso la lingua” si chiama pragmatica. Ed è interessantissimo. Così, una frase grammaticalmente corretta, cioè giusta dal punto di vista del vocabolario, della coniugazione dei verbi, della scelta delle preposizioni e dei connettivi etc., può essere PRAGMATICAMENTE APPROPRIATA o INAPPROPRIATA, cioè adatta o inadatta al contesto, alla relazione tra i parlanti o agli obiettivi della comunicazione. Questo quiz, dunque, è un quiz di pragmatica, di pragmatica linguistica. Se te lo avessi venduto così, probabilmente avresti chiuso il video dopo 2 secondi per aprire un video di gattini, o di… ricette, non lo so. Vero? Ti conosco…
Attenzione: anche i parlanti madrelingua commettono errori pragmatici e capita spesso a noi italiani (ma ripeto, questo vale per qualsiasi lingua) di arrabbiarci o offenderci quando parliamo con nostri connazionali che vìolano sistematicamente le regole pragmatiche. Mi riferisco a persone che interrompono, che cambiano argomento, che dicono cose non pertinenti… ma la sfida ulteriore, per i parlanti non madrelingua come te, come dicevo all’inizio del video, è data dal fatto che le regole pragmatiche non sono le stesse in tutte le lingue e culture: ciò che suona scortese in una, potrebbe suonare diversamente nell’altra, e viceversa. E non è detto che i parlanti te lo facciano sempre notare, specie se non hanno il giusto livello di intimità, magari, per farti una critica.
E ora, dimmi: ti è piaciuto questo test? Hai imparato delle cose nuove? Fammelo sapere, magari faremo altri video di pragmatica. Se invece ti interessa un test per valutare il tuo livello generale di italiano (niente pragmatica), te lo lascio qui a schermo. A presto!




.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
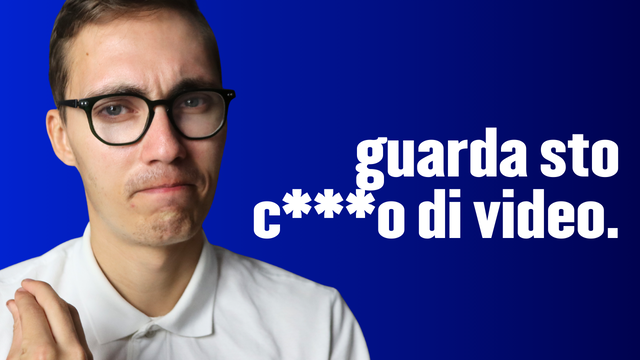
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)






























