4 "ERRORI" che fanno gli italiani
In questo video, analizzo alcuni degli "errori" più comuni che fanno gli italiani, come l'uso di "gli" al femminile, il costruttto "a me mi", il "che" polivalente e il "piuttosto che" disgiuntivo. Scopriremo perché molti di questi non sono veri errori, ma semplicemente usi informali che riflettono l'evoluzione naturale della lingua italiana.
Scarica il PDF gratuito con il riassunto della lezione
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
Gli italiani fanno errori diitaliano. In realtà, questo fatto non dovrebbe sorprenderci. Scommetto che, qualunque sia la tualingua madre, è normale anche nel tuoPaese che le persone faccianodegli errori e nonparlino o scrivano in ogni situazione secondo le regole dellalingua standard.
In questo video voglio parlarti di alcuni degli “errori”(o presunti errori) piùcomuni che fanno gli italiani. Sono molto comuni e molto interessanti, perchéci permettono di scoprire coseinteressanti su come funziona la nostralingua. Guarda il video fino alla fine perché il quarto errore è forse il piùinteressante di tutti.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Ah, io mi chiamo Davide e questoè Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l’italiano. Attiva isottotitoli se ne hai bisogno, ericorda che la trascrizione integrale di quello che dico nel video si trova sul mio sito.Come sempre ho preparato un PDF che riassume la lezione, con ulteriori esempi, maanche esercizi per metterti alla prova contutto quello che imparerai nel video. Puoi scaricarlo al link indescrizione, oppure scansionando questo codice QR. Incominciamo!
Forse sai che il pronome “gli”in italiano ha più di un significato. Il primosignificato è “a lui”, per esempio:
È da tempo che non sento Giacomo.Ora gli scrivo un messaggio.
Qui nessun problema. “Gli”significa “a lui”: scrivo a lui un messaggio.
Ora, un uso che non piace atutti, ed è criticato soprattuttodai pedanti dellagrammatica, è “gli” con significato di “loro” o “a loro”. E quindi:
È da tempo che non sento i mieizii. Ora gli scrivo un messaggio.
Qui “gli” si usa con ilsignificato di “a loro”: scrivo a loro un messaggio,o meglio, scrivo loro un messaggio.La differenza che c’è tra “scrivo loro” e “scrivo a loro” è la stessa che c’ètra “gli scrivo un messaggio” e “scrivo un messaggio a lui”: la seconda opzionemette in evidenza “alui”, come per dire “scrivoun messaggio proprio a lui”.
Quindi è una questione di enfasi,diciamo così, per semplificare. Ma anche questo è un uso così comune che ormainon si può realmente considerare errore. “Loro”, infatti, ormai appartiene a unregistro formale, e nella vita di tutti i giorninessuno direbbe realmente“scrivo loro un messaggio”.
Ma vediamo ora l’uso piùproblematico di “gli”:
È da tempo che non sentoSamanta. Ora gli scrivo un messaggio.
Ecco, l’italiano standard quivorrebbe “le” scrivo un messaggio,non “gli”: perché Samanta è una donna, scrivo a lei, un messaggio. Tuttavia, nelparlato è molto comune sentire “gli” con significato femminile. Io,personalmente, lo sento molto spesso, lo sento di continuo, e a volte scappa anche a me, loammetto.
Come si spiega? Forse c’èanche un’influenza di “glielo”, in cui la parte “glie” può significare sia “alui”, sia “a lei”, indifferentemente. Quindi “glielo dico” può significareanche “lo dico a lei”, oltre che “lo dico a lui”. Sta di fatto che, comespesso succede, non si tratta di un usonuovo: è molto antico ed è stato usato da scrittori illustri (comeBoccaccio, Machiavelli, Verga), tuttavia, oggi, questo “gli” femminile è molto sconsigliato daigrammatici. Tu l’hai mai sentito? L’hai mai usato? Fammi sapere.
Oh, il prossimo è un grandeclassico, un vero e propriopseudo-errore che tanti italiani considerano un errore vero. E anche un erroreabbastanza grave, abbastanza brutto. Vediamo un esempio:
A me mi è piaciuto.
Molti italiani storceranno il nasosentendo “a me mi”, un costrutto che la scuola italiana ha sempre volutocensurare, che ha sempre accusato con violenza di essere sbagliato, in quanto, si dice, “èridondante”, “è pleonastico”. Si dovrebbe dire, secondo gli insegnanti discuola, “mi è piaciuto” oppure “a me è piaciuto”, in base alla sfumatura che vogliamodare. Ma mai “a me mi è piaciuto” o “a me mi piace”, “a me mi hanno detto unacosa”, quello che volete. In realtà, questa è una regola del tutto arbitraria,che tra l’altro non viene applicata neanche con la stessaforza agli altri pronomi. Quindi “a te ti piace”, “a lui glipiace”, “a lei le” “a noi ci”, “a voi vi ”, “a loro gli” danno meno fastidio,alle orecchie di un italiano, di un “a me mi”. Eppure la costruzione èla stessa.
Ma che succede,grammaticalmente? Quando diciamo “a me hanno detto”, con un pronome tonico,forte, stiamo rendendo “a me” il cosiddetto tema della frase, cioè ciòintorno a cui diremo qualcosa (in questo caso, “mi è piaciuto”). Come dire“quanto a me”, “per quanto riguarda me”. Sto parlando di me.
Partiamo da qui,dunque: “a me è piaciuto” non è equivalente a “mi è piaciuto”. Ora,tecnicamente, però, il “mi” non sarebbe necessario se diciamo già “a me è piaciuto”, con ilpronome forte; si potrebbe considerare, in effetti, che quel mi sarebbe ridondante. Mala ridondanza è la stessa che troviamo in costruzioni analoghe, molto meno“odiate”, come, per esempio:
A Roma non ci vado spesso.
Ecco, il “ci” non è necessario,ma si usa per enfasi, per espressività. O ancora:
A lui gliel’ho detto.
Che è un po’ tipo “a me mi”. Di nuovo, “a lui l’ho detto”basterebbe, ma nel parlato si può aggiungere quel “gli”per dare più espressività.
La ridondanza nelle lingue è unfenomeno normale, e non andrebbe stigmatizzata.Sono in molti i linguisti, tra l’altro, che difendono l’uso di “a me mi”, che altro non è che unesempio di una costruzione molto comune nella lingua parlata, contro la quale si è fatta una crociata senza senso,un po’ come quella che in inglese è stata fatta con le preposizioni che nonandrebbero messe alla fine di unafrase. Ecco, non so se hai maisentito questa cosa qua, che è un’altra stupidaggine deigrammatici, diciamo così.
Ma ormai è troppo tardi, forsela scuola italiana ci ha inculcato l’idea immotivata che “a memi” sia una forma sbagliata, e dunque chi vuole “parlare bene” tende a evitarla, perché cosìci hanno detto e ci suona male, in effetti,proprio perché, fin da piccoli, ce lo dicono. Mi domando: chissà se suona maleanche in spagnolo, dove invece l’equivalente “a mi me” (a mi me gusta, a mi me…qualcosa) è assolutamente normale…? Sono… sono sarcastico.
Di che parliamo ora? Di “che”.In particolare, il “che” pronome relativo, quello di frasi come:
La persona che hai chiamatosi chiama Federico.
Il “che” introduce una fraserelativa, che in questo caso si lega e modifica “lapersona, ci aiuta a capire meglio di che persona stiamo parlando: la persona che hai chiamato.Grammaticalmente, il “che” in questa frase relativa ha funzione di oggettodiretto, perché diremmo “hai chiamato la persona”. Questo sarebbe ilsignificato della relativa. Quindi si considera “che” l’oggetto diretto dellafrase relativa.
Vediamo ora questa frase:
La persona a cui hai telefonatosi chiama Federico.
Cambiando il verbo, quindiusando “telefonare” al posto di “chiamare”, avremo un oggetto indiretto, perchése è vero che “chiamiamo qualcuno”, “telefoniamo a qualcuno”: oggettoindiretto, serve la preposizione a. E dunque il nostropronome relativo “che”, aggiungendo “a”, deve cambiare e diventare “cui”. “Lapersona a cui hai telefonato”. Unoggetto indiretto. Una variante leggermente più formalesarebbe “alla quale”: la persona “alla quale” haitelefonato.
Nel parlato, tuttavia, ècomunissimo usare il semplice “che” anche in casi come questo, dove dovremmo,tecnicamente, avere la preposizione + cui. La frase potrebbe dunque diventare:
La persona che haitelefonato si chiama Federico.
Un errore, sicuramente, dalpunto di vista della lingua standard ma che, nel parlato informale, èabbastanza frequente. Vediamo un altro esempio standard, quindi diciamo“corretto” dal punto di vista delle regole normative:
Il problema di cui parlavi nonsi è verificato.
“Parliamo di qualcosa”, no?Questa è la preposizione. Quindi “il problema di cui parlavi”, si dovrebbe dire.Ma come nell’esempio di prima, possiamo avere anche una versione informale:
Il problema che parlavi non si èverificato.
Ora, se ci sono italiani all’ascolto, forse,alcuni almeno, storceranno ilnaso, ma nel parlato questa costruzione è comunissima. O, ancora, una frase“standard” come:
Sono fortunato, perché non c’èniente di cui ho bisogno (perché l’espressione è, anche qui, “avere bisogno di qualcosa”)può diventare: sono fortunato, perché non c’èniente che ho bisogno (… che, tra l’altro, è una citazione dellafamosissima canzone “ragazzo fortunato” di Jovanotti).
🎶 Sono un ragazzo fortunato perchém’hanno regalato un sogno
Sono fortunato, perché non c’èniente che ho bisogno… 🎶
Ecco, questi sono esempi di“che” polivalente, come lo chiamano i linguisti, cioè di “che” che assume vari usi che nonsarebbero possibili nella lingua standard. Nel parlato, come ho detto, sonosuper comuni, e quindi facci caso.
Concludiamo con un altroclassico, un classico più recente forse, che dà fastidio a un sacco di persone (e unpo’ anche a me, in realtà, lo devo ammettere). Prendiamo questa frase:
Voglio andare al mare piuttostoche in montagna.
Che significa? In italianostandard “piuttosto che” significa “anziché”, “invece di”.Dunque al mare e non in montagna,anziché la montagna: cioè, tra le due opzioni, preferisco la montagna.
Tuttavia dagli anni Ottanta adoggi si è sviluppato un usodi “piuttosto che”, che è nato nel Nord Italia, dalle parti di Milano e Torino,e che poi si è diffuso anche nelresto d’Italia. La cosa curiosa è che, se gli altri “errori” visti finora sono normalmenteconsiderati errori rozzi, che fannopersone poco istruite (che poi inrealtà non è vero perché sono costruzioni che tanti italiani usanocomunemente), in questo caso si tratta di un uso percepito (almeno da chi lousa) come più raffinato, più elegante. Chi lo odia, invece, lo trova fastidioso e snob, unpo’ pretenzioso. Ma vediamolo in azione:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna…
Qui, quello che si sta cercandodi dire, è un semplice “o”, “oppure”. Possiamo andare al mare o inmontagna: sono opzioni valide. Tuttavia, usare quattro sillabe,evidentemente, sembra più ricercato, più elegantedi usare una sola sillaba (“o”).
Spesso, tra l’altro, si usanovari “piuttosto che” in sequenza, come per fare un elenco, unalista di possibilità:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna, piuttosto che in campagna… come vuoi tu.
E dunque si offre un elenco diopzioni. Per chi parla, insomma, vanno bene tutte, perlui o lei, è uguale. Questo usodel “piuttosto che” viene chiamato disgiuntivo: disgiuntivo nellagrammatica è praticamente il significato di o, o oppure.
Va detto che questonuovo “piuttosto che” non si usa in tutti i casi in cui si userebbe “o”. Peresempio, nessuno lo usa nelle domande: non si può dire “vuoi andare al mare piuttostoche in montagna?”. No. Qui, si userebbe solamente “o”. O meglio, possousare ovviamente “piuttosto che” ma nel suo significato originale: “vuoi andareal mare piuttosto che (cioè anziché, invece di) andarein montagna?”. Questo è sempre un uso valido.
Secondo alcuni linguisti“piuttosto che” sta diventando anche un sinonimo di eccetera. Prendendo unesempio reale, pronunciato dall’attuale Presidente del Consiglio GiorgiaMeloni, quando era una ministra, ancora, avremo qualcosa come questo:
Forse anche la politica capiràche Internet non è solamente qualcosa da vietare perché c’è il bullismoche finisce su YouTube, piuttosto che…
Insomma, come dire “eccetera”,“e così via”, “e via dicendo”. Ecco, anche questo, in effetti, a me sembra unuso abbastanza comune. Ecco, questo è uno dei nuovi “errori” linguistici, usi impropri diun’espressione dell’italiano, nonché uno dei piùodiati dalle persone a cui è stato detto che è sbagliato, oppure dalle personeche sono abbastanza anziane, diciamo così, da ricordarsi un mondo in cui questo“piuttosto che” non lo usava nessuno. Perché, in effetti, ormai circola da unpo’ di tempo, e quindi ci saranno generazioni per cui è assolutamente normale.
Scherzi a parte, il fastidio ci può stare, perchéquesto uso più generare, effettivamente, ambiguità. Anche se, personalmente,nella maggior parte dei casi, non faccio fatica a capire, dal contesto e anchedall’intonazione, qual è il significato che gli si dà. L’intonazione è diversa,senti:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna (cioè, “possiamo andare al mare, anziché inmontagna”).
L’altro uso:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna… (o una o l’altra; e di solito, magari, ci sonoanche altre opzioni: al mare, piuttosto che in montagna, piuttosto che uncampagna…).
Nello scritto, però, in effetti,diventa più difficile. L’ambiguità che si può creare ha portato molti linguistia esporsi pubblicamente contro questo uso di piuttosto che, cosa, peraltro, rara: inItalia i linguisti e gli studiosi della lingua normalmente sono piuttosto neutri, non si schieranoapertamente contro, o a favore,certi usi. Ma in questo caso lo hanno fatto. Pensa che il cantante LorenzoBaglioni, famoso anche per la sua canzone sul congiuntivo, ha anche dedicatouna canzone anche al “piuttosto che” disgiuntivo.
🎶 Ecco qui la regola che scacciale paure:
“Piuttosto che” non vuol dire“oppure”.
Più più più più piuttosto che…🎶
Inoltre, sull’argogmento, sisono scritti, e si scrivono, articoli, post… si fanno video su YouTube…insomma, si fa molta propaganda contro questo “piuttosto che” ma che finora si è rivelatoabbastanza inutile, visto che continua a usarsi eforse più di prima. Tu cosa ne pensi, l’avevi mai sentito? Ti piace? Fammisapere nei commenti.
Questi erano i quattro erroriche fanno gli italiani di cui volevo parlarti oggi. Ovviamente ce ne sarebberomolti altri: errori col congiuntivo (a cui ho dedicato un video recente),errori di ortografia, ma anche parole usate a sproposito, errorigrammaticali di vario genere… la lista sarebbe molto lunga.
Voglio concludere, però, conquesta riflessione. Le lingue, come sa ogni linguista, cambiano: questo è unfatto inevitabile e scontato. Se non fosse così stareiparlando in latino, in questo momento, o in proto-indoeuropeo. Equindi, se da un lato è normale,ma anche molto utile, che esista una lingua standard, quindi delle norme daseguire, dall’altro lato non cisi può aspettare che le persone le rispettino sempre, è impensabile. Poi ognunoavrà le proprie idiosincrasie linguistiche: a me il “piuttosto che” disgiuntivonon piace molto ma, per esempio, non ho alcun problema con “a me mi”. Èsoggettivo.
E ricordiamoci poi quello chedico sempre: una lingua ha vari registri che possono andare bene in contestidiversi. Così come non ci vestiamo allo stesso modo a un matrimonio e inspiaggia, è normale che si adatti il proprio modo diparlare, o di scrivere, in base ai contesti. Sein contesti informali è normale rilassarsi un po’ di più, in contesti piùcontrollati, più formali, è meglio attenersi alla linguastandard.
Tu, da studente, avrai a che fare consituazioni e contesti di ogni genere… ma, sedovessi ipotizzare, probabilmente avrai a che fare più con situazioni informaliche formali, ed è dunque giusto, secondo me, chequalcuno ti dica che certe forme, in contesti informali, esistono e siusano molto, anche se vanno contro le regoledell’italiano standard e anche al di là dello stigmache hanno e che possono avere. Ed è per questo che te ne ho parlato in questovideo. Ora, se scansioni questo codice QR o segui il link che ti lascio sotto,potrai ripassare tutto quelloche hai imparato e anche fare esercizi. Sono sicuro che il PDF ti piaceràmolto. Non ho altro da dirti, alla prossima.
Gli italiani fanno errori diitaliano. In realtà, questo fatto non dovrebbe sorprenderci. Scommetto che, qualunque sia la tualingua madre, è normale anche nel tuoPaese che le persone faccianodegli errori e nonparlino o scrivano in ogni situazione secondo le regole dellalingua standard.
In questo video voglio parlarti di alcuni degli “errori”(o presunti errori) piùcomuni che fanno gli italiani. Sono molto comuni e molto interessanti, perchéci permettono di scoprire coseinteressanti su come funziona la nostralingua. Guarda il video fino alla fine perché il quarto errore è forse il piùinteressante di tutti.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Ah, io mi chiamo Davide e questoè Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l’italiano. Attiva isottotitoli se ne hai bisogno, ericorda che la trascrizione integrale di quello che dico nel video si trova sul mio sito.Come sempre ho preparato un PDF che riassume la lezione, con ulteriori esempi, maanche esercizi per metterti alla prova contutto quello che imparerai nel video. Puoi scaricarlo al link indescrizione, oppure scansionando questo codice QR. Incominciamo!
Forse sai che il pronome “gli”in italiano ha più di un significato. Il primosignificato è “a lui”, per esempio:
È da tempo che non sento Giacomo.Ora gli scrivo un messaggio.
Qui nessun problema. “Gli”significa “a lui”: scrivo a lui un messaggio.
Ora, un uso che non piace atutti, ed è criticato soprattuttodai pedanti dellagrammatica, è “gli” con significato di “loro” o “a loro”. E quindi:
È da tempo che non sento i mieizii. Ora gli scrivo un messaggio.
Qui “gli” si usa con ilsignificato di “a loro”: scrivo a loro un messaggio,o meglio, scrivo loro un messaggio.La differenza che c’è tra “scrivo loro” e “scrivo a loro” è la stessa che c’ètra “gli scrivo un messaggio” e “scrivo un messaggio a lui”: la seconda opzionemette in evidenza “alui”, come per dire “scrivoun messaggio proprio a lui”.
Quindi è una questione di enfasi,diciamo così, per semplificare. Ma anche questo è un uso così comune che ormainon si può realmente considerare errore. “Loro”, infatti, ormai appartiene a unregistro formale, e nella vita di tutti i giorninessuno direbbe realmente“scrivo loro un messaggio”.
Ma vediamo ora l’uso piùproblematico di “gli”:
È da tempo che non sentoSamanta. Ora gli scrivo un messaggio.
Ecco, l’italiano standard quivorrebbe “le” scrivo un messaggio,non “gli”: perché Samanta è una donna, scrivo a lei, un messaggio. Tuttavia, nelparlato è molto comune sentire “gli” con significato femminile. Io,personalmente, lo sento molto spesso, lo sento di continuo, e a volte scappa anche a me, loammetto.
Come si spiega? Forse c’èanche un’influenza di “glielo”, in cui la parte “glie” può significare sia “alui”, sia “a lei”, indifferentemente. Quindi “glielo dico” può significareanche “lo dico a lei”, oltre che “lo dico a lui”. Sta di fatto che, comespesso succede, non si tratta di un usonuovo: è molto antico ed è stato usato da scrittori illustri (comeBoccaccio, Machiavelli, Verga), tuttavia, oggi, questo “gli” femminile è molto sconsigliato daigrammatici. Tu l’hai mai sentito? L’hai mai usato? Fammi sapere.
Oh, il prossimo è un grandeclassico, un vero e propriopseudo-errore che tanti italiani considerano un errore vero. E anche un erroreabbastanza grave, abbastanza brutto. Vediamo un esempio:
A me mi è piaciuto.
Molti italiani storceranno il nasosentendo “a me mi”, un costrutto che la scuola italiana ha sempre volutocensurare, che ha sempre accusato con violenza di essere sbagliato, in quanto, si dice, “èridondante”, “è pleonastico”. Si dovrebbe dire, secondo gli insegnanti discuola, “mi è piaciuto” oppure “a me è piaciuto”, in base alla sfumatura che vogliamodare. Ma mai “a me mi è piaciuto” o “a me mi piace”, “a me mi hanno detto unacosa”, quello che volete. In realtà, questa è una regola del tutto arbitraria,che tra l’altro non viene applicata neanche con la stessaforza agli altri pronomi. Quindi “a te ti piace”, “a lui glipiace”, “a lei le” “a noi ci”, “a voi vi ”, “a loro gli” danno meno fastidio,alle orecchie di un italiano, di un “a me mi”. Eppure la costruzione èla stessa.
Ma che succede,grammaticalmente? Quando diciamo “a me hanno detto”, con un pronome tonico,forte, stiamo rendendo “a me” il cosiddetto tema della frase, cioè ciòintorno a cui diremo qualcosa (in questo caso, “mi è piaciuto”). Come dire“quanto a me”, “per quanto riguarda me”. Sto parlando di me.
Partiamo da qui,dunque: “a me è piaciuto” non è equivalente a “mi è piaciuto”. Ora,tecnicamente, però, il “mi” non sarebbe necessario se diciamo già “a me è piaciuto”, con ilpronome forte; si potrebbe considerare, in effetti, che quel mi sarebbe ridondante. Mala ridondanza è la stessa che troviamo in costruzioni analoghe, molto meno“odiate”, come, per esempio:
A Roma non ci vado spesso.
Ecco, il “ci” non è necessario,ma si usa per enfasi, per espressività. O ancora:
A lui gliel’ho detto.
Che è un po’ tipo “a me mi”. Di nuovo, “a lui l’ho detto”basterebbe, ma nel parlato si può aggiungere quel “gli”per dare più espressività.
La ridondanza nelle lingue è unfenomeno normale, e non andrebbe stigmatizzata.Sono in molti i linguisti, tra l’altro, che difendono l’uso di “a me mi”, che altro non è che unesempio di una costruzione molto comune nella lingua parlata, contro la quale si è fatta una crociata senza senso,un po’ come quella che in inglese è stata fatta con le preposizioni che nonandrebbero messe alla fine di unafrase. Ecco, non so se hai maisentito questa cosa qua, che è un’altra stupidaggine deigrammatici, diciamo così.
Ma ormai è troppo tardi, forsela scuola italiana ci ha inculcato l’idea immotivata che “a memi” sia una forma sbagliata, e dunque chi vuole “parlare bene” tende a evitarla, perché cosìci hanno detto e ci suona male, in effetti,proprio perché, fin da piccoli, ce lo dicono. Mi domando: chissà se suona maleanche in spagnolo, dove invece l’equivalente “a mi me” (a mi me gusta, a mi me…qualcosa) è assolutamente normale…? Sono… sono sarcastico.
Di che parliamo ora? Di “che”.In particolare, il “che” pronome relativo, quello di frasi come:
La persona che hai chiamatosi chiama Federico.
Il “che” introduce una fraserelativa, che in questo caso si lega e modifica “lapersona, ci aiuta a capire meglio di che persona stiamo parlando: la persona che hai chiamato.Grammaticalmente, il “che” in questa frase relativa ha funzione di oggettodiretto, perché diremmo “hai chiamato la persona”. Questo sarebbe ilsignificato della relativa. Quindi si considera “che” l’oggetto diretto dellafrase relativa.
Vediamo ora questa frase:
La persona a cui hai telefonatosi chiama Federico.
Cambiando il verbo, quindiusando “telefonare” al posto di “chiamare”, avremo un oggetto indiretto, perchése è vero che “chiamiamo qualcuno”, “telefoniamo a qualcuno”: oggettoindiretto, serve la preposizione a. E dunque il nostropronome relativo “che”, aggiungendo “a”, deve cambiare e diventare “cui”. “Lapersona a cui hai telefonato”. Unoggetto indiretto. Una variante leggermente più formalesarebbe “alla quale”: la persona “alla quale” haitelefonato.
Nel parlato, tuttavia, ècomunissimo usare il semplice “che” anche in casi come questo, dove dovremmo,tecnicamente, avere la preposizione + cui. La frase potrebbe dunque diventare:
La persona che haitelefonato si chiama Federico.
Un errore, sicuramente, dalpunto di vista della lingua standard ma che, nel parlato informale, èabbastanza frequente. Vediamo un altro esempio standard, quindi diciamo“corretto” dal punto di vista delle regole normative:
Il problema di cui parlavi nonsi è verificato.
“Parliamo di qualcosa”, no?Questa è la preposizione. Quindi “il problema di cui parlavi”, si dovrebbe dire.Ma come nell’esempio di prima, possiamo avere anche una versione informale:
Il problema che parlavi non si èverificato.
Ora, se ci sono italiani all’ascolto, forse,alcuni almeno, storceranno ilnaso, ma nel parlato questa costruzione è comunissima. O, ancora, una frase“standard” come:
Sono fortunato, perché non c’èniente di cui ho bisogno (perché l’espressione è, anche qui, “avere bisogno di qualcosa”)può diventare: sono fortunato, perché non c’èniente che ho bisogno (… che, tra l’altro, è una citazione dellafamosissima canzone “ragazzo fortunato” di Jovanotti).
🎶 Sono un ragazzo fortunato perchém’hanno regalato un sogno
Sono fortunato, perché non c’èniente che ho bisogno… 🎶
Ecco, questi sono esempi di“che” polivalente, come lo chiamano i linguisti, cioè di “che” che assume vari usi che nonsarebbero possibili nella lingua standard. Nel parlato, come ho detto, sonosuper comuni, e quindi facci caso.
Concludiamo con un altroclassico, un classico più recente forse, che dà fastidio a un sacco di persone (e unpo’ anche a me, in realtà, lo devo ammettere). Prendiamo questa frase:
Voglio andare al mare piuttostoche in montagna.
Che significa? In italianostandard “piuttosto che” significa “anziché”, “invece di”.Dunque al mare e non in montagna,anziché la montagna: cioè, tra le due opzioni, preferisco la montagna.
Tuttavia dagli anni Ottanta adoggi si è sviluppato un usodi “piuttosto che”, che è nato nel Nord Italia, dalle parti di Milano e Torino,e che poi si è diffuso anche nelresto d’Italia. La cosa curiosa è che, se gli altri “errori” visti finora sono normalmenteconsiderati errori rozzi, che fannopersone poco istruite (che poi inrealtà non è vero perché sono costruzioni che tanti italiani usanocomunemente), in questo caso si tratta di un uso percepito (almeno da chi lousa) come più raffinato, più elegante. Chi lo odia, invece, lo trova fastidioso e snob, unpo’ pretenzioso. Ma vediamolo in azione:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna…
Qui, quello che si sta cercandodi dire, è un semplice “o”, “oppure”. Possiamo andare al mare o inmontagna: sono opzioni valide. Tuttavia, usare quattro sillabe,evidentemente, sembra più ricercato, più elegantedi usare una sola sillaba (“o”).
Spesso, tra l’altro, si usanovari “piuttosto che” in sequenza, come per fare un elenco, unalista di possibilità:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna, piuttosto che in campagna… come vuoi tu.
E dunque si offre un elenco diopzioni. Per chi parla, insomma, vanno bene tutte, perlui o lei, è uguale. Questo usodel “piuttosto che” viene chiamato disgiuntivo: disgiuntivo nellagrammatica è praticamente il significato di o, o oppure.
Va detto che questonuovo “piuttosto che” non si usa in tutti i casi in cui si userebbe “o”. Peresempio, nessuno lo usa nelle domande: non si può dire “vuoi andare al mare piuttostoche in montagna?”. No. Qui, si userebbe solamente “o”. O meglio, possousare ovviamente “piuttosto che” ma nel suo significato originale: “vuoi andareal mare piuttosto che (cioè anziché, invece di) andarein montagna?”. Questo è sempre un uso valido.
Secondo alcuni linguisti“piuttosto che” sta diventando anche un sinonimo di eccetera. Prendendo unesempio reale, pronunciato dall’attuale Presidente del Consiglio GiorgiaMeloni, quando era una ministra, ancora, avremo qualcosa come questo:
Forse anche la politica capiràche Internet non è solamente qualcosa da vietare perché c’è il bullismoche finisce su YouTube, piuttosto che…
Insomma, come dire “eccetera”,“e così via”, “e via dicendo”. Ecco, anche questo, in effetti, a me sembra unuso abbastanza comune. Ecco, questo è uno dei nuovi “errori” linguistici, usi impropri diun’espressione dell’italiano, nonché uno dei piùodiati dalle persone a cui è stato detto che è sbagliato, oppure dalle personeche sono abbastanza anziane, diciamo così, da ricordarsi un mondo in cui questo“piuttosto che” non lo usava nessuno. Perché, in effetti, ormai circola da unpo’ di tempo, e quindi ci saranno generazioni per cui è assolutamente normale.
Scherzi a parte, il fastidio ci può stare, perchéquesto uso più generare, effettivamente, ambiguità. Anche se, personalmente,nella maggior parte dei casi, non faccio fatica a capire, dal contesto e anchedall’intonazione, qual è il significato che gli si dà. L’intonazione è diversa,senti:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna (cioè, “possiamo andare al mare, anziché inmontagna”).
L’altro uso:
Possiamo andare al mare,piuttosto che in montagna… (o una o l’altra; e di solito, magari, ci sonoanche altre opzioni: al mare, piuttosto che in montagna, piuttosto che uncampagna…).
Nello scritto, però, in effetti,diventa più difficile. L’ambiguità che si può creare ha portato molti linguistia esporsi pubblicamente contro questo uso di piuttosto che, cosa, peraltro, rara: inItalia i linguisti e gli studiosi della lingua normalmente sono piuttosto neutri, non si schieranoapertamente contro, o a favore,certi usi. Ma in questo caso lo hanno fatto. Pensa che il cantante LorenzoBaglioni, famoso anche per la sua canzone sul congiuntivo, ha anche dedicatouna canzone anche al “piuttosto che” disgiuntivo.
🎶 Ecco qui la regola che scacciale paure:
“Piuttosto che” non vuol dire“oppure”.
Più più più più piuttosto che…🎶
Inoltre, sull’argogmento, sisono scritti, e si scrivono, articoli, post… si fanno video su YouTube…insomma, si fa molta propaganda contro questo “piuttosto che” ma che finora si è rivelatoabbastanza inutile, visto che continua a usarsi eforse più di prima. Tu cosa ne pensi, l’avevi mai sentito? Ti piace? Fammisapere nei commenti.
Questi erano i quattro erroriche fanno gli italiani di cui volevo parlarti oggi. Ovviamente ce ne sarebberomolti altri: errori col congiuntivo (a cui ho dedicato un video recente),errori di ortografia, ma anche parole usate a sproposito, errorigrammaticali di vario genere… la lista sarebbe molto lunga.
Voglio concludere, però, conquesta riflessione. Le lingue, come sa ogni linguista, cambiano: questo è unfatto inevitabile e scontato. Se non fosse così stareiparlando in latino, in questo momento, o in proto-indoeuropeo. Equindi, se da un lato è normale,ma anche molto utile, che esista una lingua standard, quindi delle norme daseguire, dall’altro lato non cisi può aspettare che le persone le rispettino sempre, è impensabile. Poi ognunoavrà le proprie idiosincrasie linguistiche: a me il “piuttosto che” disgiuntivonon piace molto ma, per esempio, non ho alcun problema con “a me mi”. Èsoggettivo.
E ricordiamoci poi quello chedico sempre: una lingua ha vari registri che possono andare bene in contestidiversi. Così come non ci vestiamo allo stesso modo a un matrimonio e inspiaggia, è normale che si adatti il proprio modo diparlare, o di scrivere, in base ai contesti. Sein contesti informali è normale rilassarsi un po’ di più, in contesti piùcontrollati, più formali, è meglio attenersi alla linguastandard.
Tu, da studente, avrai a che fare consituazioni e contesti di ogni genere… ma, sedovessi ipotizzare, probabilmente avrai a che fare più con situazioni informaliche formali, ed è dunque giusto, secondo me, chequalcuno ti dica che certe forme, in contesti informali, esistono e siusano molto, anche se vanno contro le regoledell’italiano standard e anche al di là dello stigmache hanno e che possono avere. Ed è per questo che te ne ho parlato in questovideo. Ora, se scansioni questo codice QR o segui il link che ti lascio sotto,potrai ripassare tutto quelloche hai imparato e anche fare esercizi. Sono sicuro che il PDF ti piaceràmolto. Non ho altro da dirti, alla prossima.

.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
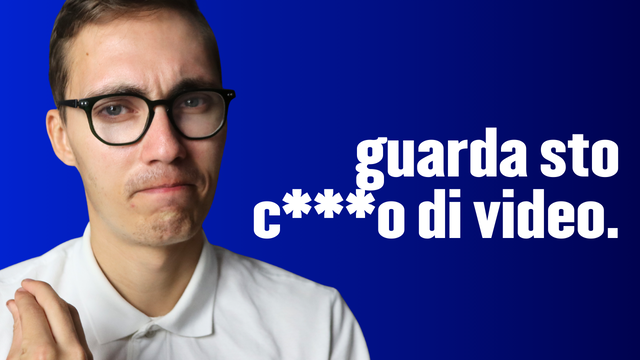
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)

































