Com'è l'ACCENTO di ROMA? 🟥🟧con @SoniaCandy
Roma, la capitale, la città eterna. Ma come si parla a Roma?
Sì, ho già fatto un video sul romano, ma è un po’ vecchio e contiene alcune imprecisioni, dunque oggi lo rifacciamo, parlando però nello specifico dell’accento. E lo farò con un’ospite d’eccezione: la mia amica romana Sonia Candy.
S: Ciao Davide. Senti, ma stavo pensando: vuoi che chiami la mia amica romana,
quella un po’ coatta (=cafona)?
D: Perché no.
S: Oh, bella regà e benvenuti su Podcast Italiano, che è un canale per chi ama o
sta imparando la lingua italiana.
Mi sto già pentendo.
D: Anzitutto voglio precisare che il romano, a differenza di altri “dialetti” italiani (o
lingue regionali), di fatto deriva dal toscano.
S: Dar toscano? Ma che stai addì? Roma caput mundi.
Eh sì. In epoca medievale non era così, a Roma si parlava una varietà più centro-meridionale, simile al napoletano; poi per cause storiche tra Quattrocento e Cinquecento il romano si è toscanizzato, motivo per cui oggi è tutto
sommato molto simile all’italiano e facile da capire. A causa di questo, tra l’altro,
i confini tra dialetto romano e italiano di Roma non sono così netti e capita spesso che
le due varietà si mescolino e che tratti del dialetto entrino nell’italiano di Roma, più di
quanto non succeda da altre parti in Italia. Il romano e l’italiano di Roma hanno sempre
avuto una grande esposizione nei media, nei film, nella cultura italiana in
generale [scena di Alberto Sordi], dunque siamo tutti in Italia abituati a sentirlo. Ed è anche per questo che se impari l’italiano è importante che ti abitui perlomeno all’accento romano.
Il romano ha le classiche sette vocali del toscano e dell’italiano standard, dunque /a/ /i/ /u/ e poi /e/ chiusa, /ɛ/ aperta, /o/ chiusa, /ɔ/ aperta. Tuttavia, romano e fiorentino (o varietà toscane) in alcune parole non concordano sulla vocale da usare. Vediamo qualche… esèmpio.
S: O, come si dice a Roma, “esémpio”.
Ma anche:
lèttera (a Firenze) - léttera
cèntro - céntro
mèmbro - mémbro
E con la O:
dópo - dòpo
sónno - sònno
pósto - pòsto
Ce ne sono un po’ di parole così. Comunque l’accento neutro tradizionale, la ”dizione”, tipicamente preferisce la variante fiorentina.
S: E se sbaja ‘nfatti, se sbaja (=si sbaglia).
D: E poi ci sono non poche parole dove i romani stessi… non si decidono se… aperto o chiuso.
S: E sì, è vero, tipo… grégge… o grègge? Bológna o Bològna? Io non lo so, le uso tutte e due. Boh…
D: In ogni caso, nella maggior parte delle parole il romano a livello di vocali si comporta come il fiorentino e come l’italiano neutro o standard.
Bene, passiamo alle consonanti.
S: ‘nnamo.
Ma prima vi voglio parlare del mio video-corso di pronuncia italiana, Fonetica Italiana Semplice. Se stai imparando l’italiano è sicuramente utile e importante comprendere i principali accenti dell’italiano, tra cui il romano; ma io credo sia utile avere un modello, come l’accento neutro, a cui provare ad ispirarsi nel proprio parlato. Nel corso insegno proprio l’accento neutro (e spiego che cos’è, innanzitutto), cercando però anche di riflettere su che cosa di questo modello è più importante per uno straniero e che cosa invece è più “trascurabile”. Inoltre ti insegno le basi della fonetica articolatoria (che ti aiuteranno a capire meglio questi video, ma anche come funziona la pronuncia della tua lingua), ti parlo di
fenomeni fonetici italiani di cui nessuno probabilmente ti ha mai parlato (se non forse io) e di alcune tecniche per imparare la pronuncia. La notizia è che di recente ho appena aggiunto
un sacco di esercizi al corso, che quindi è ancora più ricco e più completo di prima. Le recensioni degli studenti che l’hanno fatto (prima che aggiungessi gli esercizi) erano già molto positive, il che mi rende molto felice. Ma adesso il corso è ancora migliore. Ho deciso inoltre di offrire uno sconto del 30% solo fino a questa data che vedrai sullo schermo, dunque se ti interessa vai a dare un’occhiata, ma entro questa data.
Dicevo, le consonanti. Molti dei fenomeni di cui parlerò riguardano anche il centro e il sud in generale; li conoscerete già se avete guardato quest’altro mio video.
Il fonema /b/ di “bello” dopo una vocale “gemina” (cioè, si pronuncia come una doppia). Questo è tipico di tutto il Sud e parte del centro (ma non della Toscana).
- tubo diventa tu[bb]o
- Fabio > Fa[bb]io, come mio cugino.
- libro > li[bb]ro
- probabilmente > pro[bb]a[bb]bilmente sì
Anche tra due parole.
Hai fatto bene > Hai fatto [bb]ene proprio.
La bellezza di Bologna > La [bb]bellezza di [bb]ólogna. O Bològna, non lo so.
Deaffricatizzazione di /ʧ/ posvocalico.
S: A Da’, ma che stai addì? Parla come magni (=parla normalmente), pos-che?
D: Tranquilla, è più semplice di quanto sembri, in realtà. In italiano abbiamo /ʧ/, la “C dolce” (o “affricata”) di “cena”, “ciao”, “ciuffo”, “Celentano” che dopo una vocale nel romano (e in buona parte del centro-sud) diventa [ʃ], quindi da “affricata” diventa “fricativa”. La [ʃ]ena.
S: E quinii si deaffricativa… deaffritichivi-… ma come parli, ma te le stai a inventà ste parole (=te le stai inventado)? non so’ italiane…
Questo succede sia all’interno di una parola, come in “bacio” (che si dice ba[ʃ]o) o “recente” (“re[ʃ]ente”), sia tra due parole (“la [ʃ]ena” e “la [ʃ]urma” ); ma non quando /ʧ/ è geminato, quindi “faccia” rimane “faccia”. Te pare che dico “fascia”? La fascia!
[altri esempi da YouTube]
Ora, prendiamo /ʤ/ di “giallo”, cioè la versione sonora di /ʧ/. A Roma e nel centro-sud (ma non in Toscana), esattamente come /b/, /ʤ/ dopo una vocale si allunga, gemina, come se ci fossero due G. Quindi al posto di “agile” o “bugiardo” avremo…
Ah, sì sì, a[ʤʤ]gile, bu[ʤʤ]ardo,
ma anche
“la [ʤʤ]ente”, “la gente sta fori” (=fuori) ma anche “i [ʤʤ]emelli” (che sono i miei cugini).
Le occlusive /p, t, k/, dopo una vocale, si sonorizzano.
S: Si sonorizzano. E mo’ questo che vor dì?
Vuole dire che si aggiunge una vibrazione delle corde vocali. Non diventano completamente sonori, cioè non diventano vere /b/, /d/, /g/ (che sarebbero gli equivalenti sonori di /p/, /t/, /k/), ma stanno a metà. Dunque ci sarà una differenza sottile tra “gioco” e “giogo”,
“noto” e “nodo”. Qualcosa come
gioco > giogo.
noto > nodo
Tu come pronunci “Ipoteca”, Sonia?
Beh, direi “ipoteca”.
E “atipico”?
Atipico.
Però se /p, t, k/ sono geminati, doppi, si pronunciano normali:
Cappello, tatto, specchio
[altri esempi da YouTube]
Nel romano, come anche in tutto il centro-sud (Toscana esclusa), non esiste la S sonora /z/, avremo sempre /s/, anche tra due vocali.
Ca/s/a, ri/s/ata, fa/s/e, france/s/e. Detto ciò, a volte la reale articolazione è una sorta
di via di mezzo tra [s] e [z], un po’ come succede con /p, t, k/ che si sonorizzano, come abbiamo appena visto. Qualcosa come ca[z̥]a, ri[z̥]ata, [z̥] [z̥] [z̥]. Prendiamo la frase “una serata serena senza Simone”. Sonia?
Ma, per esempio… Una [z̥]erata [z̥]erena [z̥]enza [z̥]imone.
Senti? Sembrano quasi delle [z]. Curioso, vero?
Altro fenomeno non esclusivo del romano: /s/ dopo /n/, /l/, /r/ si pronuncia [ʦ]. Dunque avremo “persona”, “falso”, “borsa” pronunciati come se avessero una Z.
Sì, “per[ʦ]ona”, “fal[ʦ]o”, “sen[ʦ]o”, “bor[ʦ]a”.
Anche tra due parole, dunque:
il [ʦ]indaco, non [ʦ]i sente, per [ʦ]icurezza, il [ʦ]en[ʦ]o… della vita.
[altri esempi da YouTube]
/ʎ/, il suono palatale di GLI in parole come “figlio” o “tagliare” tende a diventare /j/, cioè il suono di “ieri”. Dunque “figlio” può pronunciarsi…
Ma tipo “fi[jj]o”?
(con [jj] lungo) o addirittura
o “fi[j]o”.
Sonia, come diresti questa frase?
S: Mio figlio taglia l’aglio.
[altri esempi da YouTube]
Questi erano i fenomeni più comuni, che la maggior parte dei romani ha nel proprio parlato.
Ci sono poi altri fenomeni più marcati percepiti dagli stessi romani come più dialettali, più “bassi” e di conseguenza evitati da molte persone in un parlato più sorvegliato.
S: Personalmente quelli so’ i miei preferiti.
Un fenomeno percepito come molto dialettale è la /rr/ geminata, quindi doppia, che diventa breve; al posto di “terra” dire “te[r]a”; al posto di “ferro” avremo “fe[r]o”.
S: Ma tipo “Il tereno di guera contiene un sacco de fero.” O, però questo è proprio coatto Davide, cioè, lasicamelo dire.
[altri esempi da YouTube]
Un altro fenomeno simile è la sostituzione di /l/ prima di una consonante con /r/: dunque “a[r]tro” al posto di “a[l]tro”, “cortello” al posto di “coltello” e persino l’articolo “il che diventa “er” in dialetto, o in un italiano molto romanizzato.
S: L’artro giorno cercavo er cortello.
Sonia 2: Coltello è giusto, ma si può dire anche “zaccagna”.
S: Ma anche tipo “colpo dopo colpo” diventa “corpo dopo corpo”.
[altri esempi da YouTube]
Lo stesso vale per l’assimilazione di /nd/ in [nn], quindi dire “qua[nn]o” e “m[onn]o” o al posto di “quando” e “mondo”.
S: Quanno è stato creato er monno?
O “andare” che diventa “annare”. Cioè, “annà”, in realtà. Ma di morfologia e sintassi parliamo un’altra volta.
S: Grazie Da’, grazie che ce fai ‘sto favore.
In romano, come nelle varietà del centro-sud e anche in italiano standard, esiste il cosiddetto raddoppiamento fonosintattico o cogeminazione. Cioè, alcune parole fanno geminare la prima consonante della parola successiva. Per esempio: ho (f)fatto, è (c) capace, andrò (s)subito, che (v)vuoi, tu (s)sei brava.
Ne ho parlato qui.
Ci sono alcune piccole differenze, però. A Roma si fa un pochino meno che a Firenze prima di tutto, dove per esempio, a Firenze, si attiva anche con “da” e “dove”, quindi “vengo da (t)te” o “dove (s)sei”, mentre a Roma no (“vengo da te”, “dove sei”?).
C’è poi anche un fenomeno curioso chiamato pre-geminazione, per cui alcune parole si pronunciano automaticamente con la consonante iniziale geminata.
Per esempio in “ce l’ho” (come “hai il libro?” “sì, ce l’ho”), si tende a geminare quella /l/ iniziale.
S: Ce (l)l’ho, il libro. Il mio, che è appena uscito!
Ma avviene spesso anche con queste parole, dunque: “vado (l)lì”; “vieni (q)quì”, “dammene di (p)più”, “la (c)chiesa”, “la (s)sedia”, “pezzo di (m)m-”
[altri esempi da YouTube]
Bene, questo è tutto.
S: Oh, avemo (=abbiamo) fatto. Io me ne posso anna’ (=andare)?
Fatemi sapere nei commenti: vi piace il romano e l’accento romano? V’interessa un secondo video sulle altre caratteristiche del romano, quindi lessico e grammatica? E per chi impara l’italiano, capite bene il romano o lo trovate difficile? Ah, e quale accento vorreste che
trattassi dopo il romano? Scrivetemi.
Io ringrazio Sonia e il suo alter ego.
Ciao ragazzi! Grazie.
Grazie grazie, grazie de che? ‘na piotta (=cento euro), prego.
Sì, dopo te pago.
Tra l’altro lei insegna inglese su Instagram e spesso fa questi personaggi romani bellissimi, dunque seguitela.
Co ‘sta pubblicità me fai uno sconto?
Vabbè dai… mezza piotta.
Vi ricordo l’offerta su Fonetica Italiana Semplice fino a questa data.. Sono davvero fiero di questo corso e penso davvero che piacerà un sacco a chiunque di voi abbia interesse a capire meglio come funziona la fonetica in generale e a comprendere meglio la fonetica italiana… a scoprire fenomeni che nessuno vi ha mai spiegato. Dunque, andate a dare un’occhiata al corso e alla prossima!
Roma, la capitale, la città eterna. Ma come si parla a Roma?
Sì, ho già fatto un video sul romano, ma è un po’ vecchio e contiene alcune imprecisioni, dunque oggi lo rifacciamo, parlando però nello specifico dell’accento. E lo farò con un’ospite d’eccezione: la mia amica romana Sonia Candy.
S: Ciao Davide. Senti, ma stavo pensando: vuoi che chiami la mia amica romana,
quella un po’ coatta (=cafona)?
D: Perché no.
S: Oh, bella regà e benvenuti su Podcast Italiano, che è un canale per chi ama o
sta imparando la lingua italiana.
Mi sto già pentendo.
D: Anzitutto voglio precisare che il romano, a differenza di altri “dialetti” italiani (o
lingue regionali), di fatto deriva dal toscano.
S: Dar toscano? Ma che stai addì? Roma caput mundi.
Eh sì. In epoca medievale non era così, a Roma si parlava una varietà più centro-meridionale, simile al napoletano; poi per cause storiche tra Quattrocento e Cinquecento il romano si è toscanizzato, motivo per cui oggi è tutto
sommato molto simile all’italiano e facile da capire. A causa di questo, tra l’altro,
i confini tra dialetto romano e italiano di Roma non sono così netti e capita spesso che
le due varietà si mescolino e che tratti del dialetto entrino nell’italiano di Roma, più di
quanto non succeda da altre parti in Italia. Il romano e l’italiano di Roma hanno sempre
avuto una grande esposizione nei media, nei film, nella cultura italiana in
generale [scena di Alberto Sordi], dunque siamo tutti in Italia abituati a sentirlo. Ed è anche per questo che se impari l’italiano è importante che ti abitui perlomeno all’accento romano.
Il romano ha le classiche sette vocali del toscano e dell’italiano standard, dunque /a/ /i/ /u/ e poi /e/ chiusa, /ɛ/ aperta, /o/ chiusa, /ɔ/ aperta. Tuttavia, romano e fiorentino (o varietà toscane) in alcune parole non concordano sulla vocale da usare. Vediamo qualche… esèmpio.
S: O, come si dice a Roma, “esémpio”.
Ma anche:
lèttera (a Firenze) - léttera
cèntro - céntro
mèmbro - mémbro
E con la O:
dópo - dòpo
sónno - sònno
pósto - pòsto
Ce ne sono un po’ di parole così. Comunque l’accento neutro tradizionale, la ”dizione”, tipicamente preferisce la variante fiorentina.
S: E se sbaja ‘nfatti, se sbaja (=si sbaglia).
D: E poi ci sono non poche parole dove i romani stessi… non si decidono se… aperto o chiuso.
S: E sì, è vero, tipo… grégge… o grègge? Bológna o Bològna? Io non lo so, le uso tutte e due. Boh…
D: In ogni caso, nella maggior parte delle parole il romano a livello di vocali si comporta come il fiorentino e come l’italiano neutro o standard.
Bene, passiamo alle consonanti.
S: ‘nnamo.
Ma prima vi voglio parlare del mio video-corso di pronuncia italiana, Fonetica Italiana Semplice. Se stai imparando l’italiano è sicuramente utile e importante comprendere i principali accenti dell’italiano, tra cui il romano; ma io credo sia utile avere un modello, come l’accento neutro, a cui provare ad ispirarsi nel proprio parlato. Nel corso insegno proprio l’accento neutro (e spiego che cos’è, innanzitutto), cercando però anche di riflettere su che cosa di questo modello è più importante per uno straniero e che cosa invece è più “trascurabile”. Inoltre ti insegno le basi della fonetica articolatoria (che ti aiuteranno a capire meglio questi video, ma anche come funziona la pronuncia della tua lingua), ti parlo di
fenomeni fonetici italiani di cui nessuno probabilmente ti ha mai parlato (se non forse io) e di alcune tecniche per imparare la pronuncia. La notizia è che di recente ho appena aggiunto
un sacco di esercizi al corso, che quindi è ancora più ricco e più completo di prima. Le recensioni degli studenti che l’hanno fatto (prima che aggiungessi gli esercizi) erano già molto positive, il che mi rende molto felice. Ma adesso il corso è ancora migliore. Ho deciso inoltre di offrire uno sconto del 30% solo fino a questa data che vedrai sullo schermo, dunque se ti interessa vai a dare un’occhiata, ma entro questa data.
Dicevo, le consonanti. Molti dei fenomeni di cui parlerò riguardano anche il centro e il sud in generale; li conoscerete già se avete guardato quest’altro mio video.
Il fonema /b/ di “bello” dopo una vocale “gemina” (cioè, si pronuncia come una doppia). Questo è tipico di tutto il Sud e parte del centro (ma non della Toscana).
- tubo diventa tu[bb]o
- Fabio > Fa[bb]io, come mio cugino.
- libro > li[bb]ro
- probabilmente > pro[bb]a[bb]bilmente sì
Anche tra due parole.
Hai fatto bene > Hai fatto [bb]ene proprio.
La bellezza di Bologna > La [bb]bellezza di [bb]ólogna. O Bològna, non lo so.
Deaffricatizzazione di /ʧ/ posvocalico.
S: A Da’, ma che stai addì? Parla come magni (=parla normalmente), pos-che?
D: Tranquilla, è più semplice di quanto sembri, in realtà. In italiano abbiamo /ʧ/, la “C dolce” (o “affricata”) di “cena”, “ciao”, “ciuffo”, “Celentano” che dopo una vocale nel romano (e in buona parte del centro-sud) diventa [ʃ], quindi da “affricata” diventa “fricativa”. La [ʃ]ena.
S: E quinii si deaffricativa… deaffritichivi-… ma come parli, ma te le stai a inventà ste parole (=te le stai inventado)? non so’ italiane…
Questo succede sia all’interno di una parola, come in “bacio” (che si dice ba[ʃ]o) o “recente” (“re[ʃ]ente”), sia tra due parole (“la [ʃ]ena” e “la [ʃ]urma” ); ma non quando /ʧ/ è geminato, quindi “faccia” rimane “faccia”. Te pare che dico “fascia”? La fascia!
[altri esempi da YouTube]
Ora, prendiamo /ʤ/ di “giallo”, cioè la versione sonora di /ʧ/. A Roma e nel centro-sud (ma non in Toscana), esattamente come /b/, /ʤ/ dopo una vocale si allunga, gemina, come se ci fossero due G. Quindi al posto di “agile” o “bugiardo” avremo…
Ah, sì sì, a[ʤʤ]gile, bu[ʤʤ]ardo,
ma anche
“la [ʤʤ]ente”, “la gente sta fori” (=fuori) ma anche “i [ʤʤ]emelli” (che sono i miei cugini).
Le occlusive /p, t, k/, dopo una vocale, si sonorizzano.
S: Si sonorizzano. E mo’ questo che vor dì?
Vuole dire che si aggiunge una vibrazione delle corde vocali. Non diventano completamente sonori, cioè non diventano vere /b/, /d/, /g/ (che sarebbero gli equivalenti sonori di /p/, /t/, /k/), ma stanno a metà. Dunque ci sarà una differenza sottile tra “gioco” e “giogo”,
“noto” e “nodo”. Qualcosa come
gioco > giogo.
noto > nodo
Tu come pronunci “Ipoteca”, Sonia?
Beh, direi “ipoteca”.
E “atipico”?
Atipico.
Però se /p, t, k/ sono geminati, doppi, si pronunciano normali:
Cappello, tatto, specchio
[altri esempi da YouTube]
Nel romano, come anche in tutto il centro-sud (Toscana esclusa), non esiste la S sonora /z/, avremo sempre /s/, anche tra due vocali.
Ca/s/a, ri/s/ata, fa/s/e, france/s/e. Detto ciò, a volte la reale articolazione è una sorta
di via di mezzo tra [s] e [z], un po’ come succede con /p, t, k/ che si sonorizzano, come abbiamo appena visto. Qualcosa come ca[z̥]a, ri[z̥]ata, [z̥] [z̥] [z̥]. Prendiamo la frase “una serata serena senza Simone”. Sonia?
Ma, per esempio… Una [z̥]erata [z̥]erena [z̥]enza [z̥]imone.
Senti? Sembrano quasi delle [z]. Curioso, vero?
Altro fenomeno non esclusivo del romano: /s/ dopo /n/, /l/, /r/ si pronuncia [ʦ]. Dunque avremo “persona”, “falso”, “borsa” pronunciati come se avessero una Z.
Sì, “per[ʦ]ona”, “fal[ʦ]o”, “sen[ʦ]o”, “bor[ʦ]a”.
Anche tra due parole, dunque:
il [ʦ]indaco, non [ʦ]i sente, per [ʦ]icurezza, il [ʦ]en[ʦ]o… della vita.
[altri esempi da YouTube]
/ʎ/, il suono palatale di GLI in parole come “figlio” o “tagliare” tende a diventare /j/, cioè il suono di “ieri”. Dunque “figlio” può pronunciarsi…
Ma tipo “fi[jj]o”?
(con [jj] lungo) o addirittura
o “fi[j]o”.
Sonia, come diresti questa frase?
S: Mio figlio taglia l’aglio.
[altri esempi da YouTube]
Questi erano i fenomeni più comuni, che la maggior parte dei romani ha nel proprio parlato.
Ci sono poi altri fenomeni più marcati percepiti dagli stessi romani come più dialettali, più “bassi” e di conseguenza evitati da molte persone in un parlato più sorvegliato.
S: Personalmente quelli so’ i miei preferiti.
Un fenomeno percepito come molto dialettale è la /rr/ geminata, quindi doppia, che diventa breve; al posto di “terra” dire “te[r]a”; al posto di “ferro” avremo “fe[r]o”.
S: Ma tipo “Il tereno di guera contiene un sacco de fero.” O, però questo è proprio coatto Davide, cioè, lasicamelo dire.
[altri esempi da YouTube]
Un altro fenomeno simile è la sostituzione di /l/ prima di una consonante con /r/: dunque “a[r]tro” al posto di “a[l]tro”, “cortello” al posto di “coltello” e persino l’articolo “il che diventa “er” in dialetto, o in un italiano molto romanizzato.
S: L’artro giorno cercavo er cortello.
Sonia 2: Coltello è giusto, ma si può dire anche “zaccagna”.
S: Ma anche tipo “colpo dopo colpo” diventa “corpo dopo corpo”.
[altri esempi da YouTube]
Lo stesso vale per l’assimilazione di /nd/ in [nn], quindi dire “qua[nn]o” e “m[onn]o” o al posto di “quando” e “mondo”.
S: Quanno è stato creato er monno?
O “andare” che diventa “annare”. Cioè, “annà”, in realtà. Ma di morfologia e sintassi parliamo un’altra volta.
S: Grazie Da’, grazie che ce fai ‘sto favore.
In romano, come nelle varietà del centro-sud e anche in italiano standard, esiste il cosiddetto raddoppiamento fonosintattico o cogeminazione. Cioè, alcune parole fanno geminare la prima consonante della parola successiva. Per esempio: ho (f)fatto, è (c) capace, andrò (s)subito, che (v)vuoi, tu (s)sei brava.
Ne ho parlato qui.
Ci sono alcune piccole differenze, però. A Roma si fa un pochino meno che a Firenze prima di tutto, dove per esempio, a Firenze, si attiva anche con “da” e “dove”, quindi “vengo da (t)te” o “dove (s)sei”, mentre a Roma no (“vengo da te”, “dove sei”?).
C’è poi anche un fenomeno curioso chiamato pre-geminazione, per cui alcune parole si pronunciano automaticamente con la consonante iniziale geminata.
Per esempio in “ce l’ho” (come “hai il libro?” “sì, ce l’ho”), si tende a geminare quella /l/ iniziale.
S: Ce (l)l’ho, il libro. Il mio, che è appena uscito!
Ma avviene spesso anche con queste parole, dunque: “vado (l)lì”; “vieni (q)quì”, “dammene di (p)più”, “la (c)chiesa”, “la (s)sedia”, “pezzo di (m)m-”
[altri esempi da YouTube]
Bene, questo è tutto.
S: Oh, avemo (=abbiamo) fatto. Io me ne posso anna’ (=andare)?
Fatemi sapere nei commenti: vi piace il romano e l’accento romano? V’interessa un secondo video sulle altre caratteristiche del romano, quindi lessico e grammatica? E per chi impara l’italiano, capite bene il romano o lo trovate difficile? Ah, e quale accento vorreste che
trattassi dopo il romano? Scrivetemi.
Io ringrazio Sonia e il suo alter ego.
Ciao ragazzi! Grazie.
Grazie grazie, grazie de che? ‘na piotta (=cento euro), prego.
Sì, dopo te pago.
Tra l’altro lei insegna inglese su Instagram e spesso fa questi personaggi romani bellissimi, dunque seguitela.
Co ‘sta pubblicità me fai uno sconto?
Vabbè dai… mezza piotta.
Vi ricordo l’offerta su Fonetica Italiana Semplice fino a questa data.. Sono davvero fiero di questo corso e penso davvero che piacerà un sacco a chiunque di voi abbia interesse a capire meglio come funziona la fonetica in generale e a comprendere meglio la fonetica italiana… a scoprire fenomeni che nessuno vi ha mai spiegato. Dunque, andate a dare un’occhiata al corso e alla prossima!




.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
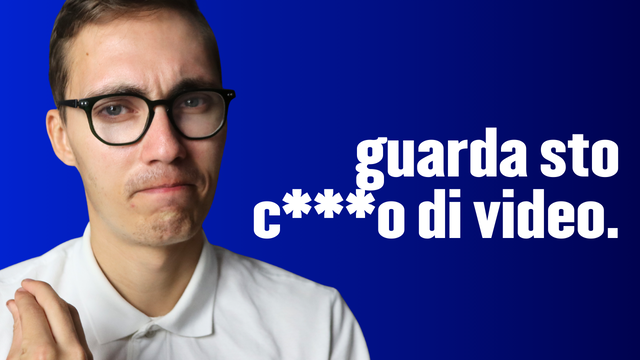
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)






























