Tutte le VOSTRE domande sull'italiano (Q&A)
In questo video rispondo a 7 domande che mi avete fatto su grammatica, pronuncia e lessico!
Abbonandoti al Podcast Italiano Club (livello di bronzo) avrai accesso alle trascrizioni dei video con glossario.
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club (livello di bronzo).
Ok. Ci ho messo tipo mezz’ora per rispondere alla prima domanda, ma va bene.
Ci vuole calma e sangue freddo… comunque, è una canzone famosa. Forse ha vinto un Festival di Sanremo… non lo so. Chi lo guarda Sanremo!
Tutte le vostre domande sulla grammatica!
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Qualche settimana fa vi ho chiesto di bombardarmi di domande sulla grammatica italiana e voi lo avete fatto. Vabbè, bombardarmi, magari no…
E io sono qui per rispondervi in questo video, che è un po’ meno preparato del solito (speriamo non venga un disastro).
In realtà, non mi avete fatto solo domande di grammatica, mi avete fatto domande anche si pronuncia, di lessico e altre cose, quindi diciamo che è, più che altro, un Q&A di lingua italiana.
Io sono Davide, insegno l’italiano su questo canale che si chiama Podcast Italiano. C’è anche un podcast, che si chiama sempre Podcast Italiano, oppure Podcast Italiano Principiante. Ti ricordo che: trovi la trascrizione di questo e di tutti i video sul mio sito, podcastitaliano.com, che puoi attivare i sottotitoli se ne hai bisogno, e anche, come sempre, che abbiamo preparato un PDF, un PDF che contiene tutte le spiegazioni e le risposte che ti darò in questo video in forma scritta, e probabilmente anche in una forma un po’ più coerente di come le spiegherò qui, perché io sono abituato a scrivere ogni singola parola dei miei video, ma in questo video, invece, improvviserò un po’ di più. Ah, nel video menzionerò tanti video e tante risorse che ho creato nel corso del tempo, troverai tutti i link nella descrizione del video e anche nel PDF, ovviamente.
Allora, un bel po’ di persone mi hanno chiesto di parlare di CI e NE. In particolare, telemedicineitaly mi chiede di spiegare la differenza, come se avesse 5 anni, tra c’è, ce, ci, ciò, cioè.
Allora: proviamoci.
C’è significa esiste, è un po come “there is” in inglese. Per esempio, “c’è tempo”; “c’è una persona che ti vuole parlare”; “c’è un problema”; “c’è un nuovo stagista in ufficio”.
Sarebbe there is, oppure hay in spagnolo.
Al plurale, diventa ci sono. Quindi, “ci sono molte persone”, per esempio.
Ora, ce e ci sono varianti della stessa parola. E attenzione a come si scrive ce: c - e, senza apostrofo, senza accento, senza niente. Dicevo, sono varianti di ci: ci è un pronome, quindi sostituisce qualcosa. Ora semplificherò un po’ perché mi hai chiesto suo spiegartelo come una persona di 5 anni, quindi…
Caso 1: ci significa “noi”, e quindi ha ruolo di oggetto diretto.
Oppure, “a noi”, e quindi oggetto indiretto.
Ok, forse se avessi 5 anni non userei questi termini. Ma dai, io rispetto la tua intelligenza. Cercherò di darti comunque una spiegazione semplice.
Ci hanno visto significa hanno visto noi.
Ci hanno chiamato significa hanno chiamato noi.
Ci hanno telefonato significa hanno telefonato a noi.
Ci hanno scritto significa hanno scritto a noi.
Quindi, a volte è come dire noi, a volte come dire a noi: essenzialmente, dipende dal verbo. Ma a cosa serve dire ci se si può anche dire noi o a noi? Detta in maniera semplice, è una questione di enfasi: dire noi o a noi dà più enfasi al pronome.
Ci, nella maggior parte dei casi, è la forma più naturale. Quindi è più naturale dire ci hanno chiamato di hanno chiamato noi, in contesti normali. Ma dipende sempre dal contesto, in realtà.
Poi, caso 2: ci legato a un luogo (per esempio, in Italia, a scuola, in Europa, dentro la macchina, sul tetto). Quindi, essenzialmente, un ci che significa lì o che significa là. E quindi:
Sei mai andato in Italia?No, non ci sono mai andato.
Ci significa in Italia: sostituisce, riprende, in Italia, un luogo.
Siete mai stati in Europa?No, non ci siamo mai stati.
Di nuovo, ci, riprende, sostituisce, in Europa.
Il cane è entrato dentro la macchina?No, non ci è entrato.
Non è entrato dentro la macchina.
Poi abbiamo 3: il ci che ha… che è connesso, che ha un rapporto, diciamo, con varie preposizioni che sostituisce, insieme a quello che viene dopo quelle preposizioni. In particolare, “a”. Per esempio:
Sono riuscito a risolvere il puzzle: ci sono riuscito.
Con… ci, di fatto, sostituisce a risolvere il puzzle, che è una frase, praticamente, in questo caso, che è introdotta dalla preposizione a. Ci sono riuscito: sono riuscito a fare questa cosa.
Oppure:
Sei andato a comprare il pane? Sì, ci sono andato. Sono andato a comprare il pane.
Ora, ce, scritto c - e, è una variante di “ci”. Si trova solo in combinazione con altri pronomi, con paroline (a volte vengono chiamate particelle, particelle pronominali, anche) come “lo”, “la”, “ne”, ecc. Per esempio:
Vi hanno portato i bagagli?Sì, ce li hanno portati (li hanno portati a noi)
Quanti biscotti sono rimasti?Ce ne sono 2 nel sacco…
Guarda cosa succede con un verbo all’infinito, per esempio:
Dove sono i libri? I tuoi cugini dovevano portarceli ieri.
Portarceli. Qui si attacca al verbo all’infinito e non ci sono spazi.
Con il verbo “avere”, spesso, usiamo questo ci (o meglio, questo ce), che non ha un vero significato. E quindi imparalo come una struttura, ovvero quella come ce l’ho, ce l’hai, ce l’ha. Per esempio, ce l’hai il passaporto? Sì, ce l’ho. Qui, questo ce, non ha più un vero significato. Imparalo così com’è. Cel ’ho.
I have it in italiano si dice ce l’ho. Fine.
È raro sentire “lo ho” o, ancora più strano, “l’ho”. Diciamo ce l’ho.
Ma poi c’è anche il c’entra. Questa costruzione è molto comune. Per esempio:
Perché ora ti metti a parlare di arte? Non c’entra niente con la nostra discussione!
Non c’entra niente: non ha alcun rapporto.
Imparala così com’è, in questo caso c - apostrofo - e (c’è) : non c’entra niente.
E poi abbiamo anche espressioni particolari, quelli che vengono chiamati verbi pronominali, o pronominali idiomatici, per esempio:
Riesci a portare i bagagli? Ce la fai?No, non ce la faccio (che significa non riesco, non riesco a farlo: non ce la faccio).
Anche qui il ce non ha un vero significato, fa parte di questa costruzione: imparala così. È probabile anche che troverai il ce in espressioni come questa, in cui non ha un vero significato, e quindi va imparato così, senza farsi troppe domande.
Poi abbiamo ciò:
Mi hai parlato anche di ciò.
Che significa, praticamente, questo, nel senso di questa cosa, questo fatto.
È un pronome, quindi sostituisce qualcosa, e in questo caso sostituisce una frase intera. Per esempio:
La casa è vuota, non c’è nessuno. Ciò è molto strano.
Ciò sostituisce la prima frase, o meglio, le prime sue frasi. Significa questo, questo fatto, questa cosa. Quale cosa? Quale fatto? Il fatto che la casa è vuota, il fatto che non c’è nessuno (o il fatto che non ci sia nessuno: possiamo usare anche il congiuntivo qui, con “il fatto che”).
Mario ha già iniziato a fare i compiti. Ciò (il fatto che Mario abbia iniziato a fare i compiti), ciò mi sorprende, di solito non inizia prima delle 4.
E poi abbiamo cioè, che è questa parolina, congiunzione, avverbio… non importa, che ha varie funzioni. Per esempio:
Arriverò presto, cioè verso le 8.
Qui è un po’ come dire “ovvero verso le 8”. Serve a dare una spiegazione, a spiegare meglio che cosa intendiamo.
Oppure:
Siamo arrivati lunedì. Cioè, no, martedì!
Questo cioè, a volte accompagnato da “no”, ma potrei anche dire solo “cioè, martedì”, si usa per correggere un’informazione che abbiamo detto.
E poi abbiamo un cioè usato molto comunemente nella lingua parlata con la funzione di prendere tempo… ma anche con altri usi, con altre funzioni… che mettiamo un po’ dappertutto. In un altro video abbiamo chiamato queste parole “segnali discorsivi”, no? Si usano un po’ come dei segnali stradali nella conversazione.
Per fare un esempio:
Cioè, boh, non lo so, a me non sembra un comportamento rispettoso, il suo.
Cioè, quel “cioè, boh, non lo so” che spesso diventa “cè”… “cè… cè, boh, non lo so”.
C’è è uno modo di prendere tempo, di iniziare un discorso… magari, a volte, anche di dare un punto di vista diverso, di riformulare quello che abbiamo detto.
Un altro esempio può essereCioè, ma ti rendi conto?Cioè, è assurda ‘sta roba.
A volte è difficile spiegare la funzione di questo cioè, è un segnale discorsivo: lo sentirai moltissimo nel parlato. A volte ha solo la funzione di prendere tempo. Come dicevo, spesso si pronuncia “cè”: cè non lo so, cè ma è assurda sta roba, cè… ma sarebbe un “cioè”, di fatto, e non va confuso con il c’è (c - apostrofo - è, con l’accento) di “c’è un gatto sul tavolo”.
Gli italiani, scrivendo, a volte, si confondono.
Ok. Ci ho messo tipo mezz’ora per rispondere alla prima domanda, ma va bene.
Domanda numero 2: è una domanda di fonetica, di pronuncia, cioè (cioè!): c’è un accento più bello di altri?
Allora, questa è una questione molto soggettiva perché a me può piacere un accento, a te può piacere un altro accento, al tuo vicino di casa può piacere un terzo accento, a me non piace quello che piace a te…: è molto soggettiva la questione. Quindi… diciamo così, forse la domanda migliore da porsi è: esiste un accento neutro, un accento “standard” in italiano?
È una domanda complessa; la mia posizione è questa: sì, esiste un accento neutro, non è l’accento di una città, non è l’accento di Firenze, di Roma, o di Milano, no. È l’accento dei professionisti della parola. Quindi, per esempio, dei doppiatori, degli attori di teatro, di certi presentatori televisivi, di certi speaker della radio. È, essenzialmente, un modo di parlare che si apprende, ma che viene effettivamente riconosciuto dagli italiani (almeno dalla maggior parte degli italiani) come l’accento più neutro. Essenzialmente, un accento che non ha caratteristiche considerabili “regionali”. È un modo di nascondere la propria provenienza, e qualcuno considera questo un problema, perché dice “no, non bisogna vergognarsi della propria provenienza” ma io non la vedo in questo modo. In certi contesti non si vuole che la propria provenienza distragga chi ci ascolta, perché a volte non ha senso mostrarla. Per esempio, se parliamo di una rappresentazione teatrale, magari di Shakespeare, perché io devo avere un accento torinese? O… io sono di Torino. Non avrebbe molto senso, caratterizzerebbe in una maniera strana un’opera che con Torino non ha niente a che fare. Oppure il doppiaggio, no? Il doppiaggio di un film straniero. A volte si possono usare gli accenti per rendere degli specifici accenti in lingue straniere, e quindi può aver senso fare gli accenti…
Ma se non vogliamo caratterizzare, in modo particolare, l'accento delle persone, serve un accento neutro. Oppure, in un annuncio ufficiale, diciamo. Un annuncio in una stazione, o al telegiornale, ecco: ha senso che esista un modo neutro di parlare, dal mio punto di vista. Non tutti sono d’accordo.
Attenzione, l’accento neutro non è necessariamente migliore o più bello degli altri, o più prestigioso; poi si possono dare anche questi giudizi di valore ma, per me, l’accento neutro è semplicemente l’accento meno regionale. Questo è come la penso io. Io, personalmente, adotto (almeno provo a farlo!) un accento neutro nei miei video. E poi ho anche fatto un corso di pronuncia dove insegno l’accento neutro, essenzialmente, anche se, in generale, insegno la pronuncia italiana a stranieri: non è un corso di dizione per italiani, ok?
Poi sono dell’idea che non sia troppo importante acquisire in toto un accento neutro, anche perché è molto difficile per uno straniero, è più importante capire quali sono le caratteristiche straniere nel proprio accento. Ma, secondo me, questo accento neutro è un buon modello da seguire, a cui ispirarsi, se non si hanno preferenze di accentri regionali, cioè se non ti importa imparare l’accento milanese, o siciliano, o romano. Vuoi un accento neutro? Io ti consiglio, appunto, l’accento neutro. Fonetica Italiana Semplice è il corso che fa per te, in questo caso. Ma ho anche fatto un video sull’accento neutro che è di qualche anno fa ma…non lo riguardo da un po’ ma non penso sia male, se me lo ricordo. Questo è il video.
A proposito, volevo farti vedere questa penna di Podcast Italiano che mi hanno regalato. È arrivata per posta, incredibile. Una campagna di marketing furba, anche se non ho ancora comprato le penne di questa azienda che me le ha mandate. Vabbè, magari lo farò.
Poi, terza domanda: il passato remoto si usa molto nella vita quotidiana?
In generale, ti direi di no, ma dipende. Al Sud si usa, in generale, di più, ma dipende comunque dalla regione; al Centro generalmente si usa un po’ meno; e al Nord non si usa praticamente mai. Poi, in generale, ti posso dire che c’è un declino del passato remoto, che si usa sempre meno in tutta Italia, e che viene sempre più sostituito dal passato prossimo (questa, tra l’altro, è una tendenza che sta avvenendo anche in altre lingue europee, come in francese e in tedesco) e che sta venendo sostituito, secondo me, (questa è la mia, personale, teoria) anche dal trapassato prossimo in un suo uso innovativo. Per esempio:
Quell’anno andammo in Francia, ti ricordi?
Raramente parliamo così, ma è probabile, oggi, dire qualcosa come:
Quell’anno eravamo andati in Francia, ti ricordi?
Questo non è l’uso standard del trapassato prossimo, cioè eravamo andati: questo è un argomento un po’ nerd ti cui ho parlato in questo video. Comunque, se vuoi approfondire il passato remoto, ne ho parlato anche in quest’altro video, e ne parlo anche nel corso avanzato di lingua e di cultura Dentro l’Italia.
Domanda 4: “come si usa anzi?” chiede… non mi ricordo chi! Non ho i vostri nomi ma forse è meglio così perché li pronuncerei malissimo, quindi trovate i vostri nomi a schermo. Dunque, “anzi” è una delle mie paroline preferite dell’italiano. Voglio partire dall’etimologia, perché “anzi” significa “prima, davanti”. Pensa, per esempio, a “anti”, “ante”, no? Come anticipare (spostare in avanti, no?), antico (qualcosa che è antico è qualcosa che viene prima, no? Che è nato prima), ma anche anziano, o anteriore, no? Anteriore significa che è davanti, che si trova davanti. Davanti o prima. Questa è l’etimologia. Vediamo però come si usa in italiano moderno, con degli esempi:
Guarda che Piero non è in ritardo, anzi, è in anticipo.
Qui serve per correggere quello che dice qualcuno: non è in ritardo, anzi, è in anticipo. Ma c’è una correzione di tipo diverso, per esempio:
È andata bene, anzi, benissimo.
O ancora:
Mi piace molto, anzi, mi piace moltissimo.
Qua è una correzione che, in realtà, non ribalta quello che si è detto, ma aggiunge intensità, enfatizza ancora di più quello che si è detto.
Poi abbiamo questo uso:
Mi sa che mi faccio una pasta stasera. Anzi, magari ordino il sushi.
Ecco, qui è un cambio di idea, stiamo cambiando idea, ragionando ad alta voce, una cosa che spesso succede, e la nuova idea che sostituisce quella precedente viene introdotto da anzi.
Magari registro un video oggi.
Anzi, no, registro quel podcast che devo registrare da tempo!
E poi abbiamo anzitutto, che significa prima di tutto, no? Lo usiamo molto all’inizio di un elenco: anzitutto ti voglio parlare dell’etimologia di “anzi”, poi ti voglio parlare di come si usa.
Abbiamo anche anziché: anziché significa invece che o al posto di.
Poi abbiamo anche poc’anzi (è italiano un po’ formale, un po’ antiquato), ma a me piace molto dire poc’anzi che significa poco fa: poc’anzi ti ho parlato della etimologia di “anzi” (cioè poco fa).
Poi, qualcuno chiedeva di occorre, bisogna, ho bisogno di, mi serve: qual è la differenza tra tutti questi verbi e queste espressioni? Vediamo un po’.
Ci vuole e serve, innanzitutto, sono di registro medio-informale; e che cosa significa? Allora: ci vuole e serve, di fatto, significano è necessario. Per esempio, nella canzone “…ci vuole calma e sangue freddo…”, Luca Dirisio (non so se… cosa faccia, se sia ancora in attività, comunque, una canzone famosa…forse ha vinto un Festival di Sanremo? Non lo so. Chi lo guarda Sanremo!).
Per esempio:
Ci vuole tempo per imparare una lingua.
Ma potrei dire:
Serve tempo per imparare una lingua.
Così come “serve calma e sangue freddo”.
Poi, visto che hai menzionato “mi serve”: beh, serve può essere, in generale, “serve tempo”, ma poi possiamo anche dire a chi serve quella cosa, tempo, energie… quindi l’oggetto indiretto. “Mi serve tempo”: a me, a tuo fratello, a tuo cugino.
Mi serve tempo per imparare l’italiano.
Ma anche ti serve, gli serve, ci serve, le serve… eccetera.
Occorre è più formale.
Occorre calma sangue freddo.
Occorre tempo per imparare una lingua.
È un po’ più formale. Anche se occorre, secondo me, si usa soprattutto con un verbo all’infinito. Ora lo vediamo. Però, attenzione: occorre non si usa come in inglese o come in spagnolo (to occur o occurrir). Non si usa così, quindi in quei casi diremmo “che è successo?”, “che è avvenuto?” ma non diciamo “che è occorso?”, ok? No. Quindi che è avvenuto, che è successo, che è capitato, anche.
Poi, bisogna è un registro medio-informale, ed è seguito da un verbo, per esempio:
Bisogna avere calma e sangue freddo.
Bisogna investire tempo per imparare una lingua.
Ok? Bisogna + verbo, sempre. E anche occorre, come dicevo, solitamente, è seguito da un verbo all’infinito.
Occorre avere calma.
Occorre investire tempo.
Poi abbiamo anche c’è bisogno, che non hai menzionato ma che è molto comune, che è medio-informale; per esempio:
C’è bisogno di calma e di sangue freddo (che, di nuovo, è come come dire serve, è come dire ci vuole, c’è bisogno di tempo per imparare una lingua).
Ma poi abbiamo anche ho bisogno oppure hai bisogno, ha bisogno, avere bisogno. “Ho bisogno”, direi, che è registro medio, non è troppo informale, quindi:
Ho bisogno del tuo aiuto.
Ho bisogno che tu mi aiuti.
Ma potrei dire mi serve il tuo aiuto.
Mi serve che tu mi aiuti.
Spero di averti aiutato. Fammi sapere se ti servono altre spiegazioni.
Oh! Si impersonale e si passivante.
Mi chiedete di fare un po’ di chiarezza in merito.
Partiamo dal si impersonale. Il si impersonale indica un’azione o qualcosa che succede, un processo che avviene, e che non riguarda me, te, Giovanni… ma riguarda tutti. La fanno o succede a tutti, a tante persone, alla gente in generale, ok? Quindi:
Si mangia tardi in Italia.
Ok? Qui stiamo descrivendo un’abitudine italiana. Forse, magari al sud Italia, più che altro. Si mangia tardi al sud Italia: in generale, la gente mangia tardi. Oppure, una domanda comune: si va? Cioè andiamo? Usciamo? Ma può essere usata anche in contesti più formali, per esempio:
Si vuole convincere le persone di qualcosa di falso.
Cioè qualcuno sta facendo questa cosa, questo tentativo, non sappiamo chi.
Nota che in Toscana si usa molto al posto del verbo, dei verbi coniugati alla forma forma del “noi”. No? Spesso anche insieme al “noi”. Quindi, al posto di noi andiamo, si dirà, in Toscana, noi si va. Che è un po’ come il francese, se sai il francese: nous on y va. In effetti, spesso, ricorda anche un noi.
Cioè, se dico oggi si è andati a pescare, di fatto significa noi siamo andati a pescare. Vediamo il si passivante o si passivo, questo passivante… perché i grammatici devono essere così…no? Sempre paroloni complicati…
Ma vediamo prima un esempio di una frase normale con un oggetto diretto:
La gente mangia molta pasta in Italia.
Questa è una frase attiva, non passiva, in cui molta pasta è l’oggetto è diretto.
Ora vediamo una frase con il si passivo, o si passivante.
Si mangia molta pasta in Italia.
Questa è una frase con il si passivo, e molta pasta è il soggetto di questa frase, e vedremo dopo perché il soggetto.
Ma ora vediamo la stessa frase al passivo:
Molta pasta viene mangiata in Italia, o molta pasta è mangiata in Italia.
La frase al passivo è un po’ strana, un po’ troppo formale. Nella conversazione comune si usa molto più di frequente la frase con il si passivo, si mangia molta pasta in Italia.
Facciamo un altro esempio:
Si dicono cose interessanti, in questi incontri.
Se trasformiamo questa frase in una tradizionale frase passiva, abbiamo:
Sono (o vengono) dette cose interessanti in questi incontri.
Vengono dette è molto più naturale, in questo caso.
Nota anche che ho detto “si dicono” cose interessanti: quindi qui abbiamo un verbo plurale che si accorda con il soggetto plurale. Infatti il soggetto si accorda con il verbo. E nella frase passiva succede la stessa cosa:
Sono (o vengono) dette (al plurale) cose interessanti.
Quindi, la frase con il si passivo è essenzialmente equivalente a una frase passiva ma, in alcuni casi, è una struttura un po’ meno formale, perché le frasi passive sono un po’ meno formali in italiano.
Facciamo un ultimo esempio:
In questa città, ultimamente, si sono costruiti molti edifici.
Frase con il passivo.
In questa città ultimamente sono stati costruiti molti edifici.
C’è, poi, anche il si riflessivo, ma non me l’hai chiesto, e quindi non ne parlo.
È il caso, per esempio, di “Luca si lava tutte le mattine”.
Lava se stesso.
Vabbè, ormai ne sto parlando! Vabbè, no, non voglio entrare nel si riflessivo se no il video diventa ancora più lungo.
E se abbiamo un si impersonale o passivo combinato con un si riflessivo, succede questo: ci si alza presto in questa casa. Ci si alza presto. Lo sapevi?
Ultima domanda. torniamo alla fonetica, alla pronuncia.
Come dire la R come gli italiani.
Allora, questo dipende molto dalla tua lingua di partenza. Perché, se parli una lingua in cui hai /r/ o /rr/, non sarà difficile. Se parti da una lingua come l’inglese, il francese o il tedesco, sarà una grande rottura di ca.
Allora, abbiamo due suoni, essenzialmente: il suono monovibrante e polivibrante (cioè, una vibrazione e più vibrazioni; in inglese si chiamano tap o trill).Quindi, il primo è /r/ e il secondo è /R/. Ora, presumo che tu parli inglese, non so perché, ma mettiamo questo caso. E se parli inglese americano, o australiano, la monovibrante, il tap, è il suono che è in parole come “better” (o better in australiano).
È lo stesso suono, essenzialmente, di caro, caro caro. Better, caro.
Con la punta della lingua che tocca gli alveoli, cioè la zona del palato immediatamente dietro i denti. Better.
La polivibrante, cioè il trillo, è più difficile. Mi baso su una spiegazione che ha dato il fonetista Luke Nicholson, e questo è un modo che forse ti può aiutare se non sai fare /rrrr/, che è molto difficile. È un suono difficile e tanti italiani non lo sanno fare. È un difetto di pronuncia, chiamiamolo cosi, molto comune. Ora, forse sai fare questo suono. Brrrr. Brrrr. Questo è il suono che fai quando fa freddo. No? Brrrr. Che freddo! Brrrrr. Se sai fare questo suono, e lo fai, ti accorgi che non stai muovendo tu le labbra, ma è l’aria che fai passare che muove le labbra. Ok? Si muovono da sole le labbra. Questo solo per abituarsi a questa sensazione di aria e di pressione che fa vibrare… fa vibrare, in questo caso, le labbra.
Ora, passiamo in concreto alla /r/.
Parti da ɑːdɑː, ɑːdɑː, ɑːdɑː. Da (quindi il suono della D) e nota il punto dove la punta della lingua tocca il palato, appunto, gli alveoli dietro i denti. D,d,d,d,d.
Ora fai una pausa sulla d. D. A-d. Ok? Magari in realtà sai già pronunciare la R. Sai pronunciare la singola R, beh, quella è la posizione di partenza. Ma se non sai pronunciare neanche la R è utile partire dalla D. Ora, nota che quando dici a- da, i lati della lingua toccano i lati dei denti superiori. D- d- d-.
Fermati proprio su (…): senti la pressione dell’aria che aumenta proprio dietro la punta della lingua? A-… . Ecco, ora, in questa posizione, butta fuori molta aria molto velocemente, ma tenendo i lati della lingua sempre nella stessa posizione, contro i lati dei denti. Se butti aria in maniera molto intensa, qualcosa del genere: (…).
Non è la R, perché per la R devi far vibrare anche le corde vocali, e quindi fare R, R, R.
Esercitati, probabilmente non ci sei riuscito, ma perché è molto difficile. Fai attenzione che la punta della lingua è anche molto rilassata, la tendenza è di tenerla molto tesa. Ricorda che non la devi muovere tu, ma è l’aria che la muove. Rrrrrrrrr. Ok? È l’aria che passa con grande forza e intensità, proprio come nel caso di brrrrrrrrr. Anche qui è l’aria che fa muovere le labbra.
Bene, questo è tutto. Comunque, se vuoi una dimostrazione da una persona più esperta di me, ti lascio un link al blog di Luke Nicholson dove te lo spiega. E se vuoi approfondire la pronuncia italiana, in Fonetica Italiana Semplice ti spiego tutti i suoni dell’italiano, tutti i principali fenomeni fonetici che devi conoscere se vuoi imparare l’italiano e, se t’interessa, anche scoprire come funziona quel modello neutro (o quell’accento neutro) di cui ti parlavo prima in questo video.
Detto questo, ricorda che nel PDF troverai riassunte tutte le informazioni che ho spiegato, spero, in maniera vagamente coerente in questo video, le troverai lì, troverai informazioni aggiuntive. Può scaricare il PDF usando il link in descrizione oppure scansionando questo codice QR.
Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video.
Ok. Ci ho messo tipo mezz’ora per rispondere alla prima domanda, ma va bene.
Ci vuole calma e sangue freddo… comunque, è una canzone famosa. Forse ha vinto un Festival di Sanremo… non lo so. Chi lo guarda Sanremo!
Tutte le vostre domande sulla grammatica!
Trascrizione e glossario sul Podcast Italiano Club
Qualche settimana fa vi ho chiesto di bombardarmi di domande sulla grammatica italiana e voi lo avete fatto. Vabbè, bombardarmi, magari no…
E io sono qui per rispondervi in questo video, che è un po’ meno preparato del solito (speriamo non venga un disastro).
In realtà, non mi avete fatto solo domande di grammatica, mi avete fatto domande anche si pronuncia, di lessico e altre cose, quindi diciamo che è, più che altro, un Q&A di lingua italiana.
Io sono Davide, insegno l’italiano su questo canale che si chiama Podcast Italiano. C’è anche un podcast, che si chiama sempre Podcast Italiano, oppure Podcast Italiano Principiante. Ti ricordo che: trovi la trascrizione di questo e di tutti i video sul mio sito, podcastitaliano.com, che puoi attivare i sottotitoli se ne hai bisogno, e anche, come sempre, che abbiamo preparato un PDF, un PDF che contiene tutte le spiegazioni e le risposte che ti darò in questo video in forma scritta, e probabilmente anche in una forma un po’ più coerente di come le spiegherò qui, perché io sono abituato a scrivere ogni singola parola dei miei video, ma in questo video, invece, improvviserò un po’ di più. Ah, nel video menzionerò tanti video e tante risorse che ho creato nel corso del tempo, troverai tutti i link nella descrizione del video e anche nel PDF, ovviamente.
Allora, un bel po’ di persone mi hanno chiesto di parlare di CI e NE. In particolare, telemedicineitaly mi chiede di spiegare la differenza, come se avesse 5 anni, tra c’è, ce, ci, ciò, cioè.
Allora: proviamoci.
C’è significa esiste, è un po come “there is” in inglese. Per esempio, “c’è tempo”; “c’è una persona che ti vuole parlare”; “c’è un problema”; “c’è un nuovo stagista in ufficio”.
Sarebbe there is, oppure hay in spagnolo.
Al plurale, diventa ci sono. Quindi, “ci sono molte persone”, per esempio.
Ora, ce e ci sono varianti della stessa parola. E attenzione a come si scrive ce: c - e, senza apostrofo, senza accento, senza niente. Dicevo, sono varianti di ci: ci è un pronome, quindi sostituisce qualcosa. Ora semplificherò un po’ perché mi hai chiesto suo spiegartelo come una persona di 5 anni, quindi…
Caso 1: ci significa “noi”, e quindi ha ruolo di oggetto diretto.
Oppure, “a noi”, e quindi oggetto indiretto.
Ok, forse se avessi 5 anni non userei questi termini. Ma dai, io rispetto la tua intelligenza. Cercherò di darti comunque una spiegazione semplice.
Ci hanno visto significa hanno visto noi.
Ci hanno chiamato significa hanno chiamato noi.
Ci hanno telefonato significa hanno telefonato a noi.
Ci hanno scritto significa hanno scritto a noi.
Quindi, a volte è come dire noi, a volte come dire a noi: essenzialmente, dipende dal verbo. Ma a cosa serve dire ci se si può anche dire noi o a noi? Detta in maniera semplice, è una questione di enfasi: dire noi o a noi dà più enfasi al pronome.
Ci, nella maggior parte dei casi, è la forma più naturale. Quindi è più naturale dire ci hanno chiamato di hanno chiamato noi, in contesti normali. Ma dipende sempre dal contesto, in realtà.
Poi, caso 2: ci legato a un luogo (per esempio, in Italia, a scuola, in Europa, dentro la macchina, sul tetto). Quindi, essenzialmente, un ci che significa lì o che significa là. E quindi:
Sei mai andato in Italia?No, non ci sono mai andato.
Ci significa in Italia: sostituisce, riprende, in Italia, un luogo.
Siete mai stati in Europa?No, non ci siamo mai stati.
Di nuovo, ci, riprende, sostituisce, in Europa.
Il cane è entrato dentro la macchina?No, non ci è entrato.
Non è entrato dentro la macchina.
Poi abbiamo 3: il ci che ha… che è connesso, che ha un rapporto, diciamo, con varie preposizioni che sostituisce, insieme a quello che viene dopo quelle preposizioni. In particolare, “a”. Per esempio:
Sono riuscito a risolvere il puzzle: ci sono riuscito.
Con… ci, di fatto, sostituisce a risolvere il puzzle, che è una frase, praticamente, in questo caso, che è introdotta dalla preposizione a. Ci sono riuscito: sono riuscito a fare questa cosa.
Oppure:
Sei andato a comprare il pane? Sì, ci sono andato. Sono andato a comprare il pane.
Ora, ce, scritto c - e, è una variante di “ci”. Si trova solo in combinazione con altri pronomi, con paroline (a volte vengono chiamate particelle, particelle pronominali, anche) come “lo”, “la”, “ne”, ecc. Per esempio:
Vi hanno portato i bagagli?Sì, ce li hanno portati (li hanno portati a noi)
Quanti biscotti sono rimasti?Ce ne sono 2 nel sacco…
Guarda cosa succede con un verbo all’infinito, per esempio:
Dove sono i libri? I tuoi cugini dovevano portarceli ieri.
Portarceli. Qui si attacca al verbo all’infinito e non ci sono spazi.
Con il verbo “avere”, spesso, usiamo questo ci (o meglio, questo ce), che non ha un vero significato. E quindi imparalo come una struttura, ovvero quella come ce l’ho, ce l’hai, ce l’ha. Per esempio, ce l’hai il passaporto? Sì, ce l’ho. Qui, questo ce, non ha più un vero significato. Imparalo così com’è. Cel ’ho.
I have it in italiano si dice ce l’ho. Fine.
È raro sentire “lo ho” o, ancora più strano, “l’ho”. Diciamo ce l’ho.
Ma poi c’è anche il c’entra. Questa costruzione è molto comune. Per esempio:
Perché ora ti metti a parlare di arte? Non c’entra niente con la nostra discussione!
Non c’entra niente: non ha alcun rapporto.
Imparala così com’è, in questo caso c - apostrofo - e (c’è) : non c’entra niente.
E poi abbiamo anche espressioni particolari, quelli che vengono chiamati verbi pronominali, o pronominali idiomatici, per esempio:
Riesci a portare i bagagli? Ce la fai?No, non ce la faccio (che significa non riesco, non riesco a farlo: non ce la faccio).
Anche qui il ce non ha un vero significato, fa parte di questa costruzione: imparala così. È probabile anche che troverai il ce in espressioni come questa, in cui non ha un vero significato, e quindi va imparato così, senza farsi troppe domande.
Poi abbiamo ciò:
Mi hai parlato anche di ciò.
Che significa, praticamente, questo, nel senso di questa cosa, questo fatto.
È un pronome, quindi sostituisce qualcosa, e in questo caso sostituisce una frase intera. Per esempio:
La casa è vuota, non c’è nessuno. Ciò è molto strano.
Ciò sostituisce la prima frase, o meglio, le prime sue frasi. Significa questo, questo fatto, questa cosa. Quale cosa? Quale fatto? Il fatto che la casa è vuota, il fatto che non c’è nessuno (o il fatto che non ci sia nessuno: possiamo usare anche il congiuntivo qui, con “il fatto che”).
Mario ha già iniziato a fare i compiti. Ciò (il fatto che Mario abbia iniziato a fare i compiti), ciò mi sorprende, di solito non inizia prima delle 4.
E poi abbiamo cioè, che è questa parolina, congiunzione, avverbio… non importa, che ha varie funzioni. Per esempio:
Arriverò presto, cioè verso le 8.
Qui è un po’ come dire “ovvero verso le 8”. Serve a dare una spiegazione, a spiegare meglio che cosa intendiamo.
Oppure:
Siamo arrivati lunedì. Cioè, no, martedì!
Questo cioè, a volte accompagnato da “no”, ma potrei anche dire solo “cioè, martedì”, si usa per correggere un’informazione che abbiamo detto.
E poi abbiamo un cioè usato molto comunemente nella lingua parlata con la funzione di prendere tempo… ma anche con altri usi, con altre funzioni… che mettiamo un po’ dappertutto. In un altro video abbiamo chiamato queste parole “segnali discorsivi”, no? Si usano un po’ come dei segnali stradali nella conversazione.
Per fare un esempio:
Cioè, boh, non lo so, a me non sembra un comportamento rispettoso, il suo.
Cioè, quel “cioè, boh, non lo so” che spesso diventa “cè”… “cè… cè, boh, non lo so”.
C’è è uno modo di prendere tempo, di iniziare un discorso… magari, a volte, anche di dare un punto di vista diverso, di riformulare quello che abbiamo detto.
Un altro esempio può essereCioè, ma ti rendi conto?Cioè, è assurda ‘sta roba.
A volte è difficile spiegare la funzione di questo cioè, è un segnale discorsivo: lo sentirai moltissimo nel parlato. A volte ha solo la funzione di prendere tempo. Come dicevo, spesso si pronuncia “cè”: cè non lo so, cè ma è assurda sta roba, cè… ma sarebbe un “cioè”, di fatto, e non va confuso con il c’è (c - apostrofo - è, con l’accento) di “c’è un gatto sul tavolo”.
Gli italiani, scrivendo, a volte, si confondono.
Ok. Ci ho messo tipo mezz’ora per rispondere alla prima domanda, ma va bene.
Domanda numero 2: è una domanda di fonetica, di pronuncia, cioè (cioè!): c’è un accento più bello di altri?
Allora, questa è una questione molto soggettiva perché a me può piacere un accento, a te può piacere un altro accento, al tuo vicino di casa può piacere un terzo accento, a me non piace quello che piace a te…: è molto soggettiva la questione. Quindi… diciamo così, forse la domanda migliore da porsi è: esiste un accento neutro, un accento “standard” in italiano?
È una domanda complessa; la mia posizione è questa: sì, esiste un accento neutro, non è l’accento di una città, non è l’accento di Firenze, di Roma, o di Milano, no. È l’accento dei professionisti della parola. Quindi, per esempio, dei doppiatori, degli attori di teatro, di certi presentatori televisivi, di certi speaker della radio. È, essenzialmente, un modo di parlare che si apprende, ma che viene effettivamente riconosciuto dagli italiani (almeno dalla maggior parte degli italiani) come l’accento più neutro. Essenzialmente, un accento che non ha caratteristiche considerabili “regionali”. È un modo di nascondere la propria provenienza, e qualcuno considera questo un problema, perché dice “no, non bisogna vergognarsi della propria provenienza” ma io non la vedo in questo modo. In certi contesti non si vuole che la propria provenienza distragga chi ci ascolta, perché a volte non ha senso mostrarla. Per esempio, se parliamo di una rappresentazione teatrale, magari di Shakespeare, perché io devo avere un accento torinese? O… io sono di Torino. Non avrebbe molto senso, caratterizzerebbe in una maniera strana un’opera che con Torino non ha niente a che fare. Oppure il doppiaggio, no? Il doppiaggio di un film straniero. A volte si possono usare gli accenti per rendere degli specifici accenti in lingue straniere, e quindi può aver senso fare gli accenti…
Ma se non vogliamo caratterizzare, in modo particolare, l'accento delle persone, serve un accento neutro. Oppure, in un annuncio ufficiale, diciamo. Un annuncio in una stazione, o al telegiornale, ecco: ha senso che esista un modo neutro di parlare, dal mio punto di vista. Non tutti sono d’accordo.
Attenzione, l’accento neutro non è necessariamente migliore o più bello degli altri, o più prestigioso; poi si possono dare anche questi giudizi di valore ma, per me, l’accento neutro è semplicemente l’accento meno regionale. Questo è come la penso io. Io, personalmente, adotto (almeno provo a farlo!) un accento neutro nei miei video. E poi ho anche fatto un corso di pronuncia dove insegno l’accento neutro, essenzialmente, anche se, in generale, insegno la pronuncia italiana a stranieri: non è un corso di dizione per italiani, ok?
Poi sono dell’idea che non sia troppo importante acquisire in toto un accento neutro, anche perché è molto difficile per uno straniero, è più importante capire quali sono le caratteristiche straniere nel proprio accento. Ma, secondo me, questo accento neutro è un buon modello da seguire, a cui ispirarsi, se non si hanno preferenze di accentri regionali, cioè se non ti importa imparare l’accento milanese, o siciliano, o romano. Vuoi un accento neutro? Io ti consiglio, appunto, l’accento neutro. Fonetica Italiana Semplice è il corso che fa per te, in questo caso. Ma ho anche fatto un video sull’accento neutro che è di qualche anno fa ma…non lo riguardo da un po’ ma non penso sia male, se me lo ricordo. Questo è il video.
A proposito, volevo farti vedere questa penna di Podcast Italiano che mi hanno regalato. È arrivata per posta, incredibile. Una campagna di marketing furba, anche se non ho ancora comprato le penne di questa azienda che me le ha mandate. Vabbè, magari lo farò.
Poi, terza domanda: il passato remoto si usa molto nella vita quotidiana?
In generale, ti direi di no, ma dipende. Al Sud si usa, in generale, di più, ma dipende comunque dalla regione; al Centro generalmente si usa un po’ meno; e al Nord non si usa praticamente mai. Poi, in generale, ti posso dire che c’è un declino del passato remoto, che si usa sempre meno in tutta Italia, e che viene sempre più sostituito dal passato prossimo (questa, tra l’altro, è una tendenza che sta avvenendo anche in altre lingue europee, come in francese e in tedesco) e che sta venendo sostituito, secondo me, (questa è la mia, personale, teoria) anche dal trapassato prossimo in un suo uso innovativo. Per esempio:
Quell’anno andammo in Francia, ti ricordi?
Raramente parliamo così, ma è probabile, oggi, dire qualcosa come:
Quell’anno eravamo andati in Francia, ti ricordi?
Questo non è l’uso standard del trapassato prossimo, cioè eravamo andati: questo è un argomento un po’ nerd ti cui ho parlato in questo video. Comunque, se vuoi approfondire il passato remoto, ne ho parlato anche in quest’altro video, e ne parlo anche nel corso avanzato di lingua e di cultura Dentro l’Italia.
Domanda 4: “come si usa anzi?” chiede… non mi ricordo chi! Non ho i vostri nomi ma forse è meglio così perché li pronuncerei malissimo, quindi trovate i vostri nomi a schermo. Dunque, “anzi” è una delle mie paroline preferite dell’italiano. Voglio partire dall’etimologia, perché “anzi” significa “prima, davanti”. Pensa, per esempio, a “anti”, “ante”, no? Come anticipare (spostare in avanti, no?), antico (qualcosa che è antico è qualcosa che viene prima, no? Che è nato prima), ma anche anziano, o anteriore, no? Anteriore significa che è davanti, che si trova davanti. Davanti o prima. Questa è l’etimologia. Vediamo però come si usa in italiano moderno, con degli esempi:
Guarda che Piero non è in ritardo, anzi, è in anticipo.
Qui serve per correggere quello che dice qualcuno: non è in ritardo, anzi, è in anticipo. Ma c’è una correzione di tipo diverso, per esempio:
È andata bene, anzi, benissimo.
O ancora:
Mi piace molto, anzi, mi piace moltissimo.
Qua è una correzione che, in realtà, non ribalta quello che si è detto, ma aggiunge intensità, enfatizza ancora di più quello che si è detto.
Poi abbiamo questo uso:
Mi sa che mi faccio una pasta stasera. Anzi, magari ordino il sushi.
Ecco, qui è un cambio di idea, stiamo cambiando idea, ragionando ad alta voce, una cosa che spesso succede, e la nuova idea che sostituisce quella precedente viene introdotto da anzi.
Magari registro un video oggi.
Anzi, no, registro quel podcast che devo registrare da tempo!
E poi abbiamo anzitutto, che significa prima di tutto, no? Lo usiamo molto all’inizio di un elenco: anzitutto ti voglio parlare dell’etimologia di “anzi”, poi ti voglio parlare di come si usa.
Abbiamo anche anziché: anziché significa invece che o al posto di.
Poi abbiamo anche poc’anzi (è italiano un po’ formale, un po’ antiquato), ma a me piace molto dire poc’anzi che significa poco fa: poc’anzi ti ho parlato della etimologia di “anzi” (cioè poco fa).
Poi, qualcuno chiedeva di occorre, bisogna, ho bisogno di, mi serve: qual è la differenza tra tutti questi verbi e queste espressioni? Vediamo un po’.
Ci vuole e serve, innanzitutto, sono di registro medio-informale; e che cosa significa? Allora: ci vuole e serve, di fatto, significano è necessario. Per esempio, nella canzone “…ci vuole calma e sangue freddo…”, Luca Dirisio (non so se… cosa faccia, se sia ancora in attività, comunque, una canzone famosa…forse ha vinto un Festival di Sanremo? Non lo so. Chi lo guarda Sanremo!).
Per esempio:
Ci vuole tempo per imparare una lingua.
Ma potrei dire:
Serve tempo per imparare una lingua.
Così come “serve calma e sangue freddo”.
Poi, visto che hai menzionato “mi serve”: beh, serve può essere, in generale, “serve tempo”, ma poi possiamo anche dire a chi serve quella cosa, tempo, energie… quindi l’oggetto indiretto. “Mi serve tempo”: a me, a tuo fratello, a tuo cugino.
Mi serve tempo per imparare l’italiano.
Ma anche ti serve, gli serve, ci serve, le serve… eccetera.
Occorre è più formale.
Occorre calma sangue freddo.
Occorre tempo per imparare una lingua.
È un po’ più formale. Anche se occorre, secondo me, si usa soprattutto con un verbo all’infinito. Ora lo vediamo. Però, attenzione: occorre non si usa come in inglese o come in spagnolo (to occur o occurrir). Non si usa così, quindi in quei casi diremmo “che è successo?”, “che è avvenuto?” ma non diciamo “che è occorso?”, ok? No. Quindi che è avvenuto, che è successo, che è capitato, anche.
Poi, bisogna è un registro medio-informale, ed è seguito da un verbo, per esempio:
Bisogna avere calma e sangue freddo.
Bisogna investire tempo per imparare una lingua.
Ok? Bisogna + verbo, sempre. E anche occorre, come dicevo, solitamente, è seguito da un verbo all’infinito.
Occorre avere calma.
Occorre investire tempo.
Poi abbiamo anche c’è bisogno, che non hai menzionato ma che è molto comune, che è medio-informale; per esempio:
C’è bisogno di calma e di sangue freddo (che, di nuovo, è come come dire serve, è come dire ci vuole, c’è bisogno di tempo per imparare una lingua).
Ma poi abbiamo anche ho bisogno oppure hai bisogno, ha bisogno, avere bisogno. “Ho bisogno”, direi, che è registro medio, non è troppo informale, quindi:
Ho bisogno del tuo aiuto.
Ho bisogno che tu mi aiuti.
Ma potrei dire mi serve il tuo aiuto.
Mi serve che tu mi aiuti.
Spero di averti aiutato. Fammi sapere se ti servono altre spiegazioni.
Oh! Si impersonale e si passivante.
Mi chiedete di fare un po’ di chiarezza in merito.
Partiamo dal si impersonale. Il si impersonale indica un’azione o qualcosa che succede, un processo che avviene, e che non riguarda me, te, Giovanni… ma riguarda tutti. La fanno o succede a tutti, a tante persone, alla gente in generale, ok? Quindi:
Si mangia tardi in Italia.
Ok? Qui stiamo descrivendo un’abitudine italiana. Forse, magari al sud Italia, più che altro. Si mangia tardi al sud Italia: in generale, la gente mangia tardi. Oppure, una domanda comune: si va? Cioè andiamo? Usciamo? Ma può essere usata anche in contesti più formali, per esempio:
Si vuole convincere le persone di qualcosa di falso.
Cioè qualcuno sta facendo questa cosa, questo tentativo, non sappiamo chi.
Nota che in Toscana si usa molto al posto del verbo, dei verbi coniugati alla forma forma del “noi”. No? Spesso anche insieme al “noi”. Quindi, al posto di noi andiamo, si dirà, in Toscana, noi si va. Che è un po’ come il francese, se sai il francese: nous on y va. In effetti, spesso, ricorda anche un noi.
Cioè, se dico oggi si è andati a pescare, di fatto significa noi siamo andati a pescare. Vediamo il si passivante o si passivo, questo passivante… perché i grammatici devono essere così…no? Sempre paroloni complicati…
Ma vediamo prima un esempio di una frase normale con un oggetto diretto:
La gente mangia molta pasta in Italia.
Questa è una frase attiva, non passiva, in cui molta pasta è l’oggetto è diretto.
Ora vediamo una frase con il si passivo, o si passivante.
Si mangia molta pasta in Italia.
Questa è una frase con il si passivo, e molta pasta è il soggetto di questa frase, e vedremo dopo perché il soggetto.
Ma ora vediamo la stessa frase al passivo:
Molta pasta viene mangiata in Italia, o molta pasta è mangiata in Italia.
La frase al passivo è un po’ strana, un po’ troppo formale. Nella conversazione comune si usa molto più di frequente la frase con il si passivo, si mangia molta pasta in Italia.
Facciamo un altro esempio:
Si dicono cose interessanti, in questi incontri.
Se trasformiamo questa frase in una tradizionale frase passiva, abbiamo:
Sono (o vengono) dette cose interessanti in questi incontri.
Vengono dette è molto più naturale, in questo caso.
Nota anche che ho detto “si dicono” cose interessanti: quindi qui abbiamo un verbo plurale che si accorda con il soggetto plurale. Infatti il soggetto si accorda con il verbo. E nella frase passiva succede la stessa cosa:
Sono (o vengono) dette (al plurale) cose interessanti.
Quindi, la frase con il si passivo è essenzialmente equivalente a una frase passiva ma, in alcuni casi, è una struttura un po’ meno formale, perché le frasi passive sono un po’ meno formali in italiano.
Facciamo un ultimo esempio:
In questa città, ultimamente, si sono costruiti molti edifici.
Frase con il passivo.
In questa città ultimamente sono stati costruiti molti edifici.
C’è, poi, anche il si riflessivo, ma non me l’hai chiesto, e quindi non ne parlo.
È il caso, per esempio, di “Luca si lava tutte le mattine”.
Lava se stesso.
Vabbè, ormai ne sto parlando! Vabbè, no, non voglio entrare nel si riflessivo se no il video diventa ancora più lungo.
E se abbiamo un si impersonale o passivo combinato con un si riflessivo, succede questo: ci si alza presto in questa casa. Ci si alza presto. Lo sapevi?
Ultima domanda. torniamo alla fonetica, alla pronuncia.
Come dire la R come gli italiani.
Allora, questo dipende molto dalla tua lingua di partenza. Perché, se parli una lingua in cui hai /r/ o /rr/, non sarà difficile. Se parti da una lingua come l’inglese, il francese o il tedesco, sarà una grande rottura di ca.
Allora, abbiamo due suoni, essenzialmente: il suono monovibrante e polivibrante (cioè, una vibrazione e più vibrazioni; in inglese si chiamano tap o trill).Quindi, il primo è /r/ e il secondo è /R/. Ora, presumo che tu parli inglese, non so perché, ma mettiamo questo caso. E se parli inglese americano, o australiano, la monovibrante, il tap, è il suono che è in parole come “better” (o better in australiano).
È lo stesso suono, essenzialmente, di caro, caro caro. Better, caro.
Con la punta della lingua che tocca gli alveoli, cioè la zona del palato immediatamente dietro i denti. Better.
La polivibrante, cioè il trillo, è più difficile. Mi baso su una spiegazione che ha dato il fonetista Luke Nicholson, e questo è un modo che forse ti può aiutare se non sai fare /rrrr/, che è molto difficile. È un suono difficile e tanti italiani non lo sanno fare. È un difetto di pronuncia, chiamiamolo cosi, molto comune. Ora, forse sai fare questo suono. Brrrr. Brrrr. Questo è il suono che fai quando fa freddo. No? Brrrr. Che freddo! Brrrrr. Se sai fare questo suono, e lo fai, ti accorgi che non stai muovendo tu le labbra, ma è l’aria che fai passare che muove le labbra. Ok? Si muovono da sole le labbra. Questo solo per abituarsi a questa sensazione di aria e di pressione che fa vibrare… fa vibrare, in questo caso, le labbra.
Ora, passiamo in concreto alla /r/.
Parti da ɑːdɑː, ɑːdɑː, ɑːdɑː. Da (quindi il suono della D) e nota il punto dove la punta della lingua tocca il palato, appunto, gli alveoli dietro i denti. D,d,d,d,d.
Ora fai una pausa sulla d. D. A-d. Ok? Magari in realtà sai già pronunciare la R. Sai pronunciare la singola R, beh, quella è la posizione di partenza. Ma se non sai pronunciare neanche la R è utile partire dalla D. Ora, nota che quando dici a- da, i lati della lingua toccano i lati dei denti superiori. D- d- d-.
Fermati proprio su (…): senti la pressione dell’aria che aumenta proprio dietro la punta della lingua? A-… . Ecco, ora, in questa posizione, butta fuori molta aria molto velocemente, ma tenendo i lati della lingua sempre nella stessa posizione, contro i lati dei denti. Se butti aria in maniera molto intensa, qualcosa del genere: (…).
Non è la R, perché per la R devi far vibrare anche le corde vocali, e quindi fare R, R, R.
Esercitati, probabilmente non ci sei riuscito, ma perché è molto difficile. Fai attenzione che la punta della lingua è anche molto rilassata, la tendenza è di tenerla molto tesa. Ricorda che non la devi muovere tu, ma è l’aria che la muove. Rrrrrrrrr. Ok? È l’aria che passa con grande forza e intensità, proprio come nel caso di brrrrrrrrr. Anche qui è l’aria che fa muovere le labbra.
Bene, questo è tutto. Comunque, se vuoi una dimostrazione da una persona più esperta di me, ti lascio un link al blog di Luke Nicholson dove te lo spiega. E se vuoi approfondire la pronuncia italiana, in Fonetica Italiana Semplice ti spiego tutti i suoni dell’italiano, tutti i principali fenomeni fonetici che devi conoscere se vuoi imparare l’italiano e, se t’interessa, anche scoprire come funziona quel modello neutro (o quell’accento neutro) di cui ti parlavo prima in questo video.
Detto questo, ricorda che nel PDF troverai riassunte tutte le informazioni che ho spiegato, spero, in maniera vagamente coerente in questo video, le troverai lì, troverai informazioni aggiuntive. Può scaricare il PDF usando il link in descrizione oppure scansionando questo codice QR.
Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video.




.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
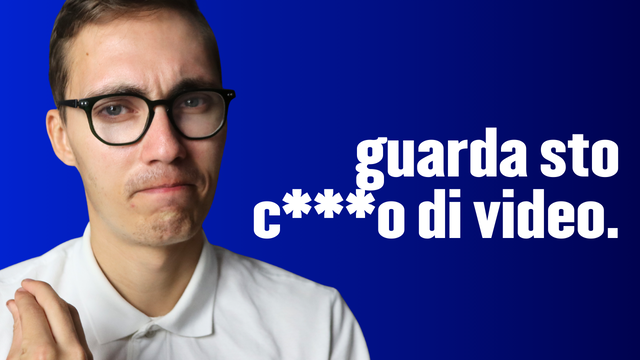
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)






























