Perché Dante è il padre dell'italiano?
Oggi vi voglio parlare di questa persona qui: DanteAlighieri, da molti definito il padre della lingua italiana.
Ma che significa esattamente essere “padre” di una lingua? E poi: Dante si merita davvero questo titolo? Benvenuti su Podcast Italiano, il canale YouTube e podcast per imparare l’italiano se siete stranieri o per ascoltare informazioni, spero, interessanti sul nostro idioma, se fate parte di quel 20% di italiani che mi guarda.
Se stai imparando l’italiano attraverso i miei video puoi accedere al PDF con la trascrizione integrale di questo video e il lessico difficile tradotto in inglese e spiegato in italiano iscrivendoti al mio Podcast Italiano Club; così facendo supporterai il mio progetto e anche il tuo italiano.
Trascrizione PDF con glossario audio isolato (PI Club)
Trovi il link qui.
Nell’anno che è appena incominciato si celebreranno in Italia e nel mondo i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021).
Per questo motivo anche io ho deciso qui su Podcast Italiano di parlare un po’ di Dante e di approfondire la mia conoscenza personale sul “sommo poeta”, come viene chiamato.
Faccio subito un’avvertenza: non sono un dantista, non so niente di letteratura, non sono un esperto, non sono nessuno.
Semplicemente sono una persona che ama la lingua italiana, che da qualche mese si sta appassionando a Dante e che vuole condividere con voi ciò che sta imparando in un anno così simbolico.
Dante è una figura dall’importanza unica nella cultura italiana: pensate, è l’unico individuo a cui viene attribuito l’epiteto di “padre”; nemmeno personaggi fondamentali nella storia italiana come Cavour o Garibaldi vengono singolarmente chiamati “padri”.
Dante invece sì: se non “Padre dell’Italia” per lo meno “Padre dell’italiano”.
Non so quanto voi sappiate o non sappiate su Dante, quindi voglio iniziare facendo un passo indietro e parlando in breve della sua vita.
01:57 - La vita di Dante Alighieri, in breve Durante degli Alighieri, detto Dante nasce nel 1265 a Firenze, una città che in quegli anni era in pieno boom economico e demografico.
A Firenze si fanno grossi affari, girano un sacco di soldi, si costruiscono edifici impressionanti (questi due, che forse conoscete, furono iniziati nel 1296 e nel 1299) e c’è una fortissima mobilità sociale: in poco tempo un contadino venuto dalla campagna può arricchirsi e fare una fortuna.
Gli Alighieri non sono una famiglia nobile (nel senso che non vantano antenati famosi), ma sono comunque abbastanza rispettabili da avere un cognome (un privilegio per pochi a quel tempo).
Anche loro hanno fatto i soldi.
Dante non è ricco sfondato ma è sicuramente benestante: suo nonno, suo padre e i suoi zii avevano guadagnato trafficando denaro, in un’economia cittadina in cui i soldi servivano come il pane.
Questi soldi poi li hanno investiti, permettendo a Dante di “vivere di rendita”, cioè non dover lavorare per guadagnarsi da vivere.
Dante si può quindi dedicare agli studi, all’attività letteraria, all’attività politica e addirittura militare.
Sì, perché Dante partecipa ad alcune battaglie, come all’importante battaglia di Campaldino del1289, in cui la sua fazione politica (o “partito”, diremmo oggi), i Guelfi, infligge una pesante sconfitta a quella nemica, i Ghibellini.
Non sapete di che sto parlando? Beh, dovete sapere che nelle città medievali italiane esistevano due fazioni politiche estremamente ostili l’una all’altra: i Guelfi, che come si dice tradizionalmente, erano a favore del Papa, e i Ghibellini che erano più dalla parte dell’imperatore ( stiamo parlando del Sacro Romano Impero); a dirla verità la divisione politica non era tanto e solo una questione ideologica, bensì, come sempre, di interessi economici e personali.
Ma comunque, a noi interessa capire che la Firenze a cavallo del ‘200 e del ‘300 non è una città affatto tranquilla.
La violenza, l’odio, la vendetta, la corruzione sono comunissime e Dante lo prova sulla sua pelle.
Tra gli anni ’90 del‘200 e il 1302 Dante ricopre infatti varie cariche politiche all’interno del “governo di popolo” fiorentino (un esperimento di democrazia molto avanzato per l’epoca), diventando persino uno dei sei Priori (la massima carica del governo) e venendo inviato in missione a Roma dal Papa come ambasciatore di Firenze.
I Ghibellini erano già stati cacciati nel 1267, ma poi gli stessi Guelfi si frammentano in due ulteriori fazioni: Guelfi Neri e Guelfi Bianchi.
Dante è un bianco, ma a Firenze prendono il potere i neri, anche grazie all’appoggio del papa, da cui Dante era stato mandato.
Nel 1302 Dante paga a caro prezzo la sua scelta politica venendo esiliato, cacciato dalla sua città, con queste accuse: «Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si prende, al rogo, così che muoia”» (Libro del chiodo - Archivio di Stato di Firenze - 10 marzo1302[66]) Dante, che era proprio in quel momento dal Papa, non tornerà mai più a Firenze e non potrà nemmeno salutare la sua amata città un’ultima volta.
Inizia così il suo lungo esilio, che per Dante è un fatto traumatico ma centrale nella sua vita.
L’esilio lo porta a girovagare per il centro-nord italiano, di corte in corte, venendo ospitato da vari signori locali.
È proprio in questi anni (si pensa dal 1306 al 1321) che Dante scrive il suo capolavoro, la Commedia.
Dante muore nel 1321 a Ravenna, dove ancora oggi è sepolto.
Parliamo ora della sua importanza letteraria.
Dante è indubbiamente il più importante scrittore nella storia della letteratura italiana.
Vediamo perché.
Dante ha scritto tante opere, alcune delle quali in latino.
Sì, perché all’epoca chi studiava doveva per forza sapere il latino (che era lingua dell’élite intellettuale in tutta Europa).
Dante, tuttavia, fa qualcosa di molto importante: scrive anche in volgare fiorentino (oggi diremmo “dialetto”), che è la lingua della sua città e la sua lingua madre.
Non solo: non accetta l’idea diffusa tra gli intellettuali che il latino fosse sempre superiore al volgare, ma rivendica l’importanza e l’utilità del volgare per educare quelle persone non colte, che non sapevano il latino, che però avevano fame* di conoscenza.
Scrive un intero trattato in latino, chiamato “De Vulgari Eloquentia” dove difende l’eloquenza del volgare.
Dante, come dice lui stesso in un altro trattato, in volgare, il Convivio, amava la sua lingua: «[…]per che si conchiude che non solamente amore, ma perfettissimo amore sia quello ch’io a lui debbo avere e ho.
” » Dante ha un perfetto amore nei confronti del volgare.
Ma Dante va oltre e fa una predizione: «Questo (il volgare) sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale(=il quale) surgerà là dove l’usato (ovvero il consueto latino) tramonterà, e darà lume a coloro che sono in tenebre ed in oscurita de, per lo usato sole che a loro non luce» Dante si riferisce alle persone che non sanno il latino, per cui imparare il volgare (o meglio: imparare a leggere) è un modo di uscire dalle tenebre.
Dante è stato profetico: oggi la lingua che si parla e si scrive in tutta Italia è l’italiano, non il latino.
In volgare Dante scrive tante opere, sia in poesia che in prosa, ma oggi mi concentrerò solamente dell’opera per cui ancora oggi parliamo di lui 700 anni dopo la sua morte: la Commedia , comunemente nota come “Divina Commedia”.
Se Dante è il più importante scrittore della letteratura italiana, la Commedia è la più importante opera della letteratura italiana e una delle più importanti al mondo.
Ma che cos’è la Commedia? La Commedia è un poema (ah, una parentesi lessicale per gli amici anglofoni: “poema” in italiano significa opera in versi, ma lunga, al contrario di una “poesia” che è breve; in inglese si usa sempre il più generico “poem”).
Ma quanto lunga?Tanto, tantissimo: la Commedia è un’opera mastodontica, composta di 14.233 endecasillabi.
Un “endecasillabo” è un verso di 11 sillabe.
Per capire meglio vediamo l’inizio dell’opera: Nel mez-zo del cam-min di nos-tra vi-ta Miri-tro-vai per u-na sel-va_os-cu-ra Ché la di-rit-ta vi-a_e-ra smar-ri-ta Siamo di fronte a una terzina, una strofa composta di tre versi di undici sillabe.
La Commedia altro non è che è una lunghissima successione di terzine come questa.
Guardiamo ora le rime: “Vita”, “oscura”, “smarrita”; nella seconda “dura”, “forte”, “paura”; “morte”, “trovai”, “scorte”; intrai”, “punto”, “abbandonai”.
Lo schema che si delinea è questo: A, B, A; B, C, B; C, D C; D, E, D, e così via per tutti i 14.233 versi della Commedia (io la trovo una cosa fuori di testa, incredibile); questo schema l’ha inventato Dante, e per questo si chiama “terzina dantesca”, o anche “terza rima”, o ancora “terzina incatenata” (perché è come una catena).
L’opera si articola su 100 canti (potremmo chiamarli “capitoli”) suddivisi in tre cantiche, ovvero tre libri: Inferno (con 34 canti), Purgatorio (con 33) e Paradiso (con 33).
I numeri non sono scelti a caso: Dante amava la numerologia e in tutta la Commedia il numero tre, che rappresenta la trinità, ritorna molte volte.
L’Inferno ha 34 canti perché il primo è un introduzione.
E di che parla l’opera? Partiamo dal primo Canto, che racconta di un uomo (che è il poeta stesso, anche se non lo sappiamo fin dall’inizio) che si perde in una selva oscura, ovvero in un bosco (che è un simbolo del peccato); l’uomo arriva a un colle illuminato dai raggi del sole (simbolo della salvezza), inizia a scalarlo ma incontra tre bestie che gli ostacolano la salita: una lonza (che sarebbe forse una lince, o comunque un felino), un leone e una lupa.
Come la selva, anche le tre bestie (o “fiere”) sono dei simboli, o più precisamente “allegorie”, dei tre peccati fondamentali secondo la Bibbia: la lussuria, la superbia e l’avidità.
Dante non riesce quindi a scalare il colle e deve scendere nella selva (ovvero tornare nelle tenebre del peccato, è tutto un simbolo), dove incontra l’ombra del poeta latino Virgilio, simbolo della ragione umana, che lo guiderà in un viaggio nel regno dei morti: lo accompagnerà all’Inferno, e al Purgatorio ma dovrà congedarsi prima di entrare in Paradiso, dove Dante verrà accompagnato da Beatrice e infine da San Bernardo.
Chi è Beatrice? Beatrice è la donna amata da Dante (una donna realmente esistita, a cui ha dedicato un intero libro di poesie, la Vita Nuova) e che qui rappresenta molto più di una donna amata, addirittura la via della salvezza attraverso la fede cristiana.
Dante qualche anno prima aveva promesso: «se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono (cioè, “se dio lo vorrà”), che la mia vita duri per alquanti anni (cioè “che non muoio dopodomani”), io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna.
» Dante dirà di Beatrice ciò che non è mai stato detto di nessuna donna.
Ed è proprio quello che ha fatto: ha elevato una donna (a cui probabilmente non ha mai parlato invita sua) a simbolo di salvezza dell’anima.
Ma Dante stesso è un simbolo, simbolo dell’umanità che ha perso la strada, la “retta via”.
La Commedia come avete capito è intrisa di simbologia e allegorie, che per un uomo della nostra epoca non sono così facili da cogliere.
Tuttavia ciò non vuol dire che non possiamo leggere la Commedia alla lettera e godercela come una storia interessante e avvincente, anche se non cogliamo tutti i suoi significati nascosti, così come tutti i suoi infiniti rimandi culturali, letterari, politici, filosofici, storici, teologici, e chi più ne ha più ne metta.
Per questi continui riferimenti al suo mondo la Commedia è stata definita un’enciclopedia del sapere medievale, perché è una vera finestra sulla cultura di quel mondo medievale a cui Dante apparteneva in pieno, anche sulla mentalità di quell’epoca, sulle credenze scientifiche, geografiche, religiose, astronomiche, medicinali e molto altro ancora.
Leggendo la Commedia si può di fatto studiare il medioevo.
Ma non è solo sfoggio di sapienza: la Commedia è anche molto umana.
Nel suo viaggio Dante incontra e dialoga con tante “superstar” del suo tempo, che magari oggi non ci dicono nulla, ma che per i suoi contemporanei erano delle celebrità: re, politici, papi, figure religiose, intellettuali; ma anche personaggi di epoche precedenti alla sua, come lo stesso Virgilio, Maometto e Giustiniano; ci sono poi mostri mitologici come Minosse, il minotauro e lo stesso Lucifero; personaggi biblici come Maria, San Pietro, l’arcangelo Gabriele e, alla fine dell’opera, Dio stesso, che Dante arriva a contemplare per un istante.
La fama della Commedia è antica: l’opera circolava già quando Dante era ancora in vita, in un epoca in cui la stampa non esisteva e per avere una copia di un libro qualcuno doveva averlo… copiato, appunto.
Ma dopo la morte del poeta la fama della Commedia esplode.
Tutti la commentano, tutti la interpretano, tutti conoscono almeno qualche verso: persino i mercanti, persone non particolarmente colte, conoscono qualche passo dell’opera.
La Commedia ha avuto un’enorme influenza sulla poesia e letteratura italiana, in alcuni periodi è stata più apprezzata che in altri, ma si tratta di un’opera con cui chiunque abbia scritto in italiano si è confrontato: o per imitarla, o per prenderne le distanze.
15:00 - Perché Dante viene chiamato “padre dell’italiano”? Ma allora torniamo alla domanda con cui ho iniziato questo video.
Perché Dante vienechiamato “padre dell’italiano”? Che significa? Quando ero piccolo e sentivo dire che “Dante ha in ventato l’italiano” ero un po’ confuso.
Cioè, pensavo che Dante avesse proprio inventato da zero l’italiano, che si fosse seduto a un tavolo e avesse scritto la grammatica e il lessico; un po’ come Zamenhof ha inventato l’esperanto o Tolkien le lingue del suo universo fantastico.
Non è chiaramente così: Dante ha adoperato come base la lingua di Firenze, ormai l’abbiamo capito.
Anzi, secondo gli studiosi la Commedia è la sua opera più fiorentina di tutte a livello linguistico.
Allora Dante magari è il primo che scrive in volgare? No, per niente.
Molti prima di lui in varie zone d’Italia avevano già scritto nei vari volgari italiani: un esempio celebre è la scuola siciliana, che ispirandosi alla poesia provenzale (quindi della Provenza, in Francia) costituisce il primo vero movimento letterario italiano, che poi ha ispirato altri poeti toscani, che scrivevano in fiorentino ancora prima di Dante.
Ma allora, se Dante non è il primo a scrivere in una lingua italo-romanza e nemmeno il primo ascrivere in fiorentino, perché mai dovremmo considerarlo “il padre dell’italiano”? Non dobbiamo guardare al “quando”, ma al “come” Dante scrive.
Perché la portata, l’ampiezza, la vastità della sua opera e del suo linguaggio non hanno eguali, né prima, né dopo di lui.
Abbiamo già visto che la Commedia è un’enciclopedia della sapienza medievale.
Bene, per parlare di qualsiasi cosa (e Dante ha davvero parlato di tutto) devi saper modellare la lingua in base alle tue esigenze, usare tutti i registri, gli stili e lepossibilità che essa, la lingua, ti offre.
Non puoi parlare diLucifero con la stessa lingua che usi per descrivere la visione della trinità.
Può aiutarvi a capireciò che intendo analizzare un po’ il lessico dell’opera.
Nell’Inferno, per esempio, troviamo una lingua spesso bassa, aspra a volte addirittura comica, le cui parole Dante trae, prende dal fiorentino popolare; (si incontrano parole come “culo”, “merda”, “puttana”, o un verso comico famosissimo come “Ed elli avea del cul fatto trombetta”, cioè “aveva usato il culo come una tromba”; Dante sta descrivendo un diavolo che per dare agli altri diavoli il comando dimettersi in marcia come in battaglia scorreggia, paragonando quindi la scorreggia al suono di una tromba militare.
All’estremo opposto abbiamo la lingua del Paradiso: elegante, solenne, colta, piena di latinismi (come “misericordia”, “grazia”, “magnificenza”, “benignità” e tanti altri).
La base della sua lingua è il fiorentino: del fiorentino Dante usa parole del suo tempo e parole arcaiche già a suo tempo, che i suoi contemporanei già non usavano più.
Dante attinge molto poi anche da altre lingue, tra cui il francese (per parole come “approcciare” e “sovente”) e, soprattutto, il provenzale (per esempio “noia” e “speranza”).
Oltre alle lingue straniere Dante fa sue parole e forme grammaticali che trova in altri dialetti toscani e a volte altri dialetti italiani.
Dante ad opera poi termini dell’astronomia (come “zenit”, “galassia”, “empireo”), della medicina(“coagulare” “febbre acuta”) e della musica (arpa e leuto, ovvero “liuto”).
E quando non trovauna parola se la inventa di sana pianta; i suoi neologismi sono chiamati“dantismi” e ce ne sono tanti.
Dante si inventa parole come, per esempio, “infuturarsi” (ovvero “prolungarsi nel futuro”)“trasumanare” (andare al di là dei limiti della natura umana), “inurbarsi”(entrare in città), “inluiarsi” (“diventare lui”).
Molti di questi dantismi a dire il vero non si usano più, ma non si può dire che Dante non fosse creativo e non amasse sperimentare e giocare con la lingua.
Ciò che invece usiamo ancora sono espressioni idiomatiche inventate da Dante ed entrate nel linguaggio comune, come “senza infamia e senza lode”, “non ragioniam* di lor, ma guarda e passa”, “lasciate ogni speranza voi ch’entrate” .
Ma vediamo qualche dato che ci aiuta a capire l’impatto della Commedia sul lessico dell’italiano.
Secondo uno studio del linguista Tullio de Mauro nella letteratura che precede Dante era già attestato il 62% delle 2000 parole più comuni nell’italiano, che compongono quindi il cosiddetto “lessico fondamentale”.
Alla fine del ‘300questa percentuale sale all’84%: ciò è sicuramente dovuto al contributo di Dante, almeno in buona parte.
Oltre a ciò, le parole che già esistevano e che Dante ha usato personalmente sono generalmente sopravvissute di più rispetto a quelle che non ha accolto (precisamente 2 volte e mezza di più).
Potremmo rispondere alla domanda però da un altro punto di vista: se la lingua italiana si basa ancora oggi sulla lingua fiorentina del ‘300 il merito è in gran parte di Dante, ma anche Petrarca e Boccaccio.
Se non fosse stato per loro oggi forse non parleremmo una lingua basata sul fiorentino, ma magari una lingua basata sul bolognese, sul siciliano, sul veneto, sul bergamasco.
O magari non avremmouna lingua nazionale.
Chi può dirlo? Ciò che è sicuro è che prima di Dante il fiorentino era UNA lingua italiana, ma già due secoli dopo di lui è diventato LA lingua italiana.
E Dante di questo è responsabile.
C’è chi dice che è la lingua della letteratura ad aver creato l’Italia e c’è chi addirittura definisce Dante padre dell’Italia (non tutti sono d’accordo con questa definizione).
Io non mi sento abbastanza competente per esprimere la mia opinione su questo, ma una cosa è innegabile: l’Italia ha raggiunto un’unità culturale e letteraria molto prima dell’unità politica.
La letteratura, e non l’esercito (come in altri stati europei) ha dato prestigio all’italiano.
L’italiano non è mai stato imposto con i fucili e le spade ma si è imposto con la bellezza della sua letteratura.
A Dante va riconosciuto il merito di aver fatto una scommessa.
Ha creduto seriamente nel volgare e non l’ha ritenuto inferiore al latino; ne ha mostrato tutte le potenzialità espressive; l’ha impiegato per scrivere l’opera più importante della sua vita, facendo una scelta molto rivoluzionaria e anche molto rischiosa: scrivere un poema in volgare (molti lo criticarono per aver usato il fiorentino e non il latino).
La storia gli ha dato ragione, perché ancora oggi, in un mondo sicuramente diverso da quello di 700anni fa, usiamo ancora le parole che Dante ha reso immortali.
Per questo l’epiteto di padre è adeguato: Dante si merita davvero il titolo di padre dell’italiano.
21:57 - Dovresti leggere la Commedia? Ora potreste chiedervi se ha senso leggere la Commedia nel2021.
Se siete italiani la risposta è facile: sì.
Dante fa parte del nostro sapere comune e della nostra identità, quindi conoscerlo non fa male.
Io stesso sto leggendo integralmente la Commedia per la prima volta (perché a scuola leggiamo e studiamo una selezione di canti) e la trovo davvero divertente, istruttiva e a volte illuminante.
E se siete stranieri? Ni.
O meglio, dipende dai vostri interessi e obiettivi.
Chiaramente leggere un’opera di 700 anni fa non è una grande idea per imparare l’italiano del 2021;tuttavia penso che, essendo quell’italiano relativamente simile al nostro, se avete un livello intermedio-avanzato e vi interessa la letteratura e Dante, possa aver senso avvicinarsi alla Commedia, magari con una guida che vi aiuti a farlo, il vostro Virgilio personale.
È per questo che sto leggendo la Commedia per voi sul mio Club su Patreon, dove potete in primo luogo sostenere questo progetto, se vi piace e vi aiuta; in secondo luogo ottenere tantissimi contenuti esclusivi tra cui, appunto, una serie di dirette che io ed Erika stiamo facendo in cui spieghiamo e leggiamo alcuni Canti della Commedia.
Finora ne abbiamo letti tre e ci stiamo divertendo molto: la reazione del membri Club è stata finora molto positiva, devo dire, e per questo l’intenzione è di continuare per tutto il 2021 e celebrare così il Sommo Poeta.
Quindi se hai pensato di iscriverti al Club e dopo questo video ti è venuta voglia di leggere Dante…questo è il momento per fare l’una e l’altra cosa.
Ah, per poter vederele dirette su Dante il prezzo che ti chiedo è simbolico, $1 al mese.
Quindi ci sta, dai.
Se sei interessato segui questo link.
Io ringrazio i membri del Club che vedete scorrere per il sostegno a questo progetto.
E noi ci vediamo presto, ciao!
Oggi vi voglio parlare di questa persona qui: DanteAlighieri, da molti definito il padre della lingua italiana.
Ma che significa esattamente essere “padre” di una lingua? E poi: Dante si merita davvero questo titolo? Benvenuti su Podcast Italiano, il canale YouTube e podcast per imparare l’italiano se siete stranieri o per ascoltare informazioni, spero, interessanti sul nostro idioma, se fate parte di quel 20% di italiani che mi guarda.
Se stai imparando l’italiano attraverso i miei video puoi accedere al PDF con la trascrizione integrale di questo video e il lessico difficile tradotto in inglese e spiegato in italiano iscrivendoti al mio Podcast Italiano Club; così facendo supporterai il mio progetto e anche il tuo italiano.
Trascrizione PDF con glossario audio isolato (PI Club)
Trovi il link qui.
Nell’anno che è appena incominciato si celebreranno in Italia e nel mondo i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021).
Per questo motivo anche io ho deciso qui su Podcast Italiano di parlare un po’ di Dante e di approfondire la mia conoscenza personale sul “sommo poeta”, come viene chiamato.
Faccio subito un’avvertenza: non sono un dantista, non so niente di letteratura, non sono un esperto, non sono nessuno.
Semplicemente sono una persona che ama la lingua italiana, che da qualche mese si sta appassionando a Dante e che vuole condividere con voi ciò che sta imparando in un anno così simbolico.
Dante è una figura dall’importanza unica nella cultura italiana: pensate, è l’unico individuo a cui viene attribuito l’epiteto di “padre”; nemmeno personaggi fondamentali nella storia italiana come Cavour o Garibaldi vengono singolarmente chiamati “padri”.
Dante invece sì: se non “Padre dell’Italia” per lo meno “Padre dell’italiano”.
Non so quanto voi sappiate o non sappiate su Dante, quindi voglio iniziare facendo un passo indietro e parlando in breve della sua vita.
01:57 - La vita di Dante Alighieri, in breve Durante degli Alighieri, detto Dante nasce nel 1265 a Firenze, una città che in quegli anni era in pieno boom economico e demografico.
A Firenze si fanno grossi affari, girano un sacco di soldi, si costruiscono edifici impressionanti (questi due, che forse conoscete, furono iniziati nel 1296 e nel 1299) e c’è una fortissima mobilità sociale: in poco tempo un contadino venuto dalla campagna può arricchirsi e fare una fortuna.
Gli Alighieri non sono una famiglia nobile (nel senso che non vantano antenati famosi), ma sono comunque abbastanza rispettabili da avere un cognome (un privilegio per pochi a quel tempo).
Anche loro hanno fatto i soldi.
Dante non è ricco sfondato ma è sicuramente benestante: suo nonno, suo padre e i suoi zii avevano guadagnato trafficando denaro, in un’economia cittadina in cui i soldi servivano come il pane.
Questi soldi poi li hanno investiti, permettendo a Dante di “vivere di rendita”, cioè non dover lavorare per guadagnarsi da vivere.
Dante si può quindi dedicare agli studi, all’attività letteraria, all’attività politica e addirittura militare.
Sì, perché Dante partecipa ad alcune battaglie, come all’importante battaglia di Campaldino del1289, in cui la sua fazione politica (o “partito”, diremmo oggi), i Guelfi, infligge una pesante sconfitta a quella nemica, i Ghibellini.
Non sapete di che sto parlando? Beh, dovete sapere che nelle città medievali italiane esistevano due fazioni politiche estremamente ostili l’una all’altra: i Guelfi, che come si dice tradizionalmente, erano a favore del Papa, e i Ghibellini che erano più dalla parte dell’imperatore ( stiamo parlando del Sacro Romano Impero); a dirla verità la divisione politica non era tanto e solo una questione ideologica, bensì, come sempre, di interessi economici e personali.
Ma comunque, a noi interessa capire che la Firenze a cavallo del ‘200 e del ‘300 non è una città affatto tranquilla.
La violenza, l’odio, la vendetta, la corruzione sono comunissime e Dante lo prova sulla sua pelle.
Tra gli anni ’90 del‘200 e il 1302 Dante ricopre infatti varie cariche politiche all’interno del “governo di popolo” fiorentino (un esperimento di democrazia molto avanzato per l’epoca), diventando persino uno dei sei Priori (la massima carica del governo) e venendo inviato in missione a Roma dal Papa come ambasciatore di Firenze.
I Ghibellini erano già stati cacciati nel 1267, ma poi gli stessi Guelfi si frammentano in due ulteriori fazioni: Guelfi Neri e Guelfi Bianchi.
Dante è un bianco, ma a Firenze prendono il potere i neri, anche grazie all’appoggio del papa, da cui Dante era stato mandato.
Nel 1302 Dante paga a caro prezzo la sua scelta politica venendo esiliato, cacciato dalla sua città, con queste accuse: «Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si prende, al rogo, così che muoia”» (Libro del chiodo - Archivio di Stato di Firenze - 10 marzo1302[66]) Dante, che era proprio in quel momento dal Papa, non tornerà mai più a Firenze e non potrà nemmeno salutare la sua amata città un’ultima volta.
Inizia così il suo lungo esilio, che per Dante è un fatto traumatico ma centrale nella sua vita.
L’esilio lo porta a girovagare per il centro-nord italiano, di corte in corte, venendo ospitato da vari signori locali.
È proprio in questi anni (si pensa dal 1306 al 1321) che Dante scrive il suo capolavoro, la Commedia.
Dante muore nel 1321 a Ravenna, dove ancora oggi è sepolto.
Parliamo ora della sua importanza letteraria.
Dante è indubbiamente il più importante scrittore nella storia della letteratura italiana.
Vediamo perché.
Dante ha scritto tante opere, alcune delle quali in latino.
Sì, perché all’epoca chi studiava doveva per forza sapere il latino (che era lingua dell’élite intellettuale in tutta Europa).
Dante, tuttavia, fa qualcosa di molto importante: scrive anche in volgare fiorentino (oggi diremmo “dialetto”), che è la lingua della sua città e la sua lingua madre.
Non solo: non accetta l’idea diffusa tra gli intellettuali che il latino fosse sempre superiore al volgare, ma rivendica l’importanza e l’utilità del volgare per educare quelle persone non colte, che non sapevano il latino, che però avevano fame* di conoscenza.
Scrive un intero trattato in latino, chiamato “De Vulgari Eloquentia” dove difende l’eloquenza del volgare.
Dante, come dice lui stesso in un altro trattato, in volgare, il Convivio, amava la sua lingua: «[…]per che si conchiude che non solamente amore, ma perfettissimo amore sia quello ch’io a lui debbo avere e ho.
” » Dante ha un perfetto amore nei confronti del volgare.
Ma Dante va oltre e fa una predizione: «Questo (il volgare) sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale(=il quale) surgerà là dove l’usato (ovvero il consueto latino) tramonterà, e darà lume a coloro che sono in tenebre ed in oscurita de, per lo usato sole che a loro non luce» Dante si riferisce alle persone che non sanno il latino, per cui imparare il volgare (o meglio: imparare a leggere) è un modo di uscire dalle tenebre.
Dante è stato profetico: oggi la lingua che si parla e si scrive in tutta Italia è l’italiano, non il latino.
In volgare Dante scrive tante opere, sia in poesia che in prosa, ma oggi mi concentrerò solamente dell’opera per cui ancora oggi parliamo di lui 700 anni dopo la sua morte: la Commedia , comunemente nota come “Divina Commedia”.
Se Dante è il più importante scrittore della letteratura italiana, la Commedia è la più importante opera della letteratura italiana e una delle più importanti al mondo.
Ma che cos’è la Commedia? La Commedia è un poema (ah, una parentesi lessicale per gli amici anglofoni: “poema” in italiano significa opera in versi, ma lunga, al contrario di una “poesia” che è breve; in inglese si usa sempre il più generico “poem”).
Ma quanto lunga?Tanto, tantissimo: la Commedia è un’opera mastodontica, composta di 14.233 endecasillabi.
Un “endecasillabo” è un verso di 11 sillabe.
Per capire meglio vediamo l’inizio dell’opera: Nel mez-zo del cam-min di nos-tra vi-ta Miri-tro-vai per u-na sel-va_os-cu-ra Ché la di-rit-ta vi-a_e-ra smar-ri-ta Siamo di fronte a una terzina, una strofa composta di tre versi di undici sillabe.
La Commedia altro non è che è una lunghissima successione di terzine come questa.
Guardiamo ora le rime: “Vita”, “oscura”, “smarrita”; nella seconda “dura”, “forte”, “paura”; “morte”, “trovai”, “scorte”; intrai”, “punto”, “abbandonai”.
Lo schema che si delinea è questo: A, B, A; B, C, B; C, D C; D, E, D, e così via per tutti i 14.233 versi della Commedia (io la trovo una cosa fuori di testa, incredibile); questo schema l’ha inventato Dante, e per questo si chiama “terzina dantesca”, o anche “terza rima”, o ancora “terzina incatenata” (perché è come una catena).
L’opera si articola su 100 canti (potremmo chiamarli “capitoli”) suddivisi in tre cantiche, ovvero tre libri: Inferno (con 34 canti), Purgatorio (con 33) e Paradiso (con 33).
I numeri non sono scelti a caso: Dante amava la numerologia e in tutta la Commedia il numero tre, che rappresenta la trinità, ritorna molte volte.
L’Inferno ha 34 canti perché il primo è un introduzione.
E di che parla l’opera? Partiamo dal primo Canto, che racconta di un uomo (che è il poeta stesso, anche se non lo sappiamo fin dall’inizio) che si perde in una selva oscura, ovvero in un bosco (che è un simbolo del peccato); l’uomo arriva a un colle illuminato dai raggi del sole (simbolo della salvezza), inizia a scalarlo ma incontra tre bestie che gli ostacolano la salita: una lonza (che sarebbe forse una lince, o comunque un felino), un leone e una lupa.
Come la selva, anche le tre bestie (o “fiere”) sono dei simboli, o più precisamente “allegorie”, dei tre peccati fondamentali secondo la Bibbia: la lussuria, la superbia e l’avidità.
Dante non riesce quindi a scalare il colle e deve scendere nella selva (ovvero tornare nelle tenebre del peccato, è tutto un simbolo), dove incontra l’ombra del poeta latino Virgilio, simbolo della ragione umana, che lo guiderà in un viaggio nel regno dei morti: lo accompagnerà all’Inferno, e al Purgatorio ma dovrà congedarsi prima di entrare in Paradiso, dove Dante verrà accompagnato da Beatrice e infine da San Bernardo.
Chi è Beatrice? Beatrice è la donna amata da Dante (una donna realmente esistita, a cui ha dedicato un intero libro di poesie, la Vita Nuova) e che qui rappresenta molto più di una donna amata, addirittura la via della salvezza attraverso la fede cristiana.
Dante qualche anno prima aveva promesso: «se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono (cioè, “se dio lo vorrà”), che la mia vita duri per alquanti anni (cioè “che non muoio dopodomani”), io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna.
» Dante dirà di Beatrice ciò che non è mai stato detto di nessuna donna.
Ed è proprio quello che ha fatto: ha elevato una donna (a cui probabilmente non ha mai parlato invita sua) a simbolo di salvezza dell’anima.
Ma Dante stesso è un simbolo, simbolo dell’umanità che ha perso la strada, la “retta via”.
La Commedia come avete capito è intrisa di simbologia e allegorie, che per un uomo della nostra epoca non sono così facili da cogliere.
Tuttavia ciò non vuol dire che non possiamo leggere la Commedia alla lettera e godercela come una storia interessante e avvincente, anche se non cogliamo tutti i suoi significati nascosti, così come tutti i suoi infiniti rimandi culturali, letterari, politici, filosofici, storici, teologici, e chi più ne ha più ne metta.
Per questi continui riferimenti al suo mondo la Commedia è stata definita un’enciclopedia del sapere medievale, perché è una vera finestra sulla cultura di quel mondo medievale a cui Dante apparteneva in pieno, anche sulla mentalità di quell’epoca, sulle credenze scientifiche, geografiche, religiose, astronomiche, medicinali e molto altro ancora.
Leggendo la Commedia si può di fatto studiare il medioevo.
Ma non è solo sfoggio di sapienza: la Commedia è anche molto umana.
Nel suo viaggio Dante incontra e dialoga con tante “superstar” del suo tempo, che magari oggi non ci dicono nulla, ma che per i suoi contemporanei erano delle celebrità: re, politici, papi, figure religiose, intellettuali; ma anche personaggi di epoche precedenti alla sua, come lo stesso Virgilio, Maometto e Giustiniano; ci sono poi mostri mitologici come Minosse, il minotauro e lo stesso Lucifero; personaggi biblici come Maria, San Pietro, l’arcangelo Gabriele e, alla fine dell’opera, Dio stesso, che Dante arriva a contemplare per un istante.
La fama della Commedia è antica: l’opera circolava già quando Dante era ancora in vita, in un epoca in cui la stampa non esisteva e per avere una copia di un libro qualcuno doveva averlo… copiato, appunto.
Ma dopo la morte del poeta la fama della Commedia esplode.
Tutti la commentano, tutti la interpretano, tutti conoscono almeno qualche verso: persino i mercanti, persone non particolarmente colte, conoscono qualche passo dell’opera.
La Commedia ha avuto un’enorme influenza sulla poesia e letteratura italiana, in alcuni periodi è stata più apprezzata che in altri, ma si tratta di un’opera con cui chiunque abbia scritto in italiano si è confrontato: o per imitarla, o per prenderne le distanze.
15:00 - Perché Dante viene chiamato “padre dell’italiano”? Ma allora torniamo alla domanda con cui ho iniziato questo video.
Perché Dante vienechiamato “padre dell’italiano”? Che significa? Quando ero piccolo e sentivo dire che “Dante ha in ventato l’italiano” ero un po’ confuso.
Cioè, pensavo che Dante avesse proprio inventato da zero l’italiano, che si fosse seduto a un tavolo e avesse scritto la grammatica e il lessico; un po’ come Zamenhof ha inventato l’esperanto o Tolkien le lingue del suo universo fantastico.
Non è chiaramente così: Dante ha adoperato come base la lingua di Firenze, ormai l’abbiamo capito.
Anzi, secondo gli studiosi la Commedia è la sua opera più fiorentina di tutte a livello linguistico.
Allora Dante magari è il primo che scrive in volgare? No, per niente.
Molti prima di lui in varie zone d’Italia avevano già scritto nei vari volgari italiani: un esempio celebre è la scuola siciliana, che ispirandosi alla poesia provenzale (quindi della Provenza, in Francia) costituisce il primo vero movimento letterario italiano, che poi ha ispirato altri poeti toscani, che scrivevano in fiorentino ancora prima di Dante.
Ma allora, se Dante non è il primo a scrivere in una lingua italo-romanza e nemmeno il primo ascrivere in fiorentino, perché mai dovremmo considerarlo “il padre dell’italiano”? Non dobbiamo guardare al “quando”, ma al “come” Dante scrive.
Perché la portata, l’ampiezza, la vastità della sua opera e del suo linguaggio non hanno eguali, né prima, né dopo di lui.
Abbiamo già visto che la Commedia è un’enciclopedia della sapienza medievale.
Bene, per parlare di qualsiasi cosa (e Dante ha davvero parlato di tutto) devi saper modellare la lingua in base alle tue esigenze, usare tutti i registri, gli stili e lepossibilità che essa, la lingua, ti offre.
Non puoi parlare diLucifero con la stessa lingua che usi per descrivere la visione della trinità.
Può aiutarvi a capireciò che intendo analizzare un po’ il lessico dell’opera.
Nell’Inferno, per esempio, troviamo una lingua spesso bassa, aspra a volte addirittura comica, le cui parole Dante trae, prende dal fiorentino popolare; (si incontrano parole come “culo”, “merda”, “puttana”, o un verso comico famosissimo come “Ed elli avea del cul fatto trombetta”, cioè “aveva usato il culo come una tromba”; Dante sta descrivendo un diavolo che per dare agli altri diavoli il comando dimettersi in marcia come in battaglia scorreggia, paragonando quindi la scorreggia al suono di una tromba militare.
All’estremo opposto abbiamo la lingua del Paradiso: elegante, solenne, colta, piena di latinismi (come “misericordia”, “grazia”, “magnificenza”, “benignità” e tanti altri).
La base della sua lingua è il fiorentino: del fiorentino Dante usa parole del suo tempo e parole arcaiche già a suo tempo, che i suoi contemporanei già non usavano più.
Dante attinge molto poi anche da altre lingue, tra cui il francese (per parole come “approcciare” e “sovente”) e, soprattutto, il provenzale (per esempio “noia” e “speranza”).
Oltre alle lingue straniere Dante fa sue parole e forme grammaticali che trova in altri dialetti toscani e a volte altri dialetti italiani.
Dante ad opera poi termini dell’astronomia (come “zenit”, “galassia”, “empireo”), della medicina(“coagulare” “febbre acuta”) e della musica (arpa e leuto, ovvero “liuto”).
E quando non trovauna parola se la inventa di sana pianta; i suoi neologismi sono chiamati“dantismi” e ce ne sono tanti.
Dante si inventa parole come, per esempio, “infuturarsi” (ovvero “prolungarsi nel futuro”)“trasumanare” (andare al di là dei limiti della natura umana), “inurbarsi”(entrare in città), “inluiarsi” (“diventare lui”).
Molti di questi dantismi a dire il vero non si usano più, ma non si può dire che Dante non fosse creativo e non amasse sperimentare e giocare con la lingua.
Ciò che invece usiamo ancora sono espressioni idiomatiche inventate da Dante ed entrate nel linguaggio comune, come “senza infamia e senza lode”, “non ragioniam* di lor, ma guarda e passa”, “lasciate ogni speranza voi ch’entrate” .
Ma vediamo qualche dato che ci aiuta a capire l’impatto della Commedia sul lessico dell’italiano.
Secondo uno studio del linguista Tullio de Mauro nella letteratura che precede Dante era già attestato il 62% delle 2000 parole più comuni nell’italiano, che compongono quindi il cosiddetto “lessico fondamentale”.
Alla fine del ‘300questa percentuale sale all’84%: ciò è sicuramente dovuto al contributo di Dante, almeno in buona parte.
Oltre a ciò, le parole che già esistevano e che Dante ha usato personalmente sono generalmente sopravvissute di più rispetto a quelle che non ha accolto (precisamente 2 volte e mezza di più).
Potremmo rispondere alla domanda però da un altro punto di vista: se la lingua italiana si basa ancora oggi sulla lingua fiorentina del ‘300 il merito è in gran parte di Dante, ma anche Petrarca e Boccaccio.
Se non fosse stato per loro oggi forse non parleremmo una lingua basata sul fiorentino, ma magari una lingua basata sul bolognese, sul siciliano, sul veneto, sul bergamasco.
O magari non avremmouna lingua nazionale.
Chi può dirlo? Ciò che è sicuro è che prima di Dante il fiorentino era UNA lingua italiana, ma già due secoli dopo di lui è diventato LA lingua italiana.
E Dante di questo è responsabile.
C’è chi dice che è la lingua della letteratura ad aver creato l’Italia e c’è chi addirittura definisce Dante padre dell’Italia (non tutti sono d’accordo con questa definizione).
Io non mi sento abbastanza competente per esprimere la mia opinione su questo, ma una cosa è innegabile: l’Italia ha raggiunto un’unità culturale e letteraria molto prima dell’unità politica.
La letteratura, e non l’esercito (come in altri stati europei) ha dato prestigio all’italiano.
L’italiano non è mai stato imposto con i fucili e le spade ma si è imposto con la bellezza della sua letteratura.
A Dante va riconosciuto il merito di aver fatto una scommessa.
Ha creduto seriamente nel volgare e non l’ha ritenuto inferiore al latino; ne ha mostrato tutte le potenzialità espressive; l’ha impiegato per scrivere l’opera più importante della sua vita, facendo una scelta molto rivoluzionaria e anche molto rischiosa: scrivere un poema in volgare (molti lo criticarono per aver usato il fiorentino e non il latino).
La storia gli ha dato ragione, perché ancora oggi, in un mondo sicuramente diverso da quello di 700anni fa, usiamo ancora le parole che Dante ha reso immortali.
Per questo l’epiteto di padre è adeguato: Dante si merita davvero il titolo di padre dell’italiano.
21:57 - Dovresti leggere la Commedia? Ora potreste chiedervi se ha senso leggere la Commedia nel2021.
Se siete italiani la risposta è facile: sì.
Dante fa parte del nostro sapere comune e della nostra identità, quindi conoscerlo non fa male.
Io stesso sto leggendo integralmente la Commedia per la prima volta (perché a scuola leggiamo e studiamo una selezione di canti) e la trovo davvero divertente, istruttiva e a volte illuminante.
E se siete stranieri? Ni.
O meglio, dipende dai vostri interessi e obiettivi.
Chiaramente leggere un’opera di 700 anni fa non è una grande idea per imparare l’italiano del 2021;tuttavia penso che, essendo quell’italiano relativamente simile al nostro, se avete un livello intermedio-avanzato e vi interessa la letteratura e Dante, possa aver senso avvicinarsi alla Commedia, magari con una guida che vi aiuti a farlo, il vostro Virgilio personale.
È per questo che sto leggendo la Commedia per voi sul mio Club su Patreon, dove potete in primo luogo sostenere questo progetto, se vi piace e vi aiuta; in secondo luogo ottenere tantissimi contenuti esclusivi tra cui, appunto, una serie di dirette che io ed Erika stiamo facendo in cui spieghiamo e leggiamo alcuni Canti della Commedia.
Finora ne abbiamo letti tre e ci stiamo divertendo molto: la reazione del membri Club è stata finora molto positiva, devo dire, e per questo l’intenzione è di continuare per tutto il 2021 e celebrare così il Sommo Poeta.
Quindi se hai pensato di iscriverti al Club e dopo questo video ti è venuta voglia di leggere Dante…questo è il momento per fare l’una e l’altra cosa.
Ah, per poter vederele dirette su Dante il prezzo che ti chiedo è simbolico, $1 al mese.
Quindi ci sta, dai.
Se sei interessato segui questo link.
Io ringrazio i membri del Club che vedete scorrere per il sostegno a questo progetto.
E noi ci vediamo presto, ciao!

.png)



.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
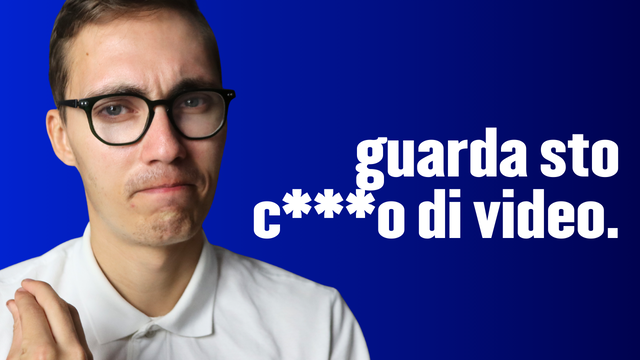
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)





























