Doppie FANTASMA in italiano? Il raddoppiamento fonosintattico [Learn Italian, with subs]
Tutto “apposto”.
Tutto “a posto”, “apposto”.
Ma, ma come si scrive?
Beh, se avete una minima conoscenza della lingua italiana sapete che si scrive “a posto”, due parole staccate. Ok, e come si pronuncia? Beh, in italiano standard si pronuncia [appósto], con una doppia.
TrascrizionePDF con glossario audio isolato (PI Club)
“Apposto”. Quindi “a posto” come“ tutto ok” e “apposto” come “ho apposto una firma”, dal verbo “apporre” hanno la stessa identica pronuncia.
E oggi vedremo il perché di questo strano fenomeno di pronuncia. [apposto] è la forma corretta.
E se mi sente una persona del Centro o del Sud dell’Italia non si sorprende minimamente, perché ha sempre detto [appósto].
Ma se mi sente una persona del Nord potrebbe pensare che io sia leggermente pazzo.
Perché “a posto” sono due parole staccate, quindi [apósto]. Però in italiano standard la pronuncia dovrebbe essere proprio questa, [appósto], ma non solo in “a posto”, anche in altre combinazioni come “tu sei”, [tussèi], [kevvuòi],[offàtto], [dʒàddétto]. E tante altre.
Ma quindi ci sono delle doppie “fantasma”? Da dove escono? Da dove arrivano? Questo fenomeno si chiama “raddoppiamento fonosintattico” e so che sembra difficile, ma non vi preoccupate, non vi spaventate, è meno difficile di quanto sembri indicare il nome.
Il raddoppiamento fonosintattico è un fenomeno dell’italiano standard, quindi significa che è presente nella dizione, nel modo in cui parlano gli attori di teatro, i doppiatori, tutte le persone che cercano di imparare quest o modo di pronunciare l’italiano, come anche me.
Io cerco di parlare in dizione da qualche tempo. Ho dedicato un video alla dizione, magari vi può interessare. La dizione si basa sul fiorentino, e quindi questo fenomeno che c’è nel fiorentino c’è anche nell’italiano standard, nella dizione standard.
Ma questo non è un fenomeno esclusivo del fiorentino, è un fenomeno dei dialetti del Centro e del Sud.
Ma è un fenomeno che è totalmente assente nei dialetti del Nord Italia, quindi questa è una differenza importante. Ok, ma come funziona esattamente? Non è che possiamo mettere doppie a caso e tutto va bene.
No, ci sono delle parole dopo le quali la parola successiva inizierà con una consonante raddoppiata. Cioè, delle parole che fanno raddoppiare la prima consonante della parola dopo.
Ok? Sono tre categorie di parole. La prima categoria sono i monosillabi forti. Allora, un monosillabo è una parola che ha una sola sillaba. Fanno parte dei monosillabi forti tutta una serie di parole. Per esempio i monosillabi che hanno un accento sulla vocale, quindi per esempio “può”, oppure“ già”, “è”, il verbo “essere”, quindi [èvvéro], [pwoddàrsi], [dʒaffàtto], ma anche tanti monosillabi che non hanno l’ accento, quindi “a”/”ha”, “che”, “chi”, “ho”, quindi per esempio [keffài], [kissèi], [arróma], [od détto].
Ci sono monosillabi deboli, come per esempio gli articoli. Non diciamo[la ppersóna], diciamo [la persóna], senza raddoppiamento, ma diciamo [oddétto],[kisséi], [dʒaffàtto]. Poi ci sono le parole più lunghe di una sillaba che sono tronche, cioè l’accento cade sull’ultima sillaba, quindi per esempio “virtù”, “caffè”, “città”. Quindi per esempio[kaffèllùngo], o [kaffèllatte].
Oppure una [tʃittàggrande]. Ma anche il futuro, quindi “sarò”, per esempio, “saro”, “avrò”, “io [sarokkapàtʃe], oppure il passato remoto, “partì”, “l’uomo [partissùbito]. E poi ci sono altre parole che non rientrano in queste due categorie, che sono parole speciali come “come”, ”dove”, “qualche” e “sopra”. Quindi [komemmé],oppure [kwalkevvòlta]. Ripeto, questa è la pronuncia nell’italiano standard.
Ok, ma da dove vengono questi strani raddoppiamenti, queste consonanti fantasma? Perché “hoddetto”? Non è un po’ strano? Ovviamente l’origine è da ricercarsi nella lingua latina!
Sì, perché questo alla fine è un fenomeno di assimilazione. Che cos’è un’assimilazione? Beh, intanto cosa vuol dire “assimilare”? “Assimilare” significa “rendere simile a sé stesso”. Quindi facciamo un esempio che secondo me è molto chiaro. La parola “admittō” in latino, che in italiano diventa “ammetto”. Vediamo un’assimilazione perché la “m” di “mittō” assimila la “d”, e in italiano abbiamo “ammetto”.
E questo non succede in altre lingue romanze. Quindi in spagnolo diciamo “admito”, o in francese “admets”. Anche in inglese c’è “admit”, che viene dal francese. La “d” quindi non sparisce, mentre in italiano sparisce, ed è un fenomeno molto molto comune, questa assimilazione, all’interno delle parole.
Quindi per esempio noi non diciamo “facto”, che deriva da “factum” in latino, diciamo “fatto”, perché la “c” viene assimilata dalla “t”. Oppure non diciamo “obtenere”, diciamo “ottenere” perché la “b” viene assimilata dalla “t”, anche se deriva dal latino obtinēre e in spagnolo si dice “obtener*”, e in francese anche “obtenir”.
Ci sono tantissime parole in italiano che hanno una doppia all’interno e quella doppia è proprio causata da un’assimilazione di questo genere. Quindi ok, “ammettere”, ma se noi abbiamo una “d” e una “n” ma al confine [06:10] tra due parole, quindi “ad mē”, “ad mē” in latino. Beh, “ad mē” in latino diventa in fiorentino “a (m)me” [ammé] perché succede la stessa cosa che succede in “ammettere”, quindi “a (m)me”. Quindi la differenza tra “ammettere” e “a me” è che “ammettere” è una parola, “a me” due parole. Però il fenomeno che succede è lo stesso, in un caso dentro la parola, nell’altro caso tra due parole. Ed è proprio quest’ultimo il raddoppiamento fonosintattico. Oppure prendiamo il verbo latino advenīre, o “adwenīre”, con la pronuncia classica che usavano iRomani. In italiano questo diventa “avvenire”, quindi la “d” si assimila.
Ok.
Però se noi prendiamo “ad vōs”, o “ad wōs” che succede? Beh, in fiorentino succede che dobbiamo dire“ a (v)voi”. Oppure la combinazione “trēs canēs” in latino diventa “tre (c)cani” in italiano, come l’Enciclopedia Treccani. Perché la “s” viene assimilata dalla “c” subito dopo. Ma anche con le parole tronche, come città, che abbiamo visto prima, per esempio “città” deriva dal latino “cīvitа̄tem” oppure “ciwītа̄tem”, che in proto-italiano diventa “cittade”, in italiano antico è ancora “cittade”.
Ecco, questa “de” si assimila e per questo “città” vuole un raddoppiamento. “Città (g)grande”, perché sarebbe “cittade grande”, “città (g)grande”. No? Quello spazio viene riempito, viene compensato dal raddoppiamento.
Quindi questa è l ’origine del fenomeno. C’è un’assimilazione. Però noi vediamo che in realtà questo fenomeno in italiano succede, si verifica anche con delle parole che in latino non finivano per consonante, quindi non c’è stata nessuna assimilazione.
Per esempio, “tu” che deriva dal latino “tū” Oppure “chi” che deriva dal latino “quī”. E quindi come si spiega “tu (s)sei” oppure “chi (s)sei”? Beh, praticamente è successo che così tante parole che avevano accento alla fine oppure avevano una sola sillaba, quindi l’accento cadeva su quella sillaba, così tante di queste parole causavano il raddoppiamento a causa di un’assimilazione che le persone inconsciamente hanno iniziato a pensare che la causa non fosse un’assimilazione che loro non percepivano, ma fosse proprio il fatto che l’ultima sillaba era accentata, una sorta di rianalisi, no? E quindi questo fenomeno è stato poi esteso ad altre parole dove ciò non doveva e non dovrebbe accadere.
Non so se è chiaro. Quindi per questo “tu(s)sei” o “chi (s)sei”. È stata fatta quindi inconsciamente un’analogia con altre parole e questo è affascinante, sono fenomeni che ovviamente si verificano inconsciamente, però è molto molto interessante studiarli. Ok, quindi questo raddoppiamento fonosintattico è un fenomeno solo del parlato, no?
Cioè non. . . non si scrive? Non è proprio così, perché in italiano c’è una lunga lunga serie di parole che si dicono “univerbate”, cioè parole che in origine erano due parole, dei composti che si sono uniti, che si sono univerbati, che si sono fusi, possiamo dire. Quindi, per esempio, “appena”, “apposta”, “davvero”, “eppure”, “frattempo”, come “nel frattempo”, “sebbene”, “soprattutto”, “chissenefrega” e anche tantissime altre parole. E se andiamo a vedere, sono delle parole in cui c’è un monosillabo, uno di quelli della lista di prima, e poi un’altra parola. E quindi logicamente si doveva verificare e si verificava un raddoppiamento, cioè “a + pena ”diventava “appena” e questo si riflette anche nel modo in cui si scrive.
Noi effettivamente scriviamo il raddoppiamento fonosintattico, perché per noi oramai “appena” o “davvero” o “oppure” sono una parola sola, non due parole, le percepiamo come una parola. E tra l’altro, anche quando diciamo “dimmi” oppure “dammi” oppure “vacci” — ecco, questi sono degli imperativi che sono dei monosillabi. “Di’” è un imperativo, “va’”, “vacci”, “va’”. Ecco, questi imperativi sono collegati con dei pronomi, ma dato che sono dei monosillabi causano il raddoppiamento.
Per questo diciamo “dimmi” e “dammi”, mentre in spagnolo no, non c’è questo, si dice “dime” e “dame”. Ok, quindi questo è un fenomeno del Centro-Sud e dei dialetti del Centro-Sud e anche l’italiano, che di fatto è un dialetto del Centro che è diventato un po’ più importante degli altri.
Ma nei dialetti del Nord questo fenomeno è totalmente assente. Anzi, nei dialetti del Nord solitamente il fenomeno è contrario, cioè si tolgono tutte le doppie. Però quando al Nord abbiamo (dico abbiamo perché io sono di Torino, del Nord), abbiamo imparato l’italiano, abbiamo imparato a pronunciare le doppie quando le doppie sono scritte, quindi nessun italiano settentrionale avrebbe dei problemi a dire “sebbene” oppure “eppure” oppure. . oppure “oppure”, anche “oppure”!
Lo vediamo scritto, lo pronunciamo e non abbiamo problemi a par- te magari qualche persona molto anziana con un accento molto forte che anche in queste parole potrebbe avere difficoltà a pronunciare la doppia e la tendenza a non dire la doppia. Però non abbiamo problemi generalmente. Tuttavia, per noi il raddoppiamento fonosintattico è qualcosa di alieno, non diremmo. . non diremmo mai “a(r)Roma”, diremmo “a Roma”, non diremmo mai “a (p)Parma” ma “a Parma”, però diciamo“ appena”. Non diremmo mai “se(b)bevi”, no? “Se (b)bevi” ma diciamo “sebbene”, quindi noi le doppie le facciamo quando le vediamo scritte, perché per noi nei dialetti del Nord questo fenomeno non è. . non esiste e quindi non è naturale nemmeno quando parliamo italiano.
Tra l’altro, se vi interessa vi lascio un link che vi manda al DOP, il Dizionario di ortografia e pronunzia (pronunzia!) dove potete andare a verificare se c’è un raddoppiamento, quindi vedete: se una parola ha questo “+”, il più significa che è necessario fare un raddoppiamento, quindi è un modo di verificare se si deve fare oppure no, o almeno nella dizione. Questo che significa? Che ora dovete imparare a fare tutti questi raddoppiamenti, sia che voi siate stranieri sia che voi siate italiani?
No, non dovete farli, a meno che non vogliate proprio padroneggiare, perfezionare la dizione. Non è assolutamente necessario, però ritengo sia interessante e. . e questo anche vi aiuta a capire perché diciamo “davvero”, “sebbene”, “eppure” ma anche “dimmi” e “dammi” e tutte queste cose.
Ora, ho delle domande sia per gli stranieri sia anche per la minoranza di italiani che mi segue. Allora, se siete stranieri: conoscevate questo fenomeno, l’avete mai notato? Magari l’avete notato ascoltando persone del Centro-Sud. E vi consiglio anche di provare a notarlo e notare le differenze tra un italiano, per esempio, di Roma e un italiano del Nord. Anche qui su YouTube! Se guardare Alberto Arrighini, per esempio, che è di Brescia, del Nord e quindi non ha i raddoppiamenti e se guardate, per esempio, Lucrezia Oddone che è di Roma e quindi ha tutti questi raddoppiamenti. E se siete italiani voglio invece chiedervi: conoscevate dell’esistenza di questo fenomeno?
Esiste nel vostro italiano regionale e esiste come l’ho descritto io o magari non esiste con alcune parole? Perché, per esempio, ci sono delle differenze. Si dice che “da” e “dove” necessitino il raddoppiamento, ma in realtà secondo me è una cosa che ormai si fa solamente a Firenze, nemmeno nell’italiano standard si dice “da(d)dove” oppure “da (f)Firenze” o “da (q)quando” oppure “di dove (s)sei?” Solamente i fiorentini direbbero così. O forse i toscani, non lo so, però ditemi voi e se c’è qualcuno che ha anche delle correzioni e ne sa più di me siete liberi di commentare come sempre. Detto questo io vi ringrazio per la cortese attenzione.
Voglio ancora parlarvi del mio Patreon, della mia. . del mio Podcast Italiano Club su Patreon.
Se state imparando l’italiano vi potrebbe interessare il mio club perché è un luogo dove potete ricevere dei contenuti bonus, dove potete. . che vi permette di entrare a far parte di un gruppo Telegram dove chiacchieriamo di italiano e di tante altre cose. Oramai è il principale modo in cui riesco a guadagnare da questo progetto quindi grazie di cuore a tutte le persone che mi sostengono. E andare a dare un’occhiata se vi può interessare. Un enorme abbraccio ai miei patrons, ai miei sostenitori. E un grazie a tutti per aver visto questo video. A (p)presto! “A(p)presto”, non “a presto”. Ciao! Beh, in fiorentino succede che dobbiamo dire “a (v)voi”. Oppure la combinazione “trēscanēs” in latino diventa “tre (c)cani” in italiano, come l’Enciclopedia Treccani.
Perché la “s” viene assimilata dalla “c” subito dopo. Ma anche con le parole tronche, come città, che abbiamo visto prima, per esempio “città” deriva dal latino “cīvitа̄tem” oppure “ciwītа̄tem”, che in proto-italiano diventa “cittade”, in italiano antico è ancora “cittade”. Ecco, questa “de” si assimila e per questo “città” vuole un raddoppiamento. “Città (g)grande”, perché sarebbe “cittade grande”, “città (g)grande”. No? Quello spazio viene riempito, viene compensato dal raddoppiamento. Quindi questa è l’origine del fenomeno. C’è un’assimilazione.
Tutto “apposto”.
Tutto “a posto”, “apposto”.
Ma, ma come si scrive?
Beh, se avete una minima conoscenza della lingua italiana sapete che si scrive “a posto”, due parole staccate. Ok, e come si pronuncia? Beh, in italiano standard si pronuncia [appósto], con una doppia.
TrascrizionePDF con glossario audio isolato (PI Club)
“Apposto”. Quindi “a posto” come“ tutto ok” e “apposto” come “ho apposto una firma”, dal verbo “apporre” hanno la stessa identica pronuncia.
E oggi vedremo il perché di questo strano fenomeno di pronuncia. [apposto] è la forma corretta.
E se mi sente una persona del Centro o del Sud dell’Italia non si sorprende minimamente, perché ha sempre detto [appósto].
Ma se mi sente una persona del Nord potrebbe pensare che io sia leggermente pazzo.
Perché “a posto” sono due parole staccate, quindi [apósto]. Però in italiano standard la pronuncia dovrebbe essere proprio questa, [appósto], ma non solo in “a posto”, anche in altre combinazioni come “tu sei”, [tussèi], [kevvuòi],[offàtto], [dʒàddétto]. E tante altre.
Ma quindi ci sono delle doppie “fantasma”? Da dove escono? Da dove arrivano? Questo fenomeno si chiama “raddoppiamento fonosintattico” e so che sembra difficile, ma non vi preoccupate, non vi spaventate, è meno difficile di quanto sembri indicare il nome.
Il raddoppiamento fonosintattico è un fenomeno dell’italiano standard, quindi significa che è presente nella dizione, nel modo in cui parlano gli attori di teatro, i doppiatori, tutte le persone che cercano di imparare quest o modo di pronunciare l’italiano, come anche me.
Io cerco di parlare in dizione da qualche tempo. Ho dedicato un video alla dizione, magari vi può interessare. La dizione si basa sul fiorentino, e quindi questo fenomeno che c’è nel fiorentino c’è anche nell’italiano standard, nella dizione standard.
Ma questo non è un fenomeno esclusivo del fiorentino, è un fenomeno dei dialetti del Centro e del Sud.
Ma è un fenomeno che è totalmente assente nei dialetti del Nord Italia, quindi questa è una differenza importante. Ok, ma come funziona esattamente? Non è che possiamo mettere doppie a caso e tutto va bene.
No, ci sono delle parole dopo le quali la parola successiva inizierà con una consonante raddoppiata. Cioè, delle parole che fanno raddoppiare la prima consonante della parola dopo.
Ok? Sono tre categorie di parole. La prima categoria sono i monosillabi forti. Allora, un monosillabo è una parola che ha una sola sillaba. Fanno parte dei monosillabi forti tutta una serie di parole. Per esempio i monosillabi che hanno un accento sulla vocale, quindi per esempio “può”, oppure“ già”, “è”, il verbo “essere”, quindi [èvvéro], [pwoddàrsi], [dʒaffàtto], ma anche tanti monosillabi che non hanno l’ accento, quindi “a”/”ha”, “che”, “chi”, “ho”, quindi per esempio [keffài], [kissèi], [arróma], [od détto].
Ci sono monosillabi deboli, come per esempio gli articoli. Non diciamo[la ppersóna], diciamo [la persóna], senza raddoppiamento, ma diciamo [oddétto],[kisséi], [dʒaffàtto]. Poi ci sono le parole più lunghe di una sillaba che sono tronche, cioè l’accento cade sull’ultima sillaba, quindi per esempio “virtù”, “caffè”, “città”. Quindi per esempio[kaffèllùngo], o [kaffèllatte].
Oppure una [tʃittàggrande]. Ma anche il futuro, quindi “sarò”, per esempio, “saro”, “avrò”, “io [sarokkapàtʃe], oppure il passato remoto, “partì”, “l’uomo [partissùbito]. E poi ci sono altre parole che non rientrano in queste due categorie, che sono parole speciali come “come”, ”dove”, “qualche” e “sopra”. Quindi [komemmé],oppure [kwalkevvòlta]. Ripeto, questa è la pronuncia nell’italiano standard.
Ok, ma da dove vengono questi strani raddoppiamenti, queste consonanti fantasma? Perché “hoddetto”? Non è un po’ strano? Ovviamente l’origine è da ricercarsi nella lingua latina!
Sì, perché questo alla fine è un fenomeno di assimilazione. Che cos’è un’assimilazione? Beh, intanto cosa vuol dire “assimilare”? “Assimilare” significa “rendere simile a sé stesso”. Quindi facciamo un esempio che secondo me è molto chiaro. La parola “admittō” in latino, che in italiano diventa “ammetto”. Vediamo un’assimilazione perché la “m” di “mittō” assimila la “d”, e in italiano abbiamo “ammetto”.
E questo non succede in altre lingue romanze. Quindi in spagnolo diciamo “admito”, o in francese “admets”. Anche in inglese c’è “admit”, che viene dal francese. La “d” quindi non sparisce, mentre in italiano sparisce, ed è un fenomeno molto molto comune, questa assimilazione, all’interno delle parole.
Quindi per esempio noi non diciamo “facto”, che deriva da “factum” in latino, diciamo “fatto”, perché la “c” viene assimilata dalla “t”. Oppure non diciamo “obtenere”, diciamo “ottenere” perché la “b” viene assimilata dalla “t”, anche se deriva dal latino obtinēre e in spagnolo si dice “obtener*”, e in francese anche “obtenir”.
Ci sono tantissime parole in italiano che hanno una doppia all’interno e quella doppia è proprio causata da un’assimilazione di questo genere. Quindi ok, “ammettere”, ma se noi abbiamo una “d” e una “n” ma al confine [06:10] tra due parole, quindi “ad mē”, “ad mē” in latino. Beh, “ad mē” in latino diventa in fiorentino “a (m)me” [ammé] perché succede la stessa cosa che succede in “ammettere”, quindi “a (m)me”. Quindi la differenza tra “ammettere” e “a me” è che “ammettere” è una parola, “a me” due parole. Però il fenomeno che succede è lo stesso, in un caso dentro la parola, nell’altro caso tra due parole. Ed è proprio quest’ultimo il raddoppiamento fonosintattico. Oppure prendiamo il verbo latino advenīre, o “adwenīre”, con la pronuncia classica che usavano iRomani. In italiano questo diventa “avvenire”, quindi la “d” si assimila.
Ok.
Però se noi prendiamo “ad vōs”, o “ad wōs” che succede? Beh, in fiorentino succede che dobbiamo dire“ a (v)voi”. Oppure la combinazione “trēs canēs” in latino diventa “tre (c)cani” in italiano, come l’Enciclopedia Treccani. Perché la “s” viene assimilata dalla “c” subito dopo. Ma anche con le parole tronche, come città, che abbiamo visto prima, per esempio “città” deriva dal latino “cīvitа̄tem” oppure “ciwītа̄tem”, che in proto-italiano diventa “cittade”, in italiano antico è ancora “cittade”.
Ecco, questa “de” si assimila e per questo “città” vuole un raddoppiamento. “Città (g)grande”, perché sarebbe “cittade grande”, “città (g)grande”. No? Quello spazio viene riempito, viene compensato dal raddoppiamento.
Quindi questa è l ’origine del fenomeno. C’è un’assimilazione. Però noi vediamo che in realtà questo fenomeno in italiano succede, si verifica anche con delle parole che in latino non finivano per consonante, quindi non c’è stata nessuna assimilazione.
Per esempio, “tu” che deriva dal latino “tū” Oppure “chi” che deriva dal latino “quī”. E quindi come si spiega “tu (s)sei” oppure “chi (s)sei”? Beh, praticamente è successo che così tante parole che avevano accento alla fine oppure avevano una sola sillaba, quindi l’accento cadeva su quella sillaba, così tante di queste parole causavano il raddoppiamento a causa di un’assimilazione che le persone inconsciamente hanno iniziato a pensare che la causa non fosse un’assimilazione che loro non percepivano, ma fosse proprio il fatto che l’ultima sillaba era accentata, una sorta di rianalisi, no? E quindi questo fenomeno è stato poi esteso ad altre parole dove ciò non doveva e non dovrebbe accadere.
Non so se è chiaro. Quindi per questo “tu(s)sei” o “chi (s)sei”. È stata fatta quindi inconsciamente un’analogia con altre parole e questo è affascinante, sono fenomeni che ovviamente si verificano inconsciamente, però è molto molto interessante studiarli. Ok, quindi questo raddoppiamento fonosintattico è un fenomeno solo del parlato, no?
Cioè non. . . non si scrive? Non è proprio così, perché in italiano c’è una lunga lunga serie di parole che si dicono “univerbate”, cioè parole che in origine erano due parole, dei composti che si sono uniti, che si sono univerbati, che si sono fusi, possiamo dire. Quindi, per esempio, “appena”, “apposta”, “davvero”, “eppure”, “frattempo”, come “nel frattempo”, “sebbene”, “soprattutto”, “chissenefrega” e anche tantissime altre parole. E se andiamo a vedere, sono delle parole in cui c’è un monosillabo, uno di quelli della lista di prima, e poi un’altra parola. E quindi logicamente si doveva verificare e si verificava un raddoppiamento, cioè “a + pena ”diventava “appena” e questo si riflette anche nel modo in cui si scrive.
Noi effettivamente scriviamo il raddoppiamento fonosintattico, perché per noi oramai “appena” o “davvero” o “oppure” sono una parola sola, non due parole, le percepiamo come una parola. E tra l’altro, anche quando diciamo “dimmi” oppure “dammi” oppure “vacci” — ecco, questi sono degli imperativi che sono dei monosillabi. “Di’” è un imperativo, “va’”, “vacci”, “va’”. Ecco, questi imperativi sono collegati con dei pronomi, ma dato che sono dei monosillabi causano il raddoppiamento.
Per questo diciamo “dimmi” e “dammi”, mentre in spagnolo no, non c’è questo, si dice “dime” e “dame”. Ok, quindi questo è un fenomeno del Centro-Sud e dei dialetti del Centro-Sud e anche l’italiano, che di fatto è un dialetto del Centro che è diventato un po’ più importante degli altri.
Ma nei dialetti del Nord questo fenomeno è totalmente assente. Anzi, nei dialetti del Nord solitamente il fenomeno è contrario, cioè si tolgono tutte le doppie. Però quando al Nord abbiamo (dico abbiamo perché io sono di Torino, del Nord), abbiamo imparato l’italiano, abbiamo imparato a pronunciare le doppie quando le doppie sono scritte, quindi nessun italiano settentrionale avrebbe dei problemi a dire “sebbene” oppure “eppure” oppure. . oppure “oppure”, anche “oppure”!
Lo vediamo scritto, lo pronunciamo e non abbiamo problemi a par- te magari qualche persona molto anziana con un accento molto forte che anche in queste parole potrebbe avere difficoltà a pronunciare la doppia e la tendenza a non dire la doppia. Però non abbiamo problemi generalmente. Tuttavia, per noi il raddoppiamento fonosintattico è qualcosa di alieno, non diremmo. . non diremmo mai “a(r)Roma”, diremmo “a Roma”, non diremmo mai “a (p)Parma” ma “a Parma”, però diciamo“ appena”. Non diremmo mai “se(b)bevi”, no? “Se (b)bevi” ma diciamo “sebbene”, quindi noi le doppie le facciamo quando le vediamo scritte, perché per noi nei dialetti del Nord questo fenomeno non è. . non esiste e quindi non è naturale nemmeno quando parliamo italiano.
Tra l’altro, se vi interessa vi lascio un link che vi manda al DOP, il Dizionario di ortografia e pronunzia (pronunzia!) dove potete andare a verificare se c’è un raddoppiamento, quindi vedete: se una parola ha questo “+”, il più significa che è necessario fare un raddoppiamento, quindi è un modo di verificare se si deve fare oppure no, o almeno nella dizione. Questo che significa? Che ora dovete imparare a fare tutti questi raddoppiamenti, sia che voi siate stranieri sia che voi siate italiani?
No, non dovete farli, a meno che non vogliate proprio padroneggiare, perfezionare la dizione. Non è assolutamente necessario, però ritengo sia interessante e. . e questo anche vi aiuta a capire perché diciamo “davvero”, “sebbene”, “eppure” ma anche “dimmi” e “dammi” e tutte queste cose.
Ora, ho delle domande sia per gli stranieri sia anche per la minoranza di italiani che mi segue. Allora, se siete stranieri: conoscevate questo fenomeno, l’avete mai notato? Magari l’avete notato ascoltando persone del Centro-Sud. E vi consiglio anche di provare a notarlo e notare le differenze tra un italiano, per esempio, di Roma e un italiano del Nord. Anche qui su YouTube! Se guardare Alberto Arrighini, per esempio, che è di Brescia, del Nord e quindi non ha i raddoppiamenti e se guardate, per esempio, Lucrezia Oddone che è di Roma e quindi ha tutti questi raddoppiamenti. E se siete italiani voglio invece chiedervi: conoscevate dell’esistenza di questo fenomeno?
Esiste nel vostro italiano regionale e esiste come l’ho descritto io o magari non esiste con alcune parole? Perché, per esempio, ci sono delle differenze. Si dice che “da” e “dove” necessitino il raddoppiamento, ma in realtà secondo me è una cosa che ormai si fa solamente a Firenze, nemmeno nell’italiano standard si dice “da(d)dove” oppure “da (f)Firenze” o “da (q)quando” oppure “di dove (s)sei?” Solamente i fiorentini direbbero così. O forse i toscani, non lo so, però ditemi voi e se c’è qualcuno che ha anche delle correzioni e ne sa più di me siete liberi di commentare come sempre. Detto questo io vi ringrazio per la cortese attenzione.
Voglio ancora parlarvi del mio Patreon, della mia. . del mio Podcast Italiano Club su Patreon.
Se state imparando l’italiano vi potrebbe interessare il mio club perché è un luogo dove potete ricevere dei contenuti bonus, dove potete. . che vi permette di entrare a far parte di un gruppo Telegram dove chiacchieriamo di italiano e di tante altre cose. Oramai è il principale modo in cui riesco a guadagnare da questo progetto quindi grazie di cuore a tutte le persone che mi sostengono. E andare a dare un’occhiata se vi può interessare. Un enorme abbraccio ai miei patrons, ai miei sostenitori. E un grazie a tutti per aver visto questo video. A (p)presto! “A(p)presto”, non “a presto”. Ciao! Beh, in fiorentino succede che dobbiamo dire “a (v)voi”. Oppure la combinazione “trēscanēs” in latino diventa “tre (c)cani” in italiano, come l’Enciclopedia Treccani.
Perché la “s” viene assimilata dalla “c” subito dopo. Ma anche con le parole tronche, come città, che abbiamo visto prima, per esempio “città” deriva dal latino “cīvitа̄tem” oppure “ciwītа̄tem”, che in proto-italiano diventa “cittade”, in italiano antico è ancora “cittade”. Ecco, questa “de” si assimila e per questo “città” vuole un raddoppiamento. “Città (g)grande”, perché sarebbe “cittade grande”, “città (g)grande”. No? Quello spazio viene riempito, viene compensato dal raddoppiamento. Quindi questa è l’origine del fenomeno. C’è un’assimilazione.

.png)



.png)




.png)
%20(2)(1).jpg)



.png)
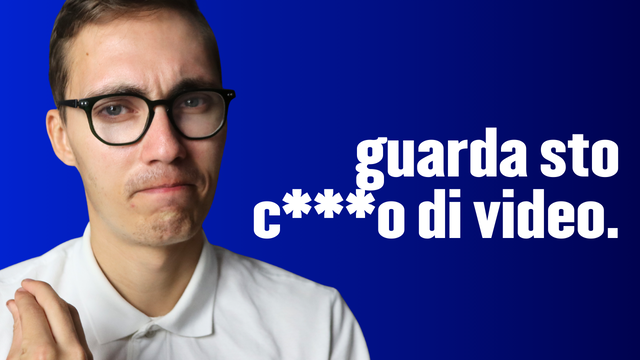
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)


.png)

.png)








%20(1).png)

%20(1)%20(1).png)
%20(1).jpg)





.jpg)

.webp)
.webp)











.webp)


.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


.webp)





























