La musica in Italia
Questo episodio è dedicato alla musica in Italia: dai canti popolari regionali come i canti a tenore sardi e la tarantella del Sud, fino alle canzoni di resistenza come "Bella ciao", scopriamo come la musica unisce le comunità italiane.
Scopri La Storia di Italo, il mio corso per raggiungere il livello intermedio.
Accedi o registrati per continuare a leggere
Ciao e benvenuto, o benvenuta, su Podcast Italiano Principiante, un podcast per chi sa un po’ di italiano e vuole fare progressi. Io sono Irene e oggi parliamo di qualcosa che accompagna da sempre la vita quotidiana degli italiani: la musica.
Scarica la versione PDF della trascrizione
Trascrizione interattiva dell'episodio
Immagina una piazza italiana, magari d’estate, con i tavolini all’aperto e tante persone che passeggiano o si riposano. Poi, all’improvviso, un musicista di strada inizia a suonare e ad animare la piazza: in pochi minuti, la gente comincia a battere le mani, a canticchiare, ad alzarsi e ballare.
La musica, in Italia, è un collante sociale. Come una colla, unisce le persone, senza distinzioni di età, provenienza o lavoro. Quando si canta o si ascolta la musica insieme, si diventa parte di un unico gruppo.
Questo perché la musica, in Italia, non è solo un mezzo di intrattenimento, ma anche un modo per condividere un senso di appartenenza. Fin dai tempi più antichi, in Italia, nelle feste di paese, nei campi o nelle piazze, il canto collettivo serviva a rafforzare i legami della comunità. Infatti, uno dei pilastri del rapporto degli italiani con la musica è la tradizione popolare.
Ogni regione ha i suoi canti, le sue melodie, i suoi strumenti tipici. In Sardegna, ad esempio, ci sono i canti a tenore, un canto corale che l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Senti.
In Sicilia, le serenate e le nenie popolari raccontano di amori impossibili, di nostalgia, di vita quotidiana. La nenia è un canto molto nostalgico, lento, lamentoso. Ascolta.
In generale, poi, nel Sud Italia, troviamo la tarantella e la pizzica, balli scatenati che, presumibilmente, nascono come rito di guarigione: si diceva che chi veniva morso dalla tarantola doveva ballare senza sosta per liberarsi dal veleno. Immagina di ballare su queste note.
E nel Nord Italia ci sono tantissimi tipi di canti popolari. Ad esempio i canti alpini, canti corali che raccontano storie, leggende, e la vita di montagna. Ti faccio ascoltare un pezzetto di uno dei più famosi, Quel mazzolin di fiori.
[Quel mazzolin di fiori
Che vien dalla montagna
Quel mazzolin di fiori
Che vien dalla montagna
E bada ben che non si bagna
Che lo voglio regalare
E bada ben che non si bagna
Che lo voglio regalar
Lo voglio regalare]
E un altro esempio è il trallallero genovese, un canto polifonico, cioè con più suoni, con più voci: qui, non si usano strumenti musicali ma solo la voce. Cinque o più persone cantano, imitando gli strumenti musicali. È praticamente un canto a cappella. Ascolta qui.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la musica è diventata anche un atto di resistenza. Un esempio di canzone di resistenza è Bella ciao, canzone che oggi è conosciuta in tutto il mondo. Te ne faccio ascoltare un pezzo.
[Una mattina mi son svegliato,
oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir]
Bella ciao non era solo una canzone, ma un simbolo: raccontava il desiderio di libertà, la speranza di un futuro migliore. Non tutti sanno che l’origine di questa canzone è abbastanza incerta. Molti dicono che nasce da vecchi canti popolari del Nord Italia, come Fior di tomba, piemontese, che ha un testo molto simile. Un altro canto che probabilmente ha influenzato Bella ciao è il canto trentino La me nòna l’è vecchierella (cioè “mia nonna è vecchia, anziana”), un canto per bambini che ripete tante volte la parola “ciao”. È davvero simile. Ascolta.
[La me nòna l'è vecchierèlla
la me fa ciau
la me diś ciau
la me fa ciau ciau ciau
la me manda la funtanèla
a tor l'acqua per deśinar]
Oggi, Bella ciao resta una delle canzoni più cantate nelle piazze italiane, soprattutto durante le manifestazioni e altri eventi pubblici. In questo senso, la canzone collega perfettamente passato e presente, memoria e partecipazione collettiva. Se c’è un luogo che rappresenta il cuore musicale italiano, infatti, è la piazza. E non parliamo solo di resistenza e politica. In Italia le piazze sono anche luoghi di incontro e di festa, e la musica è sempre protagonista. Pensiamo ai concerti gratuiti del Primo Maggio a Roma, con migliaia di giovani riuniti, oppure ai festival estivi nei piccoli borghi, dove si canta e si balla fino a notte fonda. La piazza è uno spazio aperto, pubblico e democratico: lì la musica è davvero di tutti.
Spesso basta una chitarra e tutti sono pronti a cantare. Specialmente le canzoni d’autore, cioè scritte da cantautori come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, e Lucio Dalla, artisti che hanno usato le canzoni non solo per parlare d’amore, ma anche per raccontare la società, i cambiamenti, e i problemi politici. La canzone in Italia non è solo intrattenimento: è poesia popolare, un modo per riflettere sulla vita e sui problemi della società. Ascoltiamo un pezzetto de La Guerra di Piero di De André, una canzone che denuncia le atrocità della guerra. L'ispirazione per questa canzone è lo zio del cantautore, un sopravvissuto al campo di concentramento durante la Seconda guerra mondiale.
[E mentre marciavi con l'anima in spalle,
vedesti un uomo in fondo alla valle,
che aveva il tuo stesso identico umore,
ma la divisa di un altro colore.
Sparagli Piero, sparagli ora!
E dopo un colpo sparagli ancora,
fino a che tu non lo vedrai esangue,
cadere in terra a coprire il suo sangue]
Un altro esempio di come la musica italiana racconti la vita delle persone è Amara terra mia di Domenico Modugno. Il brano parla della fatica, della nostalgia e dell’emigrazione, temi molto presenti nel Sud Italia del Novecento. Modugno canta la tristezza di chi lascia la propria terra alla ricerca di lavoro o di una vita migliore, quindi di un’emigrazione, spesso, forzata. Curiosamente, Amara terra mia è considerata una rielaborazione di una canzone tradizionale abruzzese, nata nei primi anni del 1900 come canto di lavoro delle raccoglitrici di olive nella zona della Maiella. Così, anche Modugno, come tanti cantautori italiani, prende ispirazione dalla tradizione popolare e la trasforma in un brano moderno che parla al cuore di tutti. Ascolta. È straziante.
[Sole alla valle, sole alla collina
Per le campagne non c'è più nessuno
Addio, addio amore, io vado via
Amara terra mia, amara e bella…]
Un aspetto molto forte della musica italiana, dunque, è quello della denuncia. Non solo della guerra, dell'emigrazione, ma anche della mafia e della criminalità organizzata. Sono molti i gruppi e i cantautori che hanno usato la musica come arma di resistenza. Ti faccio ascoltare una delle canzoni più belle, secondo me: I Cento Passi.
[Allora dimmi se tu sai contare!
Dimmi se sai anche camminare!
Contare, camminare insieme a cantare!
La storia di Peppino e degli amici siciliani, allora…
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento passi…]
Questa canzone racconta la storia di Peppino Impastato, un giovane siciliano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Il titolo, I cento passi, si riferisce alla distanza tra la casa di Peppino e quella del boss mafioso locale, e simboleggia il coraggio di chi si oppone alla criminalità anche quando è, proprio fisicamente, molto vicina. Questa canzone, che racconta la storia di Peppino, è diventata un inno antimafia, un inno di resistenza e impegno civile.
Comunque, passiamo dalla mafia all’amore, perché la musica italiana è davvero variegata e i temi da trattare sono tanti. Ovviamente anche in Italia ci sono tantissime canzoni d’amore, alcune più famose di altre. Adesso non voglio concentrarmi sulle canzoni d’amore, ma su una tradizione molto interessante, che è la serenata. La serenata è una tradizione antica, soprattutto nei piccoli paesi del Sud Italia. Oggi questa tradizione è un po’ scomparsa, ma non del tutto. Si tratta di un momento romantico e pubblico allo stesso tempo: un ragazzo innamorato va, di notte, sotto casa della ragazza che ama, che vuole sposare. Porta con sé dei musicisti e inizia a cantare canzoni d’amore, magari la loro canzone d’amore, per dichiararsi all’amata e magari chiederle di sposarlo. È un gesto simbolico fortissimo: a quel punto tutta la comunità, tutto il quartiere sa che quel ragazzo vuole sposarsi con lei. La serenata non è solo un atto romantico, ma anche un rito sociale, un modo per celebrare pubblicamente i sentimenti. Ancora oggi, in alcuni paesi del Sud, si organizzano serenate moderne, così che la musica diventa un ponte tra l’amore privato e la comunità. Io spero che a me non accada mai. Penso che sarebbe molto imbarazzante! Tu che ne pensi?
Comunque, parlando d’amore: ormai sai che uno dei più grandi amori degli italiani, soprattutto degli uomini, è il calcio. Infatti, un altro luogo dove la musica diventa protagonista è lo stadio. Se sei stato, o stata, a una partita di calcio in Italia, lo sai: i cori dei tifosi non sono semplici urla, sono vere e proprie canzoni. Ogni squadra ha i suoi cori, alcuni storici, altri più recenti. Ci sono quelli allegri, per festeggiare un gol, e quelli ironici, per prendere in giro gli avversari. Molti di questi cori derivano da canzoni pop italiane o internazionali. Spesso i tifosi prendono una melodia già conosciuta e ne cambiano le parole: ad esempio, il famoso coro Po po po po po po po è basato sulla melodia di una canzone rock abbastanza famosa. Ti faccio sentire il coro. Ed ecco l’originale.
Il bello è che, allo stadio, non importa se sei stonato o se non conosci bene il testo di un coro: canti insieme agli altri, e ti senti parte di qualcosa di più grande. È un po’ come nei canti popolari: la musica serve per creare comunità, per rafforzare il senso di appartenenza. Io sono romana e romanista, cioè tifo la Roma, che è la squadra della mia città. Quindi ti faccio ascoltare uno dei cori della Roma.
[Roma, Roma mia,
nun te fa incantà!
Tu sei nata grande…
E grande hai da restà!
Roma, Roma, Roma…
core de 'sta città,
unico grande amore…]
Lo stadio, per l’italiano medio, è una seconda casa. E questo può essere anche molto tenero, se pensiamo che spesso i ragazzi vanno allo stadio con il papà, con lo zio, o con il nonno. Sicuramente il calcio riesce ad unire le diverse generazioni. Ma non solo il calcio. Anche la musica collega le generazioni. Anche se magari i nonni italiani cantano le canzoni popolari, i genitori le canzoni degli anni ’70 e ’80, i giovani le canzoni moderne, capita spesso che, durante una festa, una playlist riproduca una vecchia canzone napoletana e subito dopo un brano moderno, e tutti si ritrovano comunque a cantare insieme. Soprattutto se si parla di canzoni particolarmente famose, iconiche, che magari hanno vinto il festival di Sanremo negli anni.
Ecco, il Festival di Sanremo è un evento che unisce tutti, che ogni anno ferma il Paese: immagina famiglie intere davanti alla TV, amici che discutono su chi vincerà, polemiche infinite sulle canzoni. Sanremo non è solo un concorso: è un rito collettivo della cultura e della società italiana. Spesso, chi vince Sanremo rimane famoso solo in Italia, raramente riesce a sfondare all’estero. Ci sono però delle eccezioni: un esempio recente sono i Måneskin, che hanno vinto Sanremo e poi hanno avuto un grande successo in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti. Ti faccio ascoltare la canzone con cui hanno vinto Sanremo nel 2021, Zitti e buoni.
[Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro…]
Comunque, prima di salutarti, non posso non parlare dell’Opera lirica. È uno dei grandi tesori culturali d’Italia, conosciuto e amato in tutto il mondo. E poi l’Opera è anche un simbolo della forza della lingua italiana. Le sue melodie e i suoi testi hanno fatto conoscere l’italiano in tutto il mondo, quando il Belpaese non era ancora famoso per la moda o la cucina. Pensa che l’Opera italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO nel 2023.
Nell’Opera, gli italiani hanno avuto ruoli fondamentali come librettisti, come compositori e come cantanti lirici. Giusto per fare qualche nome: tra i compositori, possiamo menzionare Rossini, autore de Il barbiere di Siviglia, o Giuseppe Verdi, celebre per La Traviata, Aida e Rigoletto; e poi, Giacomo Puccini, famoso per La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Dei cantanti lirici, basta fare un nome: l’unico e inimitabile Luciano Pavarotti, un tenore emiliano noto per la sua voce potentissima. Te lo faccio ascoltare qui in Nessun Dorma, canzone iconica dell’opera Turandot, l'ultima opera di Giacomo Puccini, nonché l'ultima grande opera romantica della storia.
[Dilegua, o notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!
Vincerò… vincerò!
Vincerò!]
L’episodio di oggi finisce qui. È stato un episodio un po’ diverso, quindi fammi sapere se ti è piaciuto. Mi piace tanto leggere i vostri commenti, è bello ricevere un feedback, soprattutto perché lavoriamo davvero tanto per questo podcast. Quindi se ti va, lascia un commento dove ci fai sapere che genere di musica preferisci e se conosci qualche cantante o canzone italiana. Oltre a commentare l’episodio, puoi anche lasciare una recensione positiva al podcast, una valutazione, sul profilo principale del podcast sull’applicazione che stai usando per ascoltarci, Spotify o Apple podcast. I commenti all’episodio sono super utili ma lo sono anche le recensioni al profilo del podcast. Detto questo, grazie mille per l’ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo! Ciao!
Ciao e benvenuto, o benvenuta, su Podcast Italiano Principiante, un podcast per chi sa un po’ di italiano e vuole fare progressi. Io sono Irene e oggi parliamo di qualcosa che accompagna da sempre la vita quotidiana degli italiani: la musica.
Scarica la versione PDF della trascrizione
Trascrizione interattiva dell'episodio
Immagina una piazza italiana, magari d’estate, con i tavolini all’aperto e tante persone che passeggiano o si riposano. Poi, all’improvviso, un musicista di strada inizia a suonare e ad animare la piazza: in pochi minuti, la gente comincia a battere le mani, a canticchiare, ad alzarsi e ballare.
La musica, in Italia, è un collante sociale. Come una colla, unisce le persone, senza distinzioni di età, provenienza o lavoro. Quando si canta o si ascolta la musica insieme, si diventa parte di un unico gruppo.
Questo perché la musica, in Italia, non è solo un mezzo di intrattenimento, ma anche un modo per condividere un senso di appartenenza. Fin dai tempi più antichi, in Italia, nelle feste di paese, nei campi o nelle piazze, il canto collettivo serviva a rafforzare i legami della comunità. Infatti, uno dei pilastri del rapporto degli italiani con la musica è la tradizione popolare.
Ogni regione ha i suoi canti, le sue melodie, i suoi strumenti tipici. In Sardegna, ad esempio, ci sono i canti a tenore, un canto corale che l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Senti.
In Sicilia, le serenate e le nenie popolari raccontano di amori impossibili, di nostalgia, di vita quotidiana. La nenia è un canto molto nostalgico, lento, lamentoso. Ascolta.
In generale, poi, nel Sud Italia, troviamo la tarantella e la pizzica, balli scatenati che, presumibilmente, nascono come rito di guarigione: si diceva che chi veniva morso dalla tarantola doveva ballare senza sosta per liberarsi dal veleno. Immagina di ballare su queste note.
E nel Nord Italia ci sono tantissimi tipi di canti popolari. Ad esempio i canti alpini, canti corali che raccontano storie, leggende, e la vita di montagna. Ti faccio ascoltare un pezzetto di uno dei più famosi, Quel mazzolin di fiori.
[Quel mazzolin di fiori
Che vien dalla montagna
Quel mazzolin di fiori
Che vien dalla montagna
E bada ben che non si bagna
Che lo voglio regalare
E bada ben che non si bagna
Che lo voglio regalar
Lo voglio regalare]
E un altro esempio è il trallallero genovese, un canto polifonico, cioè con più suoni, con più voci: qui, non si usano strumenti musicali ma solo la voce. Cinque o più persone cantano, imitando gli strumenti musicali. È praticamente un canto a cappella. Ascolta qui.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la musica è diventata anche un atto di resistenza. Un esempio di canzone di resistenza è Bella ciao, canzone che oggi è conosciuta in tutto il mondo. Te ne faccio ascoltare un pezzo.
[Una mattina mi son svegliato,
oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir]
Bella ciao non era solo una canzone, ma un simbolo: raccontava il desiderio di libertà, la speranza di un futuro migliore. Non tutti sanno che l’origine di questa canzone è abbastanza incerta. Molti dicono che nasce da vecchi canti popolari del Nord Italia, come Fior di tomba, piemontese, che ha un testo molto simile. Un altro canto che probabilmente ha influenzato Bella ciao è il canto trentino La me nòna l’è vecchierella (cioè “mia nonna è vecchia, anziana”), un canto per bambini che ripete tante volte la parola “ciao”. È davvero simile. Ascolta.
[La me nòna l'è vecchierèlla
la me fa ciau
la me diś ciau
la me fa ciau ciau ciau
la me manda la funtanèla
a tor l'acqua per deśinar]
Oggi, Bella ciao resta una delle canzoni più cantate nelle piazze italiane, soprattutto durante le manifestazioni e altri eventi pubblici. In questo senso, la canzone collega perfettamente passato e presente, memoria e partecipazione collettiva. Se c’è un luogo che rappresenta il cuore musicale italiano, infatti, è la piazza. E non parliamo solo di resistenza e politica. In Italia le piazze sono anche luoghi di incontro e di festa, e la musica è sempre protagonista. Pensiamo ai concerti gratuiti del Primo Maggio a Roma, con migliaia di giovani riuniti, oppure ai festival estivi nei piccoli borghi, dove si canta e si balla fino a notte fonda. La piazza è uno spazio aperto, pubblico e democratico: lì la musica è davvero di tutti.
Spesso basta una chitarra e tutti sono pronti a cantare. Specialmente le canzoni d’autore, cioè scritte da cantautori come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Francesco De Gregori, e Lucio Dalla, artisti che hanno usato le canzoni non solo per parlare d’amore, ma anche per raccontare la società, i cambiamenti, e i problemi politici. La canzone in Italia non è solo intrattenimento: è poesia popolare, un modo per riflettere sulla vita e sui problemi della società. Ascoltiamo un pezzetto de La Guerra di Piero di De André, una canzone che denuncia le atrocità della guerra. L'ispirazione per questa canzone è lo zio del cantautore, un sopravvissuto al campo di concentramento durante la Seconda guerra mondiale.
[E mentre marciavi con l'anima in spalle,
vedesti un uomo in fondo alla valle,
che aveva il tuo stesso identico umore,
ma la divisa di un altro colore.
Sparagli Piero, sparagli ora!
E dopo un colpo sparagli ancora,
fino a che tu non lo vedrai esangue,
cadere in terra a coprire il suo sangue]
Un altro esempio di come la musica italiana racconti la vita delle persone è Amara terra mia di Domenico Modugno. Il brano parla della fatica, della nostalgia e dell’emigrazione, temi molto presenti nel Sud Italia del Novecento. Modugno canta la tristezza di chi lascia la propria terra alla ricerca di lavoro o di una vita migliore, quindi di un’emigrazione, spesso, forzata. Curiosamente, Amara terra mia è considerata una rielaborazione di una canzone tradizionale abruzzese, nata nei primi anni del 1900 come canto di lavoro delle raccoglitrici di olive nella zona della Maiella. Così, anche Modugno, come tanti cantautori italiani, prende ispirazione dalla tradizione popolare e la trasforma in un brano moderno che parla al cuore di tutti. Ascolta. È straziante.
[Sole alla valle, sole alla collina
Per le campagne non c'è più nessuno
Addio, addio amore, io vado via
Amara terra mia, amara e bella…]
Un aspetto molto forte della musica italiana, dunque, è quello della denuncia. Non solo della guerra, dell'emigrazione, ma anche della mafia e della criminalità organizzata. Sono molti i gruppi e i cantautori che hanno usato la musica come arma di resistenza. Ti faccio ascoltare una delle canzoni più belle, secondo me: I Cento Passi.
[Allora dimmi se tu sai contare!
Dimmi se sai anche camminare!
Contare, camminare insieme a cantare!
La storia di Peppino e degli amici siciliani, allora…
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento passi…]
Questa canzone racconta la storia di Peppino Impastato, un giovane siciliano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Il titolo, I cento passi, si riferisce alla distanza tra la casa di Peppino e quella del boss mafioso locale, e simboleggia il coraggio di chi si oppone alla criminalità anche quando è, proprio fisicamente, molto vicina. Questa canzone, che racconta la storia di Peppino, è diventata un inno antimafia, un inno di resistenza e impegno civile.
Comunque, passiamo dalla mafia all’amore, perché la musica italiana è davvero variegata e i temi da trattare sono tanti. Ovviamente anche in Italia ci sono tantissime canzoni d’amore, alcune più famose di altre. Adesso non voglio concentrarmi sulle canzoni d’amore, ma su una tradizione molto interessante, che è la serenata. La serenata è una tradizione antica, soprattutto nei piccoli paesi del Sud Italia. Oggi questa tradizione è un po’ scomparsa, ma non del tutto. Si tratta di un momento romantico e pubblico allo stesso tempo: un ragazzo innamorato va, di notte, sotto casa della ragazza che ama, che vuole sposare. Porta con sé dei musicisti e inizia a cantare canzoni d’amore, magari la loro canzone d’amore, per dichiararsi all’amata e magari chiederle di sposarlo. È un gesto simbolico fortissimo: a quel punto tutta la comunità, tutto il quartiere sa che quel ragazzo vuole sposarsi con lei. La serenata non è solo un atto romantico, ma anche un rito sociale, un modo per celebrare pubblicamente i sentimenti. Ancora oggi, in alcuni paesi del Sud, si organizzano serenate moderne, così che la musica diventa un ponte tra l’amore privato e la comunità. Io spero che a me non accada mai. Penso che sarebbe molto imbarazzante! Tu che ne pensi?
Comunque, parlando d’amore: ormai sai che uno dei più grandi amori degli italiani, soprattutto degli uomini, è il calcio. Infatti, un altro luogo dove la musica diventa protagonista è lo stadio. Se sei stato, o stata, a una partita di calcio in Italia, lo sai: i cori dei tifosi non sono semplici urla, sono vere e proprie canzoni. Ogni squadra ha i suoi cori, alcuni storici, altri più recenti. Ci sono quelli allegri, per festeggiare un gol, e quelli ironici, per prendere in giro gli avversari. Molti di questi cori derivano da canzoni pop italiane o internazionali. Spesso i tifosi prendono una melodia già conosciuta e ne cambiano le parole: ad esempio, il famoso coro Po po po po po po po è basato sulla melodia di una canzone rock abbastanza famosa. Ti faccio sentire il coro. Ed ecco l’originale.
Il bello è che, allo stadio, non importa se sei stonato o se non conosci bene il testo di un coro: canti insieme agli altri, e ti senti parte di qualcosa di più grande. È un po’ come nei canti popolari: la musica serve per creare comunità, per rafforzare il senso di appartenenza. Io sono romana e romanista, cioè tifo la Roma, che è la squadra della mia città. Quindi ti faccio ascoltare uno dei cori della Roma.
[Roma, Roma mia,
nun te fa incantà!
Tu sei nata grande…
E grande hai da restà!
Roma, Roma, Roma…
core de 'sta città,
unico grande amore…]
Lo stadio, per l’italiano medio, è una seconda casa. E questo può essere anche molto tenero, se pensiamo che spesso i ragazzi vanno allo stadio con il papà, con lo zio, o con il nonno. Sicuramente il calcio riesce ad unire le diverse generazioni. Ma non solo il calcio. Anche la musica collega le generazioni. Anche se magari i nonni italiani cantano le canzoni popolari, i genitori le canzoni degli anni ’70 e ’80, i giovani le canzoni moderne, capita spesso che, durante una festa, una playlist riproduca una vecchia canzone napoletana e subito dopo un brano moderno, e tutti si ritrovano comunque a cantare insieme. Soprattutto se si parla di canzoni particolarmente famose, iconiche, che magari hanno vinto il festival di Sanremo negli anni.
Ecco, il Festival di Sanremo è un evento che unisce tutti, che ogni anno ferma il Paese: immagina famiglie intere davanti alla TV, amici che discutono su chi vincerà, polemiche infinite sulle canzoni. Sanremo non è solo un concorso: è un rito collettivo della cultura e della società italiana. Spesso, chi vince Sanremo rimane famoso solo in Italia, raramente riesce a sfondare all’estero. Ci sono però delle eccezioni: un esempio recente sono i Måneskin, che hanno vinto Sanremo e poi hanno avuto un grande successo in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti. Ti faccio ascoltare la canzone con cui hanno vinto Sanremo nel 2021, Zitti e buoni.
[Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro…]
Comunque, prima di salutarti, non posso non parlare dell’Opera lirica. È uno dei grandi tesori culturali d’Italia, conosciuto e amato in tutto il mondo. E poi l’Opera è anche un simbolo della forza della lingua italiana. Le sue melodie e i suoi testi hanno fatto conoscere l’italiano in tutto il mondo, quando il Belpaese non era ancora famoso per la moda o la cucina. Pensa che l’Opera italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO nel 2023.
Nell’Opera, gli italiani hanno avuto ruoli fondamentali come librettisti, come compositori e come cantanti lirici. Giusto per fare qualche nome: tra i compositori, possiamo menzionare Rossini, autore de Il barbiere di Siviglia, o Giuseppe Verdi, celebre per La Traviata, Aida e Rigoletto; e poi, Giacomo Puccini, famoso per La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Dei cantanti lirici, basta fare un nome: l’unico e inimitabile Luciano Pavarotti, un tenore emiliano noto per la sua voce potentissima. Te lo faccio ascoltare qui in Nessun Dorma, canzone iconica dell’opera Turandot, l'ultima opera di Giacomo Puccini, nonché l'ultima grande opera romantica della storia.
[Dilegua, o notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!
Vincerò… vincerò!
Vincerò!]
L’episodio di oggi finisce qui. È stato un episodio un po’ diverso, quindi fammi sapere se ti è piaciuto. Mi piace tanto leggere i vostri commenti, è bello ricevere un feedback, soprattutto perché lavoriamo davvero tanto per questo podcast. Quindi se ti va, lascia un commento dove ci fai sapere che genere di musica preferisci e se conosci qualche cantante o canzone italiana. Oltre a commentare l’episodio, puoi anche lasciare una recensione positiva al podcast, una valutazione, sul profilo principale del podcast sull’applicazione che stai usando per ascoltarci, Spotify o Apple podcast. I commenti all’episodio sono super utili ma lo sono anche le recensioni al profilo del podcast. Detto questo, grazie mille per l’ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo! Ciao!






































.jpg)



.jpg)




.png)







.png)
























.png)




%20(1).png)

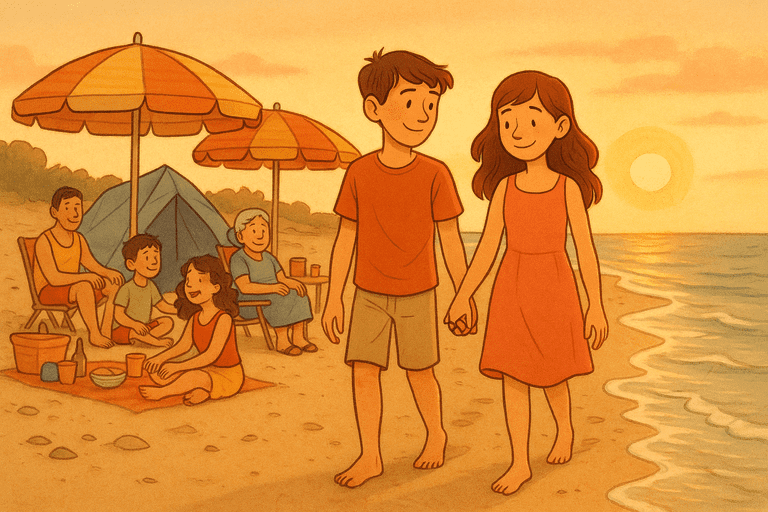

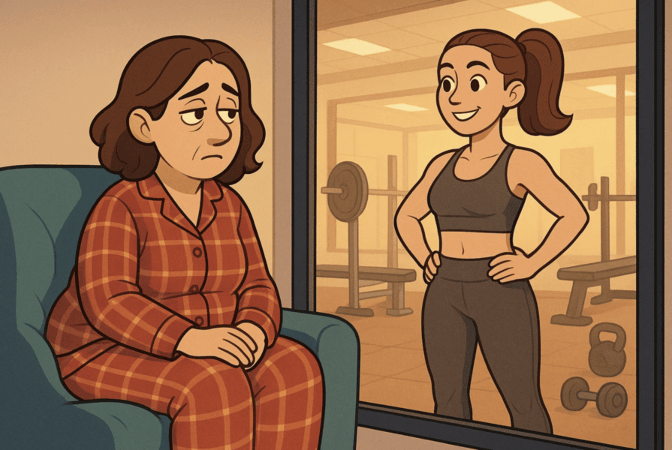

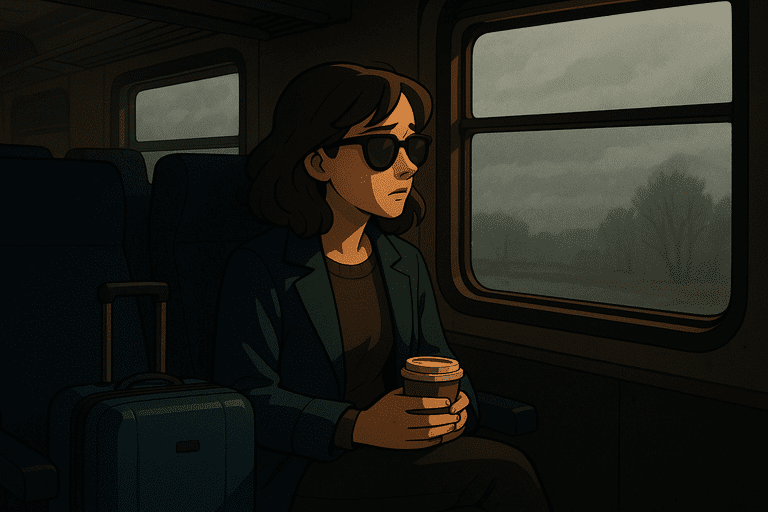

.png)
.jpg)



.png)






0 Commenti